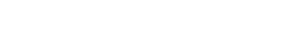La frammentazione della scena in una serie di microscene che si susseguono senza un legame narrativamente logico sembra suggerire – di più, rispecchiare – la frantumazione in una miriade di monadi in cui si frastaglia l’oggi, con un mondo del lavoro il cui accesso è un imbuto strozzato che ha fra le sue conseguenze quella di riaprire e ricalibrare un conflitto generazionale in cui i vecchi rappresentano la conservazione e sono il tappo alla crescita dei giovani, un conflitto che rovescia l’Edipo, per cui sono i genitori ad ammazzare metaforicamente i figli.
Le scene che si susseguono e che prevedono l’interazione col pubblico sono regolate una scansione cronologica a vista, segnata ora per ora, nesso temporale lineare lungo il quale si dipana la sconnessa schizofrenia di microstorie fatte di colloqui lavorativi e pseudolavorativi (come quello per entrare nella mafia), che terminano con l’immancabile “le faremo sapere”, o di accudimento forzoso di un’anziana madre in forma di scheletro su di una sedia a rotelle, rimpinzata a forza e compulsivamente, o ancora di cartonati di vecchi (Hugh Hefner, la Regina Elisabetta, Sophia Loren) a cui il pubblico è invitato a tirar pallate. È un modo cinicamente comico, urticante, di raccontare la contemporaneità, il consesso sociale che la abita e le conflittualità larvate e latenti che lo corrodono.
Ma è il “demone” che pervade ciascuno di noi, quel daimon che ci instilla desideri e ambizioni per lo più destinate a rimanere irrealizzate, il vero oggetto della ricerca dei Sotterraneo; un oggetto che nella messinscena non prende una sembianza dai contorni fisicamente definiti, ma si intrufola nelle coscienze degli spettatori sotto forma di evidenza implicita, permeando azioni e situazioni crudeli e spietate; il (dis)valore generico sotteso alle dinamiche socio-economiche del nostro mondo soffoca quell’istinto che ci fa ambire a voler fare l’artista, o che da bambini ci fa cullare il sogno di fare l’astronauta, facendoci giungere alla considerazione dell’amara evidenza della necessità di soccombere pur di sopravvivere, di acquisire la frustrazione come pratica di acquiescenza. “Distruggete il vostro daimon”, ci suggeriscono i Sotterraneo e ci forniscono anche un decalogo su come farlo, suddiviso per fasce d’età, campionario di vari metodi per abortire se stessi.
Avviene ciò con la leggerezza del gioco.
È infatti un gioco quello dei Sotterraneo; è un gioco perché parla il linguaggio surreale di un’ironia sferzante, che scarnifica in rivoli di senso espressivo la propria visione per ricondurla carsicamente ad un filo unitario; è un gioco perché le situazioni che vengono ricreate hanno un’evidenza tanto grottesca da suscitare il riso, l’ilarità; è un gioco perché fa sapiente uso dei meccanismi della teatralità (e della metateatralità) per raccontare una condizione generale – quella della società – ed una particolare – quella del teatro − in cui le medesime dinamiche di asfissia professionale si riproducono; ed è un consapevole gioco nel gioco, che dopo aver fatto in abbrivio suggerire ai due attori da una voce in segreteria che si qualifica come William Shakespeare di cambiare lavoro, nella seconda fase dello spettacolo vedrà chiamata in scena un’attrice locale – nella fattispecie Simona Fredella – che racconterà della propria precarietà e contribuirà a dar vita ad una ulteriore truce lotta per la sopravvivenza che si concluderà con tanto di roulette russa.
Ed è un gioco, questo gioco consapevole e metateatrale, che nell’avvicinarsi al suo epilogo – finale dichiarato e preannunciato – gioca ancora e ulteriormente, come nel dialogo fra i due interpreti in scena in merito ad un figlio che non c’è, che richiama alla memoria il gioco perverso imbastito dai due protagonisti di Chi ha paura di Virginia Woolf? e che troverà il proprio crudele simulacro in una piccola bara bianca portata in scena.
In questa dispersione frammentata di immagini e spunti Sara Bonaventura e Claudio Cirri delineano un’idea che si definisce con evidenza grottesca e caustica spietatezza; il fatto di riderne – e di farlo con gusto – all’apparenza rinfranca, ma nel bilancino etico sul quale si soppesa ciò che ci si porta a casa da uno spettacolo come Be Normal! è l’amarezza – gradevole per come è stata esposta, ma feroce nel suo portato profondo – a costituire il gusto predominante con cui ascoltare, citando i più volte ripresi Simon & Garfunkel (che insieme al Brian Eno di By This River e al Lou Reed di Perfect Day costituiscono la colonna sonora dello spettacolo), i suoni del silenzio in cui vagola questa società, serenamente in marcia verso la propria consunzione».
DICONO DI NOI
GENERALE
«Teatro Sotterraneo fa parte a pieno titolo del nuovo teatro italiano […]. Di cosa è fatto il linguaggio del Teatro Sotterraneo? Non di emozioni, sistematicamente negate sul nascere, non di immagini, sacrificate a uno stile spietatamente spoglio, non di storie dotate di senso compiuto, la cui rappresentazione non viene neppure presa in considerazione: in effetti questo gruppo, fra i più emblematici dell’ultima generazione, punta quasi esclusivamente sulla pura energia psico-fisica, sull’esemplare rigore compositivo e su una comunicazione allusiva, ironicamente trasversale. Alla base c’è una personalità davvero molto forte: ci vuole una grande sicurezza di sé per rinunciare praticamente a tutto, sapendo che comunque l’attenzione dello spettatore non cadrà neanche per un attimo».
Renato Palazzi, www.delteatro.it
«Quando invece il problema è la messa in discussione della stessa rappresentazione, questa avviene solitamente attraverso l’utilizzo di un procedimento: una feroce ironia. Ogni oggetto, ogni gesto, ogni azione perde di senso o, almeno, il senso slitta continuamente. Non pochi gruppi iniziano dichiarando di non avere nulla da dire, iniziano confrontandosi con un’idea di fine declinata poi su sentimenti e identità e, soprattutto, sul teatro stesso. […] Quello che importa è il procedimento di montaggio e smontaggio della scena che viene portato avanti ad esempio da Teatro Sotterraneo (Firenze) […]. Sono percorsi questi che intraprendono una strada estremamente difficile perché fin da subito si posizionano su un limite: una disperazione ai limiti del tic e della nevrosi, un’ironia che può cedere al cinismo, un gioco che quando perde di carica utopica si fa scherzo. In questo caso la rappresentazione è negata ma è l’oggetto con cui fare i conti, e il coraggio risiede proprio nello sporcarsi le mani con le cose del mondo, nel provare a ritrovare un’intelligente comunicatività con il pubblico, anche utilizzando un immaginario quotidiano certo da criticare, ma non da rimuovere».
Rodolfo Sacchettini, Lo Straniero
«Una rabbia nascosta, mimetizzata, capace però di segnare la pelle come una carezza che si trasforma attraversa gli spettacoli di Teatro Sotterraneo […]. Le loro creazioni […] sono schiaffi alla mediocrità dei tempi, di cui siamo tutti complici. Il ritmo sempre precisissimo si scioglie in una fruibilità altissima: sono questi i due fattori principali attraverso cui Teatro Sotterraneo restituisce il proprio sguardo sul quotidiano. Uno sguardo che, non prendendosi sul serio, obbliga il pubblico a fare il contrario. […] L’ironia deflagrante messa in atto dal Teatro Sotterraneo può essere letta come comicità pura. Cioè come quella comicità che è violenta perché ci restituisce la violenza del mondo […]. Così si ride moltissimo, oscillando tra un parlato corrosivo capace di frustrare tutte le aspettative e momenti di puro teatro fisico, ma tra gag e brandelli di scenette si fa strada un retrogusto amaro, e il ridere si fa storto e livido, e fa male. A pochi minuti dall’ingresso in teatro il disvelamento è ormai completo: si ride, ma ridendo ci si scopre e ci si riconosce. La bruttura del quotidiano […] sale alla superficie e inchioda lo spettatore alla realtà».
Lucia Oliva, Teatri del tempo presente
«Sono il gruppo del momento, inutile negarlo. […] Teatro Sotterraneo prosegue un’opera di decostruzione avviata diverse generazioni fa, dagli anni ’70 del secolo scorso, ma lo fa – ed è questa la sostanziale novità della generazione di cui la formazione fiorentina guida le fila – coniugando complessità e accessibilità fuori da facili contrapposizioni, ben sapendo che l’elemento aggregante, quello che può trasformare i singoli spettatori in una seppur temporanea comunità, è la (cattiva) coscienza della tacita connivenza con un sistema che antepone denaro e successo a qualunque altro valore. […] Teatro Sotterraneo ci restituisce una scena che non smette di interrogare il presente con caustica leggerezza, insinuanosi in formati pop per innescarvi linee di fuga che ne alterano le polarità e aprendo così il campo a inedite, rivelatorie combinazioni».
Andrea Nanni, Hystrio
«I Sotterraneo hanno dimostrato di essere ancora una volta uno dei collettivi ai quali il termine emergenti sta davvero troppo stretto. Arguti, fini, cerebrali, intellettuali ma allo stesso tempo intuitivi. Donano flash di emozione e lampi d’attualità ed è un piacere ogni volta osservarli nelle loro vere e proprie performances. Molto fisici, sudati, anche schifosi ma terribilmente terreni e veri. Il futuro è loro».
Tommaso Chimenti, Il Corriere di Firenze
«Teatro Sotterraneo. Un vero collettivo, senza gerarchie. Nasce a Firenze e contamina diverse tecniche comunicative. Nessuna narrazione classica. Molte risate. […] Nel corso degli ultimi anni, si è distinto nei diversi epicentri del teatro di ricerca per l’originalità delle produzioni e per un percorso di ricerca di statuto autonomo con un metodo di assenza di regia, a evidenziare la mancanza di gerarchie […]. Il collettivo fa parte, insieme ad altri giovani gruppi, di Fies Factory One, progetto di promozione di nuove realtà del tetrodi ricerca nate intorno al nucleo del Festival di Dro. Correte a vederli e divertitevi».
Carlo Orsini, Rolling Stone
«Intanto la formazione: non gerarchica, in orizzontale – quattro performer più uno, il dramaturg – da collettivo di ricerca anni Settanta ripitturato di fresco. […] Sono smaliziati questi “Sotterranei”, che si muovono come fumetti ma si portano dietro tutto il disincanto degli adulti. […] Tremate spettatori, una risata lugubre vi sotterraneerà».
Rossella Battisti, L’Unità
«Non c’è regista, si fa tanto laboratorio, e un dramaturg offre la partitura verbale, una serie “ponti di parole”, che permettono, quando necessario, di saldare i vari momenti di uno stile di rappresentazione eminentemente visivo tutto fondato sull’azione fisica, sul gesto, la postura, il segno. Interessante: costringe lo spettatore a diminuire lo stato di veglia, anzi di allarme razionale, per affidarsi alla coscienza intuitiva».
Marcantonio Lucidi, LEFT
«Quello che Teatro Sotterraneo ci restituisce non è altro che lo scheletro di una realtà più ampia e supplementare, una situazione costruita per essere “acchiappata al volo” dal fruitore: ci espone una nuova significazione dei gesti, delle esperienze, della parola, una nuova profonda ristrutturazione di quello che ci circonda e ci ingloba».
Massimiliano Schiavoni, Performativi
«Teatro Sotterraneo, compagnia fiorentina nata nel 2005, da sempre lavora riferendosi a un immaginario contemporaneo e di massa, con la rara capacità di creare processi di ironico straniamento e di mostrare e disinnescare il potere di manipolazione dei mezzi di comunicazione e dei consumi culturali più diffusi. Non ci sono però concessioni ai meccanismi della denuncia o dell’indignazione, al contrario lo stile di Teatro Sotterraneo procede per micro-svelamenti e micro-conflittualità, aperture di senso improvvise, feroce irriverenza e rara leggerezza. I riferimenti spaziano dalla letteratura al cinema, dalla graphic novel ai videogiochi e in particolare al linguaggio delle serie tv. Come altre compagnie della medesima generazione Teatro Sotterraneo si riferisce a un immaginario preciso: l’immaginario di chi è nato all’inizio degli anni Ottanta, appartenente alla piccola e media borghesia della provincia italiana. Vale a dire la prima generazione che è cresciuta con i cartoni animati giapponesi e con videogame di massa, che ha passato l’adolescenza seguendo cento serie tv. Tra le compagnie citate questa è naturalmente la più imbevuta di televisione e la più sensibile anche alle possibilità narrative del web. Sotterraneo è tra le prime realtà in Italia che si è interrogata in modo originale sulle modalità interattive che si possono applicare al teatro. In particolare in ogni suo lavoro si è provato a coinvolgere lo spettatore tramite i “trucchi” della società dello spettacolo. Dai giochi a premi, alle telefonate, dagli sms da spedire in diretta ai selfie di gruppo, Teatro Sotterraneo ha tematizzato la diffusione di una nuova interazione tecnologica di massa, applicandola allo spettatore di teatro, con grande ironia e causticità. In particolare il serbatoio ludico mediale viene inserito in una riflessione critica sulle derive manipolatorie dei mezzi di comunicazione di massa, in special modo per quanto riguarda l’induzione delle emozioni (Lanteri, 2009). La serialità subisce un processo analogo di assimilazione. Anch’essa viene tematizzata dal momento che Sotterraneo le associa un immaginario preciso, determinato principalmente da serie tv americane, di larga diffusione.
Ma la serialità penetra anche dentro il linguaggio scenico, costituendone quasi una piccola regola interna. Costruiti da un ritmo frenetico di scene, gli spettacoli di Sotterraneo hanno continui rimandi interni e una sorta di consequenzialità da sit-com. Estremizzando si può dire che la serialità per Teatro Sotterraneo è addirittura un modo di leggere la realtà in maniera orizzontale, di collegare e connettere oggetti e temi tra loro diversissimi. Più nello specifico per Teatro Sotterraneo il modello della sit-com è fondamentale, seppure utilizzato nel suo ribaltamento. Gli spettacoli procedono per microscene e secondo ritmi ben definiti, con esiti fortemente ironici. A questo proposito è emblematico Be Normal!, uno degli ultimi lavori, che racconta una giornata impossibile di una coppia di trentenni. Il passare delle ore è scandito dal succedersi di scene tipiche della quotidianità di un giovane disoccupato, alle prese con nuove forme di peripezie e di avventure, per garantirsi la sopravvivenza. La concentrazione, il ritmo accelerato, l’estremizzazione di molti accadimenti rendono lo spettacolo un succedersi di episodi impossibili e incredibili che paiono ribaltare una delle regole delle canoniche sit-com, cioè “essere all’altezza dell’ideale sociale del benessere” (Monico, F. 2006). Al contrario negli spettacoli di Teatro Sotterraneo si rappresenta costantemente l’essere inadeguati e incapaci rispetto a un ideale sociale di benessere, che però si manifesta adesso non come raggiungimento di un equilibrio, ma come l’adattarsi a regole assurde. È la nevrosi, in un certo senso, il motore della ribellione, lo sforzo che si compie per non cedere completamente alle regole imposte. A differenza delle sit-com l’effetto comico si produce nel fallimento di azioni assai serie, con la percezione dunque di un’ombra – ma solo di un’ombra – di tragedia, che non esplode mai, perché non può esplodere: è come se anch’essa fosse drammaticamente sabotata. Al centro persiste lo svilupparsi di situazioni vissute non da personaggi, ma da performer, che fingono esplicitamente di rappresentare personaggi, che vivono solitamente per poche scene, per poi dissolversi o per meglio dire crollare a terra, come abiti senza più corpo. Nella “scrittura scenica” (Bartolucci, 1968) di Teatro Sotterraneo non c’è mai una vera e propria sospensione della narrazione, nemmeno nei progetti esplicitamente seriali come Be Lengend!, perché la narrazione è solitamente assorbita dalla rappresentazione, composta da un complesso di circostanze e di situazioni, e non precisamente da una consequenzialità verbale. La sospensione e l’interruzione sono però strategie essenziali e ripetute nello stile di Sotterraneo. Si interrompono le azioni, le situazioni e soprattutto i processi di riconoscimento, innescati nella mente degli spettatori che si rispecchiano in un primo momento su elementi noti, per poi rimanere sorpresi da deviazioni improvvise e inaspettate. L’ironia dissacrante lavora proprio a sabotare i meccanismi di riconoscibilità, tramite l’interruzione anche delle emozioni e dei sentimenti, il più delle volte innescando meccanismi di ‘opacità’, ovvero di messa in mostra dell’artificio del teatro. Nell’ultimo progetto si sperimenta la sospensione della narrazione e la serialità, a partire da un classico romanzo di avventura, a suo tempo pubblicato a puntate, Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne (uscì su «Le Temps» dal 6 novembre al 22 dicembre 1873).
Lo spettacolo si presenta come reading, con musica dal vivo, ed è suddiviso in quattro puntate. Ogni puntata racconta un pezzo di viaggio, con l’attraversamento di uno o due continenti e viene realizzata in luoghi diversi della città. A Pistoia, ente coproduttore, il gruppo è partito dalla villa settecentesca che ospita la Scuola di musica e danza Mabellini, passando poi per la Biblioteca Comunale, il Teatro Bolognini e infine a Palazzo Fabroni, il museo di arte contemporanea della città. Ogni puntata viene replicata per una settimana ed è immersa in un clima musicale differente che viene realizzato dal vivo dalle realtà musicali presenti sul territorio In questo caso la serialità dell’operazione viene rinforzata con un effettivo spostamento di luogo, che è anche una sua trasfigurazione e riscoperta, e con un cambiamento di atmosfere, che è soprattutto di ordine musicale. Il gioco teatrale in questo caso consiste anche nello slittamento delle dimensioni, dal giro del mondo in ottanta giorni al giro della città in ottanta minuti. La serialità diventa in questo caso un modo ludico di esplorazione di luoghi, ben caratterizzati nella mappa cittadina e con specifiche funzioni, per imparare a ‘leggere la città’ come fossero paesi da esplorare, e allo stesso tempo per lasciarsi stupire dalla musica stessa che la città è in grado di produrre, con cambiamenti stilistici arditi e inusuali».
Rodolfo Sacchettini, annalidibotanica.uniroma1.it
IL FUOCO ERA LA CURA
Il testo di Ray Bradbury, che ha celebrato nel 2023 i settant’anni dalla prima pubblicazione, ha fornito al gruppo composto da Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa un solido impianto narrativo, restituitoci in scena da cinque giovani attori, quasi tutti alla prima collaborazione con Sotterraneo. Flavia Comi, Davide Fasano, Fabio Mascagni, Radu Murarasu, Cristiana Tramparulo fanno il loro ingresso ciascuno stringendo in mano un libro, sussurrandone le frasi nell’inane sforzo di impararlo a memoria, e introducendo attraverso rapidi accenni le caratteristiche del personaggio che interpreteranno. È una dichiarazione che il pubblico più attento al percorso di Sotterraneo accoglie quasi con stupore: da sempre associato alle declinazioni più raffinate del post-drammatico nazionale, il collettivo approda adesso a caratterizzazioni e torsioni psicologiche, a una fabula, finanche a una scrittura tratta da un libro celebre, del quale ripercorrere gli snodi fondamentali. Ma il “metodo Sotterraneo” – di cui Il fuoco era la cura rappresenta soprattutto un tentativo di trasmissione a una nuova generazione di performer – agisce anche se applicato a un romanzo, e la scrittura di Daniele Villa frappone alla linearità del racconto altre tracce drammaturgiche e registiche. Accanto ai momenti salienti della vicenda – l’ordinaria, feroce attività incendiaria dei pompieri; l’improvvisa presa di coscienza del protagonista, Montag; l’incontro con i book people – si susseguono ora alcune scene volte a ripercorrere una storia universale del libro, e con essa della stessa cultura umana, ora un surreale mockumentary che, sotto forma di incontro con il pubblico di un teatro, racconta la quotidiana vita di una compagnia in un prossimo 2051. I fili del tessuto testuale si sovrappongono e si meticciano, trasformando le immagini di Fahrenheit 451 in interrogativi filosofici e affondi antropologici – agiti attraverso quei riconoscibili tableaux vivants che contraddistinguono l’arte scenica del gruppo – e nelle confessioni di un gruppo di attori, riunitisi in un futuro non così improbabile. Come in un romanzo, i capitoli indicati dalle didascalie proiettate sui due schermi delimitano gli ambiti cronologici di un’opera che spazia attraverso le ere e le epoche, condensandole nell’immediatezza di un fatto – il teatro – perennemente antico: ancestrale come i racconti di un tempo, pronunciati nel buio rischiarato da un fuoco, e ormai dimenticato come una vecchia moda, un vizio da perdere, una cattiva abitudine fortunatamente sconfitta.
Qui, nella velocità con cui le sezioni della drammaturgia si succedono, agisce con più efficacia la corrosiva ironia di Sotterraneo: che vorrebbero poter tradurre l’esplosiva scrittura di Bradbury, la pirotecnica descrizione della città e dei roghi, in apparati scenografici sontuosi e cinematografici, ma che – considerato il budget a disposizione – si limitano a descrivere le auto sportive che avrebbero dovuto fendere le quinte, o l’interno di quella metropolitana che avrebbero voluto riprodotta sul palco con assoluta, iperrealistica fedeltà. Che il bersaglio principale della satira di Il fuoco era la cura sia la costante minaccia sotto la quale vivacchia il teatro, lo rivelano d’altronde i cinque interpreti nel loro surreale rivolgersi al pubblico, quando rammentano le rapide tappe che, a partire da quel 2024 in cui stavano lavorando insieme a uno spettacolo tratto dal capolavoro di Bradbury, ha portato all’estinzione di quella forma d’arte così desueta, così nostalgica. Mentre Montag passa dall’iniziale, cieca adesione alla propria missione incendiaria, a quella feroce e omicida ribellione che sembra nascondere, in nuce, il germe di un futuro differente, la fantasia distopica de Il fuoco era la cura associa invece un percorso inverso, al termine del quale nessuna salvezza è concessa alle donne e agli uomini di teatro, e con loro a una società sempre più rabbiosa e violenta, lacerata da insanabili pulsioni giustizialiste.
I roghi dei libri, ci ricordano le didascalie sugli schermi, hanno costellato la storia umana sin dai suoi albori: Alessandria d’Egitto, i Bücherverbrennungen nazisti, la distruzione del patrimonio culturale Maya, o ancora le “cupe vampe” che avvolsero, nelle parole di Giovanni Lindo Ferretti, la Biblioteca Nazionale di Sarajevo, fino ai grotteschi – ma altrettanto pericolosi – roghi di libri a tematica LGBTQIA+ che periodicamente gli esponenti dei gruppi alt-right organizzano negli Stati Uniti. E altri roghi, profetizzano i Sotterraneo, colpiranno il Corano, dato alle fiamme nelle nostre capitali occidentali, o la Biblioteca del Consiglio Europeo: ma al fuoco saranno presto affiancate nuove forme di distruzione, di censura, di damnatio memoriae. Il fuoco era la cura affronta, con sorniona eleganza, anche i temi della cancel culture e della “nube tossica mediatica” nella quale siamo costantemente immersi: la messe di informazioni contrastanti che bombardano l’uomo e la donna del ventunesimo secolo – e di cui Overload tratteggiava le conseguenze sulla soglia d’attenzione individuale – determina oggi una brutale guerra per la verità, o piuttosto per il più efficace storytelling. A farne le spese sono soprattutto gli spazi di discussione e confronto, le zone intermedie e grigie di un pensiero che non sia monolitico, le scrittrici e gli scrittori non allineati. Sul finire degli anni Venti del terzo millennio – ricordano gli attori in quel 2051 in cui incontrano il pubblico – le fatwe lanciate in rete contro autori considerati pericolosi si stavano sempre più diffondendo, finché a farne le spese fu J. K. Rowling, la creatrice di Harry Potter, assassinata dalla destra ultracattolica o forse dalla sinistra transfemminista. Il futuro è già adesso, sussurrano i Sotterraneo: è tra noi che assistiamo imponenti al crescente odio verso gli intellettuali, tra noi che non sappiamo (o forse non vogliamo) difendere l’autonomia dell’artista o della sua opera, tra noi che forse avremmo bisogno solo di un po’ di silenzio. La scritta silence, luminosa e pop, emerge così dalla semioscurità del palco, sorretta con cura e rispetto, dal gruppo degli attori: quasi un invito – non sapremo mai con quanta convinzione formulato – a pretendere un tempo di raccoglimento e ascolto che possa separarci dal rumore assordante che ci circonda, e al contempo un monito e una minaccia. È il silenzio delle voci di opposizione, di qualsiasi opposizione, che i roghi dei libri hanno cercato di ottenere, e a volte ottenuto.
Di insanabili contraddizioni, d’altra parte, si nutre Il fuoco era la cura: la creazione di Sotterraneo rifugge da qualsiasi manicheismo, dall’algida sicumera con la quale molto attivismo odierno, nel propugnare sacrosante battaglie, corre il rischio – sembra suggerire il collettivo – di assomigliare tanto, troppo, alla propria antitesi. Le didascalie ci ricordano quanto Hemingway fosse maschilista e guerrafondaio, ma lasciano altresì deflagrare la sua vertiginosa capacità di condensare, in sei parole, un’intera, drammatica storia – “In vendita: scarpette neonato, mai usate” – affidando a noi spettatori (e non è forse questo il privilegio più grande?) la responsabilità di decidere verso quale narrazione propendere. La verità è una merce rara anche in Fahrenheit 451, se scegliamo di credere all’aneddoto per il quale la temperatura alla quale brucerebbe la carta sarebbe stata indicata a Bradbury, a caso, da un centralinista della più vicina stazione dei pompieri: in fondo, perché mai dovremmo deturpare la bellezza con la verità? Ma non farlo, non ci lascerebbe piuttosto in preda al pensiero magico e alla superstizione?
Schizofrenica, la realtà delineata da Il fuoco era la cura appare ciò nonostante prossima a una distruzione ben più radicale di quello che potrebbe sembrare un mero cambio di paradigma: mentre discettiamo di “polarizzazioni, tribalismi, teorie del complotto, politiche identitarie, trigger warnings” – e l’elenco di questi feticci culturali sembra interminabile – è la catastrofe ecologica a incendiare il mondo. In una delle sequenze più riuscite dello spettacolo, il rogo della casa di una lettrice, arsa viva da Montag e dai pompieri insieme alla sua biblioteca, si propaga fino alla foresta: le voci dei cinque interpreti si rincorrono nella straziante descrizione di koala in fiamme, di uccelli infuocati che si librano nell’aria insieme alle pagine dei libri, di alberi che cedono al calore schiantandosi al suolo. Posti di fronte alla fine dei tempi, e della civiltà per come l’abbiamo conosciuta, possiamo forse respirare un ultimo alito di bellezza: leggere Proust, contemplare un dipinto di Matisse, ascoltare insieme la voce di Damon Albarn. O piuttosto, come ci insegna il circo, fare entrare i pagliacci: un istante dopo che il trapezista, e la sua utopia di sopravvivenza, si sono schiantati al suolo.
Alessandro Iachino, Doppiozero
La distopia è diventato uno dei generi più frequentati del nostro presente carico di angoscia per il futuro. Non solo nuove narraziono, ma anche ritorno ai classici, tra i quali “Fahrenheit 451″ occupa sicuramente un posto d’onore. Eppure la storicizzazione delle distopie – sembra suggerirci la compagnia fiorentina – rischia di affievolire il rapporto inquieto che un libro come questo intratteneva con il proprio tempo. Ci si concentra (com’è giusto che sia) sul cortocircuto con la storia – i roghi di libri nazisti erano avvenuti solo vent’anni prima, e ancora meno tempo separava il romanzo da quella sorta di book-people ante litteram che mandavano a memoria i versi di poeti divorati dallo stalinismo come Mandel’štam – ma si finisce per stemperare il discorso carsico che scorre sotto l’immagine letteraria degli incendi di parole.
Così i cinque attori in scena – Flavia Comi, Davide Fasano, Fabio Mascagni, Radu Murarasu, Cristiana Tramparulo, tutti davvero molto bravi – da una parte ripercorrono la storia immaginata da Bradbury (e trasposta da Truffaut), interpolandola con inserti divertenti e intelligenti che sono oramai un marchio di fabbrica della compagnia, come il fatto che i 451 gradi non sono la temperatura corretta dell’autoignizione ma forse era un numero che “suonava bene”. Ma dall’altro immaginano un futuro prossimo in cui si giungerà addirittura a bruciare volontariamente le biblioteche delle istituzioni europee. Il viatico per questa nuova messa al bando della parola scritta è l’uso che se ne fa come strumento di offesa, di umiliazione, di rifiuto della dialettica nel discorso pubblico, quello grande della politica e quello microscopico (ma poi non tanto) dei nostri social. Obiezioni e contro obiezioni scorrono su un doppio schermo rosso e blu, che ci ricorda gli occhialini per la visione 3D, trasposizione stereoscopica di una polarizzazione dei discorsi che alimenta sé stessa. L’apice si raggiunge quando una nota scrittrice criticata per la sue posizioni “transfobiche”, ma anche per l’universo magico dei suoi libri per l’infanzia che secondo qualcuno si ispirerebbe al satanismo, verrà uccisa: chi ha compiuto il gesto d’odio, un fanatico di destra o uno di sinistra? Non è importante, in realtà, saperlo. Perché l’oggetto di questa satira affilata, in pericoloso equilibrio tra comico e tragico, è il vortice solo parzialmente consapevole in cui ci siamo infilati, trasformando le parole in clave, sottraendo statuto al pensiero di che non la pensa come noi.
Il cortocircuito proposto da Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa con le culture wars ci indica una frattura del presente che, proprio in questi ultimi anni, viene indagata da più parti nella sua capacità di frammentazione anziché di unione delle istanze dei movimenti progressisti (tra le ultime uscite c’è l’interessante saggio di Mimmo Cangiano, «Guerre culturali e neoliberismo», per Nottetempo). Quello che forse colpisce di più de “Il fuoco era la cura”, allora, il suo messaggio carsico e potente anche se si potrebbe definirlo “indicibile”, sta nella disposizione con cui il divieto dei libri e della scrittura viene accolto dalla popolazione: con sollievo. I libri ci mancano, sì, come ci manca il teatro – e alcune manifestazioni semi legali che lo ricordano sono un fuoco che resta acceso, che sfida lo stato delle cose. Ma abitare la fine dei discorsi d’odio, delle diatribe culturali più tribali che sostanziali, dell’inquinamento costante della realtà operato dal linguaggio pubblico… beh, viene accolto con un terribile “finalmente”. Come dare torno a questa umanissima reazione. Certo, il quadro generale, il bigger picture, ci dice che è una reazione sbagliata, che un atteggiamento del genere ci nasconde esageratamente i contorni dell’iper-oggetto mortoniano che è la comunicazione nel nostro presente, il modo surrettizio e sempre meno controllabile con cui plasma le nostre visioni del mondo, fino a portarci all’autoinganno. Quante svolte autoritarie, nel corso della storia, sono cominciate con un “finalmente”? Averlo presente mentre si entra in empatia con quella posizione è forse il regalo più terribile, avvelenato, che il Sotterraneo – tra le più intelligenti compagnie della scena contemporanea – fa al suo pubblico con questo spettacolo.
Graziano Graziani, Stati d’Eccezione
Sotterraneo – ideazione e regia come sempre di Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa – torna dunque a giocare con il tempo, indaga i rapporti di causa-effetto passando da uno spettacolo di altissimo spessore come L’angelo della storia, in cui il dispositivo teatrale diviene lo strumento dei viaggiatori del tempo che si muovono liberi nella pancia del passato, a porre ora sotto esame il presente, quel fascio intricato di possibilità e impossibilità che si stringe attorno alle vite dei contemporanei. C’è una scena vuota e nera, al centro della quale emerge, come una sorta di totem, un proiettore verticale che attrae verso l’alto, dove ha luogo l’immaginazione, sembra un fuoco attorno a cui solo una storia – o la, storia – può essere narrata; cinque presenze – attori energici e completi Flavia Comi, Davide Fasano, Fabio Mascagni, Radu Murarasu e Cristiana Tramparulo, che si caricano il peso di uno spettacolo senza risparmiare nulla, capaci di diventare uomini-teatro al pari di come nel romanzo si parla di uomini-libro – cercano sul palco di far emergere tratti della vicenda, frammentata in singole scene che via via vengono discusse, a costituire elementi di un’indagine più profonda sulla società che ci avviamo a diventare, usano cioè il teatro come sonda per la contemporaneità, costruiscono un rituale con il solo intento di sovvertirlo, vanno avanti e indietro nel tempo e nel racconto creando così una distopia nella distopia.
All’interno del romanzo destrutturato, la cui forma è costantemente minacciata da un fuoco che (forse) sarebbe la sua e nostra cura, si fanno strada le tante contraddizioni delle questioni politiche di maggiore impatto, dalla crisi climatica alla fine della democrazia che fa emergere questa nuova esigenza autoritaria nel cuore dell’Occidente; eppure le istanze ideate dalla scrittura di Daniele Villa che appaiono sullo schermo, al riparo dalla banalità, si fanno carico di paradossi e domande scomode che riguardano la verità non delle istanze, ma della nostra capacità di partecipazione al dibattito, di conservazione delle idee in una società in cui la sovrapproduzione dei nostri amati libri, in quanto contenitori di teorie uguali e contrarie, è anche responsabile di creare strumenti validi per ogni teoria, anche la più folle. Insomma, un libro è La Bibbia o le ricette dell’Artusi, ma un libro è anche il Mein Kampf.
Le parti del romanzo seguono una cronologia fluttuante, gli attori ne mimano una scena mentre uno di loro, scegliendo un microfono tra i vari fili arancioni intrecciati sul palco, la racconta agli spettatori, creando così due diverse narrazioni che rendono complementare il totale dell’immagine. Non c’è una sola storia, non c’è una sola verità. Poi tutto si mescola, i personaggi – Montag, Beatty, Clarisse, Mildred – anche già morti si incontrano e parlano tra loro della vicenda, gli uomini-libro compiono l’atto impossibile e simbolico di imparare a memoria volumi, velocizzando e rallentando le scene (con una qualità tecnica degli attori davvero eccellente), una conferenza del 2051 parla del tempo presente al passato, ascoltando testimonianze sullo spettacolo andato in scena molti anni prima, cioè adesso, il linguaggio metateatrale amplifica la scena a renderla idealmente gigantesca e magnifica (ma sempre nera e vuota resta), così che il romanzo si accresce di altri e vari materiali – certo anche il film omonimo di Truffaut e le tante canzoni che ad esso si ispirano – creando così una forma ancora nuova, un apparato con cui affrontare quel senso di gravità perenne che sta conducendo, sotto la spinta di tutte le nostre mani, il mondo verso la fine.
Se fossimo in un Paese in grado di valorizzare le eccellenze, il Sotterraneo sarebbe analizzato nei contesti culturali nazionali e internazionali, non solo rappresentato ovunque ma discusso – sui giornali, in TV, in radio e sul web – assieme all’uscita dei grandi libri di letteratura, dei grandi film che si presume faranno la storia del cinema, sarebbe cioè inserito nel dibattito perché dice qualcosa di importante sulla contemporaneità con limpidezza e qualità ineccepibili e raffinate. Eppure non accade, restiamo noi a scomparire in un applauso perché almeno quel poco si noti quanto, attraverso il teatro, si possa vedere del mondo.
Sono tante le domande con cui si esce dalla sala, tante domande che però hanno nel cuore pulsante, com’è per l’arte che rilancia oltre l’opera, il desiderio di una risposta. L’eredità del sapere è una risorsa oppure una condanna, l’erudizione ottunde o libera lo spazio della mente, saremo per sempre o no capaci di mantenere e dissipare con questo senso dell’equilibrio innato, cui ci porta più l’istinto di conservazione che la capacità di deciderne il destino. Tante domande rivolte al presente, stimoli fragili e profondi che hanno l’unica vocazione di restare tali. Perché questo non è che teatro, pur grande e durevole nel tempo. E un rogo alto e fiero che scalda è pur sempre luce. La fiamma che brucia i bordi delle pagine, c’è da chiedersi, sarà la stessa che brucia l’interno del libro? E la temperatura giusta, poi, sarà davvero quella che Bradbury ha fatto diventare iconica?
Il dilemma è sempre quello con cui si apre lo spettacolo.
“Perché rovinare una bella storia con la verità?”
“Perché rovinare la verità con una bella storia?”
Perché la vita, forse, è come un fuoco lento.
E cambia spesso direzione, esposta al vento.
Simone Nebbia, Teatro e Critica
Si trattava di piccoli bassorilievi scolpiti nella pietra che sono diventati centenaria testimonianza di quella vita, come se in quel fatto artistico l’uomo avesse condensato il senso del suo vivere in quella miserabile condizione. Come dire che il bisogno dell’arte, quello veramente disperato e assoluto, si manifesta insopprimibile nelle condizioni di maggiore deprivazione.
Ecco perché all’uscita dal Teatro Fabbricone di Prato, dove abbiamo assistito al debutto del nuovo lavoro dei Sotterraneo, Il fuoco era la cura, liberamente ispirato a Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, mi sono tornate in mente quelle immagini; di simili ce ne sono in tanti luoghi di disperata prigionia.
E forse mai come in questo momento il genere umano è prigioniero di sé stesso verso un destino che sembriamo incapaci di sovvertire.
MB: Ce l’hanno fatta anche stavolta. Il tocco dei Sotterraneo ha funzionato anche con Bradbury. Fahrenheit 451, nelle mani di Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa, diventa il racconto incendiario di questo nostro presente impazzito a ogni latitudine, con il Doomsday clock (l’orologio dell’Apocalisse, creato nel 1947 all’indomani delle bombe su Hiroshima e Nagasaki) che segna 90 secondi alla fine del mondo.
La guerra atomica è scritta, è predetta nel romanzo. Per questo attraversa più volte il Fabbricone da parte a parte, come una lama, il rombo di un qualche caccia che fa abbassare tanto la testa di Flavia Comi, Davide Fasano, Fabio Mascagni, Radu Murarasu, Cristiana Tramparulo in palcoscenico quanto i nostri pensieri in sala. È una guerra immaginata, tutt’al più temuta, ma non è campata in aria, come quel fragore vorrebbe far sembrare. Difatti, la canzone ossessiva su cui i pompieri “danzano” e si motivano durante gli incendi dei libri non è una qualsiasi: è Fire Water Burn di Bloodhound Gang, con il suo tormentoso «The roof, the roof, the roof is on fire» – «Il tetto, il tetto, il tetto è in fiamme». Veniva ascoltata dai marines in Iraq e Afghanistan.
Il tocco dei Sotterraneo di cui parlo sta proprio qui: nella loro capacità di far emergere il proprio pensiero sul mondo amplificando usi, commistioni e abusi degli immaginari e dei linguaggi prodotti dal sistema e dall’industria culturale. E lo fanno in modo sia accattivante – fin quasi a rendere sexy anche il male – che intellettualmente onesto. Con il fuoco non si scherza: infatti, ed è quantomeno insolito per loro, l’ironia è praticamente bandita.
RF: Non so dire se sia davvero così, perché in fondo tutta la costruzione è un gioco ironico, a tratti sardonico. Più della risata leggera si gode dell’arguzia, dell’intelligenza della costruzione, guardando a quanto di miracoloso il teatro ancora può fare per raccontare il tempo che viviamo.
In scena, come in molti dei loro lavori, non c’è nulla: alcuni oggetti funzionali alla resa scenica (studiati da Eva Sgrò) vengono portati nello spazio agito da dietro le quinte, ma di fatto ci sono solo le luci e le videoproiezioni oltre alle presenze fisiche degli attori.
Torna in mente Post-it, il loro primo lavoro, quello che li aveva consacrati come emblematici rappresentanti della nuova generazione della scena italiana una quindicina di anni fa. Anche lì un focus sul tema della fine, anche lì la scena vuota che veniva alimentata di oggetti recuperati dietro le quinte, messi sulla scacchiera e poi riportati fuori, in un andirivieni apparentemente intonato al gioco.
Qui, tuttavia, come anche in Overload, dove al centro era la figura dello scrittore David Foster Wallace, c’è una traccia drammaturgica sottostante che, seppure con grande libertà, funge da collante concettuale dell’operazione performativa. Ma anche lì si parlava di termine, di interruzione, di scomparsa.
MB: Fahrenheit 451 è un libro che parla della scomparsa dei libri. Sulla scena dei Sotterraneo è una realtà già avvenuta. Non c’è più l’incendio, c’è il fumo. Il fuoco era la cura. L’azione, dunque, è còlta al passato, nella continuità ininterrotta del suo svolgimento. L’inizio e la fine sfumano nell’oggi, il presente di cinque interpreti che entrano come Amleto, anche loro con un libro in mano, e ciascunə prova a imparare il proprio a memoria ma non ci riesce, mentre i suoi sogni e i suoi timori alle prove passano nell’audio. L’unico scritto che sono in grado memorizzare e di recitare nel senso di ricitare, è il testo dello spettacolo, composto da tre capitoli, più prologo ed epilogo.
L’ossatura del romanzo, interpolato con estratti dalla sceneggiatura dell’omonimo film di François Truffaut, è restituita nei tre capitoli per dialoghi e descrizioni. Ognunə è sia personaggio sia narratore onnisciente. Quando parlano tra loro non ricorrono ai microfoni, li usano soltanto quando raccontano. Sono di colore arancione e corrono veloci di mano in mano: rappresentano le vere lingue di fuoco che si sprigionano sul palco. Sono i fili del discorso su Fahrenheit 451 che ci portano ai “dibattiti post spettacolo” di Comi, Fasano, Mascagni, Murarasu, Tramparulo.
Il fuoco era la cura, infatti, non si svolge adesso ma nel 2051. Quindi a distopia avverata. Le “persone libro” di Bradbury per i Sotterraneo sono glɜ “interpretɜ copione” che recitano anche nel senso che ricordano la loro vita prima e dopo i roghi dei libri, ciò che li ha portati lì, a essere come sono. Un’invenzione, a mio avviso, inquietante e sorprendente, perché ci fa vedere la realtà per quella che potrebbe o, peggio, potrà essere se continuiamo a bruciare la complessità sull’altare della mera semplificazione binaria.
RF: Lo spettacolo si apre proprio dentro questa finzione in cui il pubblico (in modo immaginario) partecipa a un incontro con gli interpreti, in cui loro, fra trent’anni, in un mondo in cui è già tutto successo, come dicevi, raccontano a un gruppo di presenti in quale maniera si è avverata la profezia dello scrittore. Gli ascoltatori della conferenza-dibattito siamo noi, presenti oggi, ma anche, in un certo qual modo, le nostre identità future che raccolgono questa drammatica testimonianza. Tanto che loro rispondono a domande che nessuno di noi rivolge loro in realtà.
È un finto dibattito, un finto dibattimento. È un finto abbattimento della quarta parete. Potemmo anche non esserci.
Magari fra 30 anni non ci saremo.
Ma l’interrogativo è anche rivolto a cosa faremo noi da oggi ad allora per scongiurare che non si sia davvero solo testimoni; o magari, peggio ancora, complici di questa deriva, senza opporre resistenza, cosa a cui il finale dello spettacolo vuole alludere, fra catastrofe e speranza. Ma, un po’ come anche in altre loro creazioni e, in particolare, ne L’Angelo della Storia, l’andamento della narrazione va avanti e indietro nel tempo, fino a tornare ai riti primordiali dell’umanità intorno al fuoco. Che ovviamente c’è ma non c’è.
Il tutto viene reso mirabilmente da un disegno luci, opera di Marco Santambrogio, che crea un kolossal nel vuoto, rafforzato nelle sensazioni dai suoni del sempre affidabile e tridimensionale Simone Arganini e anche da una presenza in scena che mai come in questo lavoro punta anche sull’elemento direttamente o indirettamente coreografico cui ha collaborato Giulio Santolini. Di arguta semplicità iconica, ma senza pauperismi e sciatterie, gli abiti di scena di Ettore Lombardi. Semplici perché, comunque, gran parte del lavoro di completamento immaginativo viene lasciato allo spettatore, come sempre deve essere in un’opera d’arte che non deve mai farsi completa in sé.
MB: È esattamente così. Al pubblico Il fuoco era la cura chiede un grande lavoro di immaginazione, quasi al pari di un libro. Come se il teatro fosse una pagina da sfogliare, un tableau vivant di copertine che svelano storie e canzoni ispirate ai volumi più celebri o ai personaggi letterari più popolari. Aglɜ interpretɜ, invece, chiede un impegno altrettanto grande di esecuzione per interpretazioni a velocità normale, ma anche rallentata, tipo “stop-motion”, oppure accelerata, stile “fast forward”.
È come se vedessimo tutto su uno schermo, inquadrato da una telecamera, ripreso e riprodotto in video. E il telecomando ce l’ha qualcuno che è tra noi ma che non siamo noi. Questa prospettiva, che può essere presa per una trovata di intrattenimento, un esercizio di stile o una prova di abilità per glɜ interpretɜ, delinea, a mio avviso, la seconda invenzione dei Sotterraneo, notevole e autentica, perché si rifà al pensiero originario di Bradbury: nelle sue intenzioni Fahrenheit 451 era una critica della televisione, considerata colpevole di distruggere l’interesse nei libri.
Cosa c’è di tanto importante in un libro? Non cosa c’è scritto ma leggere. Ovvero, raccogliersi in sé stessə e dare la propria voce a parole di altrɜ. Un’azione che unisce i popoli da secoli e secoli, poiché non è mai cambiata da quando è stato inventato il libro. Se scomparisse, ci dicono i Sotterraneo, non avremmo più uno strumento di comunione con la nostra umanità.
RF: Lo spettacolo è l’esito teatrale più maturo della compagnia, e non perché l’ultimo in ordine di tempo, ma perché compone in questa creazione una summa di molti dei percorsi, delle tematiche, delle tecniche sceniche e drammaturgiche studiate e sperimentate nelle creazioni precedenti, che qui arrivano a sintesi: va accolto come un bene, dal punto di vista semantico, che il collettivo abbia stilemi e ossessioni artistiche e tematiche, e che, con una modernità di approccio al linguaggio della scena, sappia intessere un dialogo con il pubblico senza ricorrere alla ormai banale rottura della quarta parete, a cui qui si gioca ma senza che davvero mai accada. Anzi, pare quasi che la si voglia chiudere.
Ma soprattutto, devo ammettere, in più occasioni mi sono fermato a pensare fra me e me: ma che meraviglia che a teatro si possano fare tutte queste cose con pochissimo, e con la maestria dell’esperienza e del pensiero di chi, avendo esplorato la macchina, arriva a conoscerla così a fondo. In diverse occasioni i membri dei Sotterraneo giocano sulla povertà dei mezzi, ma in fondo è una scusa per lasciare allo spettatore – in questo spettacolo più che mai – il compito di completare con il pensiero e l’immaginazione quello che volutamente manca in palcoscenico. Ed è per questo che con ancora maggior forza si porta a casa la fortissima, angosciante e più vera sensazione su questo tempo malato e sconvolgente.
Avevo visto anni fa un allestimento di Fahrenheit 451 con grandi mezzi ma di cui oggi non riesco a tenere in me quasi nessun fotogramma, se non qualche espediente scenografico da kolossal. Qui, invece, ho dentro una sensazione emotiva durissima, che si rafforza con l’andare dei giorni. Siamo di fronte a un gioiello. Hai ragione: ce l’hanno fatta anche stavolta. E, per quanto mi riguarda, persino meglio delle altre.
Renzo Francabandera e Matteo Brighenti, Pac Paneacquaculture
Nicola Arrigoni, Sipario
Tutti e due giocano col “mokumentary”, ma Twarkowski lo dispiega con enormi tecnologie e mezzi cinematografici, qui il falso-ironico documentario è solo immaginato. In entrambi troviamo una ricchezza di spunti che illuminano lo stato del teatro, il senso del fare cultura o arte, e in entrambi sono in gioco anche le “guerre culturali” o, meglio, il conflitto di paradigmi: in “Rohtko” Twarkowski si chiede: che succede se nel sistema neoliberista del mercato dell’arte entra in campo la Cina, che ha altri paradigmi estetici? Invece Sotterraneo tiene sottotraccia questa domanda: Che succede se dopo che il XX secolo ha lottato per una democratizzazione del sapere, la base democratica nel XXI secolo deciderà che non le importa nulla di quel sapere (i libri, la cultura, l’istruzione)?
In “Il Fuoco era la cura” troviamo in apertura i cinque attori seduti che provano a imparare a memoria un libro per realizzare uno spettacolo su Fahrenheit 451. Scena spoglia, solo un faro verticale rosso, che mima freddo il fuoco. Sul fondo due schermi, su cui passeranno testi, domande, citazioni. Ironia qua e là sul basso budget, ma è solo parte del gioco finzionale (ma pure certo stoccata critica verso gli scarsi fondi pubblici).
Quel che ha costruito Sotterraneo è un teatro composito, in cui la finzione metateatrale degli attori si mescola a frammenti in cui si recitano scene del libro di Bradbury (in una scena particolarmente suggestiva, mimando in playback il sonoro del doppiaggio italiano del film di Truffaut). Il filo conduttore è però un’altra distopia – lo scrittore di fantascienza aveva ambientato Fahrenheit 451 negli anni Venti del XXI secolo, i nostri – ovvero quella del 2051 quando quello stesso gruppo dei cinque attori, racconta, con un salto temporale e durante un “Incontro col pubblico”, come progressivamente il teatro sia stato estromesso dalla società, dagli anni Venti in poi, proprio da quel 2024 in cui preparavano una versione di “Fahrenheit 451”. Si capisce già qui l’abile tessitura di rimandi della scrittura di Dario Villa che si arricchisce di riflessioni antropologiche, sociali, sui linguaggi dei media, sul ruolo dei social, e soprattutto sulla politica e sulle possibili derive autoritario prossime future.
Tutto in un crescendo che ha il ritmo degli sketch (spesso si ride, con retrogusto amaro) tenuto benissimo dagli attori, tutti bravi: Flavia Comi, Davide Fasano, Fabio Mascagni, Radu Murarasu e Cristiana Tramparulo (stavolta Bonaventura e Cirri non sono in scena come in lavori precedenti) affiatati anche nella continua cinèsi performativa – bello il balletto stile tiktok con la tuta dei pompieri – e nel cambiare continuamente registro (e personaggi) nei vari inserti. Sono attori che in scena si mettono al servizio di un racconto (un’idea di teatro che ricorda quella che esprime spesso Massimiliano Civica e non a caso col Teatro Metastasio di Prato che dirige, lo ha prodotto, insieme a Piccolo Teatro di Milano e Teatro d’Europa e Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale. Lo spettacolo sarà al teatro Bonci di Cesena il 18-19 ottobre e poi Arena del Sole di Bologna il 9-10 novembre, oltre che a Torino al Festival delle Colline il 15 ottobre e ne raccomando assolutamente la visione).
“Il fuoco era la cura” procede per scene scandite in capitoli, con salti temporali avanti e indietro sottolineati da titoli luminosi, in cui al racconto del 2051 si intrecciano le scene da Fahrenheit 451: la distruzione dei libri dei pompieri, i dubbi di Montag, la ferocia di Beatty (impressionano le sue parole, così vicine a certi leader populisti di oggi) i circoli di resistenza degli “uomini-libro”, con inserti sulle sorti della democrazia futura allarmanti. Se infatti Montag nel romanzo di Bradbury si unisce ai book people, Sotterraneo non concede consolazioni o facili sdegni (non mancano critiche a certe ideologie correct e woke). La società autoritaria nel 2051 è immaginata al potere senza alcun colpo di stato, ma con il nostro consenso. Anzi quasi per eccesso di tutela e consapevolezza: gli attori raccontano come dal 2029 i democratici, preoccupati per il crescente populismo vittorioso, che sfruttava l’ignoranza dell’elettorato, abbiano introdotto un “patentino di voto”, col risultato della rinuncia di molti e esprimerlo. (A parte Pirandello e “La patente”, viene in mente il sistema elettorale Usa con iscrizioni alle liste di voto).
Tutto è raccontato mettendo in scena una falsa “audience development”, il cosiddetto “dopo spettacolo” che si immagina finirà per essere l’unico (post)teatro possibile, eccetto le gag dei “clown bianchi” (è lo show tv ripetitivo che la moglie di Montag guarda ossessivamente in tv) che compariranno a suggellare questa sorta di profezia di un futuro che si preconizza dai segni del passato (sulla scia del pensiero di Benjamin, a cui Sotterraneo ha dedicato il precedente spettacolo “L’angelo della storia”). Se il teatro era un “rito attorno a fuoco” ora davanti a noi gli attori che interpretano sé stessi nel 2051, che ascoltano domande dal pubblico ma non dette (così noi spettatori diventiamo metafora incarnata di un’assemblea democratica esautorata dalla parola).
La costante anche se virata da una vena apocalittica, è l’ironia e l’intelligenza, il gioco tra molte opzioni interpretative possibili, con l’invito a non prende “alla lettera” nulla, nemmeno la distopia politica di Bradbury (né alcun paradigma, compresi quelli della “cancel culture”: feroce, tra le tante satire distopiche, quella sulle “Fatwe” social che – raccontano i cinque testimoni –“ iniziarono dal 2026 e portarono alla morte di J.K. Rowling” per mano di estremisti (forse ultracattolici oppure transfemministi, che è lo stesso). La “nube tossica mediatica” avvelena il pensiero, e il manicheismo social degli attivisti senza sfumature somiglia all’ottusità di Beatty, al suo populismo semplificatorio. La scritta luminosa potata a braccio dagli attori, “Silence” è l’insegna dell’ultima speranza.
“Il fuoco era la cura” è un eccellente esempio di rito teatrale che si celebra nel suo sviluppo decostruito. Tra amarezza (crediamo il fuoco-autoritarismo una minaccia, si presenterà come cura di ciò che era già malato, compreso ciò che si riteneva nel giusto) e la speranza del debole vento messianico della Storia che procede per “choc” (scorrono alla fine sullo schermo le date dei grandi roghi, da quello dell’imperatore cinese fino a quelli del Corano oggi, ma passando per l’ira “cancel” sia di destra che di sinistra) l’opzione è aperta.
Ci saranno ancora persone che si faranno portare prima di morire davanti a un quadro di Matisse anche se bruciacchiato o saremo presi solo dallo show di clown bianchi? E le risposte stanno negli studenti di una scuola superiore che alla replica al Teatro Melato hanno parlato tutto il tempo indifferente? O nel resto dell’audience che ha applaudito per dieci minuti alla fine?
Mario de Santis, Huffington Post
Se proprio una forma verbale si volesse trovare per lo spettacolo, bisognerebbe parlare di futuro anteriore. Cioè di un futuro che già è diventato passato, o sta per esserlo. Guardare da un tempo futuro, e pensare di viverlo nel presente. Non siamo lontani dall’angelo della storia di Walter Benjamin, che vola verso il futuro con lo sguardo rivolto al passato, a cui non per caso aveva felicemente attinto la precedente creazione di Sotterraneo. Dove insomma il futuro è il mezzo, ma ciò che interessa è il presente. Qui due piani temporali e linguistici si sovrappongono continuamente. C’è il racconto dello spettacolo a cui stiamo assistendo, una sorta di surreale making of; e c’è lo slittamento all’anno 2051, il futuro anteriore in cui gli stessi cinque interpreti, seduti in fila su seggioline in faccia agli spettatori, partecipano a un incontro un po’ clandestino, rispondendo a domande che possiamo soltanto immaginare sullo spettacolo di un quarto di secolo prima. La guerra atomica ci fu, anche se non è certo che abbiamo vinto «noi». I roghi di libri non servono più perché nessuno li legge…
Il racconto procede a sbalzi, com’è nello stile di Sotterraneo. Entrano concentrati sui grossi volumi che tengono aperti alla prima pagina, cercando inutilmente di memorizzarla, nel vano tentativo di diventare loro stessi uomini-libri come vuole il finale ottimistico del romanzo. Presentano i personaggi che interpretano. Montag, pompiere riluttante. La moglie Mildred che passa le giornate attaccata a un visore interattivo, a guadare la danza dei clown bianchi. La giovane Clarisse che vive ai margini della legalità, cioè si concede un pensiero autonomo… Le azioni vengono prima spiegate e poi eseguite con le parole del romanzo o il sonoro del film, nel doppiaggio italiano. Le poche risorse produttive hanno messo fuori questione le idee colossali che avevano in mente. L’incidente stradale simulato per togliere di mezzo la strana Clarisse diventa un volo sulle braccia dei compagni – ma la ritroveremo alla fine avvolta dalle bende, prima di morire ha chiesto di vedere la Danza di Matisse. E non mancano le immagini che aggiungono un tono pop, come la danza dei pompieri in tuta rossa e casco integrale, conclusa a girare intorno alla colonna luminosa che trasforma in un totem il getto del lanciafiamme. O il passaggio sul fondo di un SILENCE scritto da neon rossi. Due schermi in alto un po’ convergenti proiettano le didascalie che commentano in maniera dialettica l’azione. Tesi e antitesi, poema e antipoema. Oggi è prioritario lanciare un messaggio / L’artista non è un postino. L’artista e la sua opera coincidono / L’opera è autonoma e il suo valore prescinde da chi l’ha scritta. Ed è bene che qualcosa insinui il valore del dubbio, laddove la distopia lavora soltanto su bianco e nero fatalmente predicatorio. Anche Mildred si è convinta di essere intrappolata dalla sua parte nel ruolo di una casalinga americana anni cinquanta, ancora attuale, dopo settant’anni. Mentre i brani della colonna sonora richiamano altrettanti libri, non se ne scappa. White rabbit dei Jefferson Airplane anni sessanta con l’Alice del reverendo Lewis Carrol e così via. Mimati sulla scena in una serie di tableaux vivants nello stile del vecchio Living che loro, i ragazzi di Sotterraneo, non hanno ovviamente conosciuto (e sono bravi Flavia Comi, Davide Fasano, Fabio Mascagni, Radu Murarasu e Cristiana Tramparulo, passato il primo sconcerto di non vedere sulla scena nessuno dei volti storici del gruppo). Play with fire dice la canzone che accompagna la danza dei clown bianchi. Hanno preso loro il possesso della scena, anche i nostri cinque attori hanno dovuto adattarsi. Puro entertainment, ma è l’unico teatro che è rimasto. Nel 2051, naturalmente.”
Gianni Manzella, Il Manifesto
Rodolfo di Giammarco, La Repubblica
Rodolfo di Giammarco, La Falena
Sono a botta calda queste considerazioni che mi porto dentro dopo aver visto in questo periodo diversi lavori interessanti in contesti tra i più disparati e a ridosso delle premiazioni Ubu, sulle quali bisognerebbe scrivere a parte.
Si comincia con l’ultima fatica di collettivo Sotterraneo da Firenze e dunque si comincia con una delle eccellenze della scena contemporanea, stupendoci tutto sommato che questo ensemble di scrittori e talenti della e per la messa in scena, ovvero Daniele Villa, Claudio Cirri, Sara Bonaventura, sia già tra noi da una ventina d’anni tale è la freschezza ogni volta e la cogenza ai tempi presenti della rappresentazione che propongono, pur in una riconoscibilità di cifra e di stile che sempre distingue chi sappia creare un equilibrio tra urgenza dei temi, linguaggio opportuno per trattarli e aderenza alla propria autentica vena creativa.
Ci stiamo comunque riferendo in questo caso a “Il fuoco era la cura”, mai titolo fu più icastico di questo, spettacolo liberamente ispirato all’arcifamoso romanzo scifi Fahrenheit 451 a firma Bradbury, datato 1953 e poi trasposto nel 1966 in una fortunata edizione cinematografica per la regia di Francois Truffaut.
I gradi di temperatura cui allude il titolo del romanzo peraltro concepito inizialmente come racconto all’interno di una raccolta di racconti sarebbero quelli indicativi per la combustione della carta, sebbene ci siano in corso discussioni da sempre sui vari gradienti e forme di misurazione del calore necessario a tal fine a seconda della tipologia di carta.
La storia più o meno è nota. In un mondo non tanto diverso e distante da qui, anzi forse nel nostro apparentemente confortevole oggi, ma certo sconfortante al tempo stesso specialmente nelle sue proiezioni sul futuro, possedere libri è diventato un reato che costa caro e il corpo dei pompieri non assolve più prevalentemente la funzione di spegnere incendi tramite idranti, bensì quella di appiccare le fiamme a cataste di libri in qualche modo snidati attraverso delazioni, sentito dire e indagini di dubbia natura e correttezza o tramite manipolazioni e pressioni psicologiche dirette o indotte da una cultura televisiva di intrattenimento, quella dei clowns bianchi attraverso cui passano contenuti subliminali di conformismo e serena accettazione dello status quo. All’inizio del racconto ci stanno dentro due dei protagonisti della storia, ovvero Montag, il vigile del fuoco tipo e sua moglie, poi le cose prendono una piega ben diversa, a causa di una sorta di ribaltamento paradossale di valori che investe nelle modalità casuali e clandestine tipiche di questo tipo di narrazioni, l universo programmatico degli addetti all’eliminazione della cultura libraria, e che lascia trasparire ai limiti di un olocausto finale, una possibile ancora di salvezza rappresentata da una popolazione marginale autoesclusa e boschiva che ha scelto di farsi comunità nella missione simile a quella degli amanuensi medievali di preservazione di contenuti mandando a memoria un volume per ciascuno. La storia sembra lineare e dimostrativa, tanto si pone come paradigmatica e paradossale, sottintendendo un bene che sappiamo benissimo da che parte sia, ovvero quello della scrittura, della lettura e della trasmissione del sapere, ma a ben vedere molteplici sono le pieghe di un racconto, che certo risente dell’epoca maccartista in cui fu concepito e della latente minaccia nucleare in capo alla politica dei blocchi. In realtà, con una messinscena piena, pur nel sostanziale vuoto scenografico, veloce quasi da risultare convulsa un manipolo di cinque bravissimi attori che sanno padroneggiare bene tecniche di movimento quasi coreografiche, sono li a dimostrarci plasticamente tutta l’ambiguità e la contraddittorietà di cui la nostra cultura Wikipedia è oggi inesorabilmente intrisa. A cominciare dal fuoco stesso, elemento sacro e simbolico di per se di cui viene messa in dubbio l’attribuzione catartica. Il teatro stesso di ricerca viene minato nella sua caratterizzazione vocazionale quando i nostri personaggi, meglio sarebbe considerarli quasi reagenti chimici di un esperimento, con verve fregoliana, abbandonano metaforicamente la tuta ignifuga per sedersi in un salotto da talk show, contrappunto all’azione stessa che viene peraltro contemporaneamente anche raccontata mentre si svolge quasi in un controcanto da tragedia. Qui, in un depressivo duemilacinquantaqualcosa, ormai molto vicino a noi spettatori essi vengono interrogati sulla loro biografia di teatranti ormai conclusa perché senza alcun bisogno di incendi ai teatri, essi sono andati via via chiudendo per mancanza di materia prima ovvero spettatori ed un destino da entertainers, lo stesso ruolo che nell’opera in corso di rappresentazione viene tollerato come forma di spettacolo – psicotropo per le masse, è il massimo cui essi possono aspirare. Già da questo impianto narrativo ed esemplificativo, si comprende come il lavoro messo su dai Sotterraneo come spesso accade, sia una diabolica implacabile macchina atta tramite stratificazioni di significati a seminari dubbi, porre interrogativi, minare certezze…a “scherzare col fuoco”, in poche parole e a saggiare la tenuta di un pensiero critico, laico, democratico universalista per come abbiamo fin qui creduto di praticarlo noi dalla parte giusta tra molte virgolette, della Storia. Tutto lo scibile umano, in una sorta di vertigine distopicamente divertente sta apparecchiato per noi fruitori e viene utilizzato dalla compagnia non tanto come la classica tavolozza da cui attingere coloriture ma piuttosto come un agone sportivo in cui scorrazzare tra epoche diverse, fatti, accadimenti ere intere addirittura. La Storia e la sua ambigua valenza ammaestratrice, ma anche di ricorrenza attraverso una dialettica spietata tra progresso e regressione, come sempre si pone al centro della poetica del gruppo fiorentino.
Silvia Napoli, Il Manifesto
L'ANGELO DELLA STORIA
Che cosa sono i fatti all’interno della storia? Certamente sono degli atti di coscienza, attraverso i quali gli esseri umani potranno definirne i mutamenti, raggrumare i frammenti sparsi di passato e con essi comporre un presente ideale, qualcosa che sia al contempo fruibile, plausibile. Ma proprio in virtù di questo i fatti, nella storia, corrispondono a delle immense illusioni, mediante le quali ci permettiamo di costruire una narrazione, differente secondo esperienza, latitudine, risorse economiche, conseguenze. Questa alterità del tempo, mai stabile e che quindi mai permette alla storia di essere determinata unilateralmente, questa relazione in continua definizione tra passato e presente, ricorre nell’immagine famosa descritta dal filosofo Walter Benjamin nella sua penultima opera: un angelo che spiega le proprie ali verso il futuro, ma ha il volto, l’intero corpo rivolto verso il passato; l’angelo sa, non può non sapere, che il suo volo non è libero, tutto ciò che sta alle sue spalle dovrà forzatamente essere trasportato, nel bene o nel male, nel tempo successivo, non è possibile evitarlo e non importa quanto di esso sia distrutto, scomposto in molti frammenti, dovrà in ogni caso procedere a comporre, con tale passato, il presente che vi succede. Tale è L’angelo della storia, spettacolo collettivo ideato dal Sotterraneo e che, dopo il debutto a Inteatro Festival 2022 di Polverigi (Marche Teatro), ha abitato il Teatro Solvay di Rosignano per l’edizione 25 del Festival Inequilibrio.
Prima di tutto una nota tecnica: si fa fatica a dire “uno spettacolo del Sotterraneo”. Era così, forse, un tempo. Ma il termine “spettacolo” pare non più adatto. Sotterraneo ha trasformato negli anni il proprio impegno teatrale, innescando un processo di estrema complessità che si estende all’opera concettuale su più larga scala, giungendo a definire il teatro in sé – ed è sicuramente un processo iniziato fin dalla fondazione della compagnia – come non più il fine, ma il mezzo attraverso cui scavare nelle cavità di questo tempo. La formazione attuale, cambiata negli anni, mantiene un nucleo fondativo storico dal 2005 con Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa (colui che scrive e dispone, raramente sul palco) e si è allargata con Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini, non come semplici performer occasionali, bensì come parte integrante del progetto Sotterraneo, al punto di firmare concept e regia con il nome di collettivo. È, questo, un elemento portante di come si sia trasformato il gruppo, non solo sul piano della costruzione dell’opera, ma soprattutto come esemplare di più alto livello (da ricordare il premio Ubu per il miglior spettacolo 2018 con Overload) di riorganizzazione della “compagnia teatrale” al tempo delle riforme ministeriali che ne minano il concetto basilare.
Come spesso nei lavori del Sotterraneo, il rapporto tra ciò che accade sul palco e l’effetto sulla platea è privo di barriera: c’è un display in alto, sul fondale, dove appaiono sovraimpressioni di numeri, date storiche che vanno avanti e indietro nel tempo come su un orologio impazzito; ogni data, impressa con un enorme rettangolo di luce negli occhi dello spettatore, rappresenta un evento storico che viene ricomposto sulla scena, per dirla un po’ con Marx, con le caratteristiche di una farsa, per indicarne così l’impossibile verità, illustrata da una storiografia necessariamente priva di prospettiva: tempo contemporaneo in movimento sovrapposto al tempo immobile del passato. E proprio per questo, prima di iniziare, ma dopo l’inizio, viene chiesto agli spettatori di impostare il timer del proprio telefono a 53 minuti esatti, fine dello spettacolo; e dunque il racconto che fa saltare i margini del tempo può avere validità, formare un modello di realtà utile a sopravvivere, soltanto dentro una cellula di tempo stabilita, una durata, ossia la misura entro cui gli esseri umani riescono a percepire la storia senza impazzire.
Ognuna delle vicende su cui si sofferma il viaggio nel tempo, espressa da un preciso giorno cui si antepone la formula “l’unico e irripetibile”, attinge a un molteplice universo fatto allo stesso tempo da verità e leggenda, senza che se ne possa evidenziare l’una o l’altra componente. Il russo Petrov era davvero a un passo dal far scoppiare la guerra atomica? Eleonora d’Inghilterra ha davvero dovuto partorire 16 figli prima che uno fosse un buon erede al trono? Il gatto Tommasino ha ereditato un patrimonio e il combattente giapponese Shōichi Yokoi è davvero rimasto nella giungla per 28 anni senza sapere che la guerra era finita? È davvero “unico e irripetibile” ogni giorno della nostra storia? La notizia ci raggiunge in modi molteplici, il fatto si fa storia e viene interpretato, incasellato in un sistema che norma le emozioni provocate dagli eventi: è dunque necessario, per sopravvivere, che la realtà sia ogni volta modellata. Così, proprio in virtù di questo vorticoso effetto sul reale, le date infine si mescolano, una grande balena bianca gonfiabile è la storia che si sta spiaggiando sul palco, sul nostro presente, ma potrebbe essere l’iceberg sul quale sbatterà il Titanic, nessuno davvero può dirlo, la fine della storia è un inizio dall’altro verso, un differente atto di acquisizione, una nuova realtà, l’angelo avrà sempre dimenticato qualcosa indietro. E torna a prenderlo.
Simone Nebbia, Teatro e Critica
In questo i Sotterraneo con L’Angelo della Storia danno corpo, movimento e racconto a una stellare sintesi della necessità dell’uomo di costruire una narrazione di sé e del mondo, dai tempi delle caverne a oggi. Un display in cui compaiono delle date: 10.000 a C e il racconto degli uomini preistorici alle prese con la sopravvivenza e le prime forme di immagini dipinte nelle caverne; 1943 Carla Capponi, antifascista, suona Chopin per coprire una riunione di partigiani; 1944 Hiro Onoda, 22 anni, soldato dell’esercito giapponese è lasciato nell’isola di Lubang con l’ordine di non arrendersi mai al nemico; 1983 Stanislav Petrov deve decidere se schiacciare il pulsante rosso per il lancio di testate nucleari e rispondere alla minaccia statunitense segnalata sullo schermo; 1255, Eleonora di Castiglia partorisce la prima di una serie di figli per dare successione al regno di Inghilterra, e ancora 1518 i piagati di Strasburgo danzano fino allo sfinimento, oppure 500 a C., i pitagorici ammazzano su una spiaggia della Magna Grecia Ippaso perché con la scoperta dei numeri irrazionali metteva in crisi la concezione dell’universo elaborata da Pitagora. Sono questi alcuni dei racconti che i Sotterraneo – e in particolare la scrittura controllatissima e acuta di Daniele Villa – intrecciano ne L’Angelo della Storia, un tessuto di accadimenti concreti e verificati: dal naufragio del Titanic allo spiaggiamento delle balene, dalla fake news del gattino Tommasino alla spedizione russa nel 1958 in Antartide per porre una statua di Lenin come segno di conquista. Racconti e rappresentazione di mondi perseguiti fino alla fine, letture di realtà in cui abitare e in cui sentirsi a proprio agio fino a diventarne vittime, i Sotterraneo raccontano il bisogno dell’uomo di raccontarsi storie, di avere una narrazione coerente con quello che sono o vorrebbero essere. L’uomo è vittima e carnefice di sé stesso, è personaggio delle sue storie e ne è condizionato, fino alla fine, fino, a volte, a esserne prigioniero. E allora si assiste a L’Angelo della Storia godendo di un piacere intellettuale che ci mette in crisi, che dice di come il potere dell’immaginazione ci guidi e ci condizioni. La compattezza frammentata della narrazione è direttamente proporzionale all’intensità e pulizia scenica e coreutica di Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini che sono un corpo unico, sono segni e racconti essi stessi e si muovono al battito delle ali dell’Angelo della Storia di Walter Benjamin, che vola con lo sguardo rivolto al passato, dando le spalle al futuro: macerie di edifici e ideologie si accumulano davanti ai suoi occhi e l’angelo vorrebbe fermarsi a ricomporre i detriti, ma una tempesta gonfia le sue ali e lo trascina inesorabilmente avanti: questa tempesta è ciò che chiamiamo progresso». Ciò che fanno i Sotterraneo è sbatterci in faccia la nostra coazione a ripetere narrazioni in cerca di un senso, di una ragione plausibile sulla casualità e sul divenire, in cui il nostro stare al mondo è un definirsi e ridefinirsi continuamente rispetto ai racconti che incontriamo e abitiamo. E tutto ciò accade in scena con grande leggerezza, incredibili intensità e compattezza esecutiva che fa rimanere a bocca aperta, che regala piacere e inquieta, che coinvolge e respinge, che chiede di partecipare ma al tempo stesso sa tenere con intelligenza le distanze, proprio come i grandi racconti in cui è bello muoversi perché ci si sente al tempo stesso un po’ di casa e un po’ estranei. Ma non è forse questa la situazione che è data all’uomo, ospite della Terra e non suo signore e padrone?
Nicola Arrigoni, Sipario
Ma si può farlo anche con la concezione del tempo, con i suoi imprevisti, galoppando nel suo alveo per dimostrare, magari, che noi esseri “sapienti” di sapiente non abbiamo “un fico secco”.
Dopo “Overload” quindi, i cinque di Sotterraneo, ormai diventati grandi e posati, lo hanno fatto, con senso e profondità di accenti, ne “L’Angelo della storia”, che abbiamo visto al teatro di Rosignano Solvay per il festival Inequilibrio, dopo il recente debutto a Inteatro 22.
Hanno come base un display che scandisce il passaggio del tempo, fra passato remoto, prossimo e presente. Qui Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati e Giulio Santolini, sulla effervescente scrittura di Daniele Villa, giocano sapientemente con tutto ciò che la scena offre, e ci comunicano con sagacia pertinente che noi, esseri umani, ci siamo narrati addosso una realtà fasulla che ci faceva semplicemente comodo, e questo fin dagli albori del tempo, quando, compiendo sacrifici umani, raccontavamo a noi stessi che non stavamo compiendo un orrendo misfatto, ma solo un rito propiziatorio per far sorgere il sole.
È da qui che Sotterraneo parte, prendendo ispirazione dall’immagine regalataci da Walter Benjamin nella sua ultima opera: l’Angelo che si volge a guardare le macerie del passato dando le spalle al futuro; vorrebbe fermarsi a ricomporre le rovine che vede, ma una burrasca gonfia le sue ali e lo trascina inesorabilmente avanti. Ed eccolo dunque il nostro Sapiens che, come quell’Angelo, continua ad andare avanti senza però neppure accorgersi delle rovine che ha lasciato dietro, compiendo sempre gli stessi errori, facendo al contempo credere a sé stesso – si badi bene – che ogni cosa che compie è unica e irripetibile, modellata come a lui interessa, spargendo in giro racconti di accadimenti che paiono vederlo protagonista ma di cui poi alla fine è solo vittima.
Ed è così che, con i toni parossistici che appartengono allo stile della compagnia, ad ogni data apparsa sul display viene rappresentato in modo esemplificativamente beffardo un avvenimento per indicarne (forse) l’impossibile verità: Eleonora di Castiglia, regina d’Inghilterra, ha davvero dovuto partorire 16 figli prima che uno fosse un buon erede al trono? Il gatto Tommasino ha ereditato davvero un patrimonio?
Nel 1944 Hiro Onoda, soldato dell’esercito giapponese di 22 anni, è stato lasciato veramente nell’isola di Lubang con l’ordine di non arrendersi mai al nemico? E nel 1983 Stanislav Petrov era davvero in ambasce per schiacciare il pulsante rosso per il lancio di testate nucleari così da rispondere alla minaccia statunitense segnalata sullo schermo?
E perché mai, nel 500 a. C., i Pitagorici, su una spiaggia, dovettero affogare Ippaso, reo di aver scoperto i numeri irrazionali mettendo così in crisi le loro concezioni? Per arrivare fino a tempi più recenti, quando William Burroughs, giocando con una pistola a fare Guglielmo Tell con la testa di sua moglie, lui che non sbagliava mai, la uccide, e non per finta.
Avvenimenti certi (forse), spesso compiuti per dabbenaggine o senso di potenza infinita.
Alla fine dello spettacolo, che si gode davvero gioiosamente, sembra di essere andati a spasso per il tempo, vagabondando con curiosità ogni parte del globo.
Rimane comunque un groppo in gola vedendosi rappresentati sul palco: un essere umano che, per sembrare di essere felice, anche solo un attimo, ha la sola possibilità di illudersi di poter padroneggiare la vita, quando invece basta una briciola perché l’ingranaggio si fermi e lo faccia ripiombare alla triste realtà: essere una piccola informe parte dell’infinito.
Noi, esseri senzienti, riusciremo mai a provare a ricomporre quanto abbiamo distrutto nei secoli, smontando le false narrazioni che abbiamo inventato e riuscendo finalmente a voltarci, proiettando quindi il nostro sguardo verso un futuro realizzabile? O ci limiteremo ad osservare la grande balena bianca che alla fine compare sul palco? Che non è certo Moby Dick, il coacervo di meraviglie che faceva così ammaliare il capitano Achab, semmai un triste reparto gonfiabile che non serve proprio a niente.
Mario Bianchi, Krapp’s Last Post
Ma questa, come si suol dire, è un’altra storia. Quella che va raccontata – ammesso che sia possibile una sintesi – in questo articolo è la visione vertiginosa e non riduzionista, ma soprattutto intelligente e comica, che la compagnia del Sotterraneo affresca nel suo ultimo spettacolo, “L’Angelo della Storia”. Concepito come una serie di vicende giustapposte tra loro, spesso assurde ma del tutto indicative della temperie dell’epoca in cui sono incastonate, lo spettacolo procede per scene veloci, a volte fulminee, che ci permetto di saltare nel tempo assieme al gruppo di attori, dalla preistoria al presente, cercando una “ricomposizione dell’infranto” che, va da sé, è praticamente impossibile ottenere. Dal busto di Lenin posizionato nel polo dell’inaccessibilità antartico alla piaga del ballo di Strasburgo, passando per gli infiniti parti della regina Eleonora per dare un erede maschio all’Inghilterra, fino alla morte di John Wayne, forse causata dalla prossimità ai test nucleari in Nevada, quello che si disegna è un circo della storia non riassumibile, a cavallo tra il carnevale e la danza macabra, dove tutti noi, in fondo, siamo come il tenente Onoda (citato anche lui), il soldato giapponese che si rifiuta di arrendersi anche se la guerra è finita, incapaci di inventare un modo nuovo di raccontare le cose. Già, perché forse c’è un filo rosso che lega questi avvenimenti surreali è proprio l’attitudine a concepire il mondo in forma di mito, quella peculiarità della specie sapiens che le ha permesso di conquistare il mondo. È stato lo storico Yuval Noah Harari, nel suo libro bestseller “Sapiens”, a spiegare con dovizia di esempi come in fondo ciò che permetta agli esseri umani di cooperare sia la condivisione di un mito: religioso, politico, esistenziale. Il mito ci fornisce la mappa neurale adatta a spiegare le cose e a interagire con esse, anche se, con l’alternarsi dei secoli, finisce per sbiadire ed essere meno comprensibile agli umani del futuro, evolvendosi e modificandosi così come fa il linguaggio. La teoria del mito di Harari aleggia sullo spettacolo che, non a caso, comincia proprio con un gruppo di sapiens che si aggira nella foresta, diecimila anni fa, intravedendo una tigre dietro ogni fruscio delle piante: l’arte di saper sopravvivere, l’arte di prevedere ciò che potrà accadere, l’arte – in fondo – di convivere con l’ansia dei possibili disastri che incombono su di noi. Quell’ansia che, certe volte, rischia di trasformarsi lei nella bestia che ci mangerà. Se c’è un aspetto ritornate nelle mitologie distanti e difformi delle epoche della storia dell’uomo è il ricorso al mito, alla sua capacità di elargire senso, alla sua abilità a ricondurre i gesti più assurdi nell’ambito di un’imprevista (e a tratti commovente) coreografia della storia.
Lo spettacolo del Sotterrano ha il pregio di essere non solo ironico e complesso, stratificato e intelligente, ma soprattutto ha la forza di riconnetterci con la nostra animalità. Che non va intesa come un’affermazione new age sugli istinti repressi, ma come la dimensione biologica che la nostra specie occupa in un vasto e complesso ecosistema che contribuisce a manipolare e non sempre per il meglio. Lo fa con acume e con gusto del paradosso – come quando racconta del coniglio verde ottenuto con modifiche genetiche richieste da un artista brasiliano, oppure raccontando la storia assurda dell’uomo che si è lanciato con un razzo, morendo, per dimostrare che la terra è piatta – ma è un’ironia che serve, in un certo senso, a rassicurarci mentre ci addentriamo in una vertigine profonda che scardina le nostre convinzioni più prossime, più quotidiane. La vertigine ridimensiona il mito, ci mostra la fallacia delle nostre credenze e delle nostre reti neurali, ma allarga almeno un po’ lo spettro del visibile. Un gesto di cui abbiamo tutti urgente bisogno.
Graziano Graziani, Stati d’Eccezione
Il noto filosofo Walter Benjamin, col suo marxismo riletto attraverso suggestioni ebraiche e la sua cifra stilistica frammentaria (per riproporre il frammento come carattere specifico della modernità), scardina nelle sue Tesi di filosofia della storia la concezione progressista della storia, erede della visione cristiano-paolina di un tempo lineare e cronologico. Partendo dall’immaginifico Angelus Novus di Paul Klee, Benjamin ci pone davanti alle mute macerie della storia osservate da un angelo sgomento il quale, sospinto verso il futuro, vola con lo sguardo rivolto al passato. Qui, l’unica redenzione possibile è quella offerta dalla memoria: solo serbando il ricordo delle vittime, e perciò testimoniando della loro dipartita, dell’insensatezza della loro sconfitta e delle loro sofferenze, si può interrompere il giogo del «tempo mitico» dei vincitori, ovvero la visione della Storia ufficiale che resta ancora all’ipotetico e incontrovertibile «dato di fatto» escludendo l’ambito delle «possibilità non date». Il fulcro essenziale delle sue tesi, dunque, è l’inversione del tradizionale rapporto tra passato e presente: se solitamente abbiamo sempre concepito il presente come la risultante di un flusso di eventi che proviene dal passato, Benjamin concepisce il passato come l’altra faccia del presente, derivante e prodotto da esso. È il presente che genera dal suo interno il proprio passato, e il passato non può sussistere indipendentemente da un presente che lo testimonia e lo redime.
Per invertire questo rapporto così dominante, dunque, il filosofo deve farsi «pescatore di perle», concentrandosi su ciò che gli accademismi ufficiali e la Storia dei vincitori hanno sempre tentato di marginalizzare e relegare all’angolo. Ed è proprio questo che fanno (riuscendoci) i Sotterraneo nella loro ultima fatica, L’angelo della storia. Convinti del fatto che la scena sia «un luogo di cittadinanza» in cui allenare «la coscienza critica del pubblico», i pluripremiati interpreti della compagnia fiorentina reperiscono le singolarità degli avvenimenti al di fuori di ogni finalità monotona e li spiano dove meno li si aspetta e «in ciò che passa per non aver storia» (i sentimenti, l’amore, la coscienza, gli istinti), evitando di tracciare la curva lenta d’una evoluzione bensì ritrovando le diverse scene in cui questi avvenimenti hanno giocato ruoli diversi.
Attraverso un linguaggio teatrale fatto di simultaneità e ingegnosità, i cinque interpreti di Sotterraneo mettono in scena una vera e propria «mappa del paradosso», trasportando un pubblico rapito ed estatico in una corsa a perdifiato lungo i meandri di una Storia che spazzolano convintamente contropelo: passiamo infatti dalle cavernosità proto-artistiche del 10.000 A.C. al genetismo post-naturale fosforescente del 2000, dall’autoimmolante nazionalismo giapponese del 1970 all’isterismo coreutico di una Strasburgo del 1518, aprendo e mai chiudendo delle «crepe nel cervello» che mettono in discussione i modelli di realtà assunti di volta in volta dai nostri compagni di specie sapiens.
Traducendo in gesto scenico un pensiero filosofico invero complesso, con L’angelo della storia i Sotterraneo riescono a immaginare e ad agire un rapporto soggetto-storia aperto e problematizzante, che non si risolve in una passiva accettazione del dato ma che, creando quelle che Benjamin chiama «immagini dialettiche», riesce a rivelare i processi che li hanno determinati, le loro intenzionalità profonde, i loro valori allegorici e le opportunità che da esse sprigionano. Come sostiene lo stesso filosofo nei Passages, infatti: «non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l’ora in una costellazione. In altre parole: immagine è dialettica nell’immobilità. Poiché, mentre la relazione del presente con il passato è puramente temporale, continua, la relazione tra ciò che è stato e l’ora è dialettica: non è un decorso ma un’immagine discontinua, a salti. – Solo le immagini dialettiche sono autentiche immagini (cioè non arcaiche); e il luogo, in cui le si incontra, è il linguaggio» e, qualche volta, anche il teatro.
Francesco Chiaro, Persinsala
Sotterraneo figura nel novero di quei quindici Artisti Associati con cui il direttore Claudio Longhi intende tracciare le linee del nuovo triennio. I tre spettacoli presentati (Shakespearology, il già premio Ubu Overload, e il nuovo L’Angelo della Storia) confermano senz’altro che la compagnia possiede la caratura intellettuale e la maturità artistica idonee a questa sfida.
L’ultimo capitolo del trittico, che ha debuttato la scorsa estate al festival Inteatro di Polverigi, è in particolare una piena prova di maturità. Nella raffinata drammaturgia che prende le mosse da Walter Benjamin, da Yual Novel Harari e da altri pensatori per procedere poi del tutto autonoma, Sotterraneo dispiega davanti agli occhi della platea una costellazione di eventi storici senza reciproca connessione: dall’assassinio di un pitagorico dissidente nel 500 a.C., passando per una riunione segreta di partigiani nel 1943, fino alla morte di un terrapiattista nel 2020.
Lo schizofrenico viaggio nel tempo back and forward è scandito da date che campeggiano su un tabellone al neon, dalle parole metronomo dei cinque attori in scena, e da folgoranti tableaux vivants costruiti come epifanie oniriche.
Sono i morti, i fallimenti e le macerie della storia che – Benjamin docet – continuiamo a compiangere e poi a calpestare, slanciati a tutta velocità e di malavoglia verso futuro e progresso.
Ma a legare come un filo in visibile tutte le vicende rievocate ne L’Angelo della Storia, cucite in una composizione scenica rigorosa e calligrafica, è soprattutto una riflessione sulla potenza del racconto per l’essere umano. Convinzioni personali, modelli di realtà, auto-convincimenti: asserragliati nelle nostre convinzioni, assomigliamo tutti un poco a Hiroo Onoda, quel soldato giapponese che continuò a combattere per trent’anni ignorando che la guerra mondiale era finita da un pezzo.
«Uscire dal racconto – chiosa la drammaturgia tra il serio e il faceto – significa quasi sempre morire». Quale funzione resta dunque al teatro nella visione di Sotterraneo? Tempio del mito fin dall’antichità, luogo per eccellenza delle storie, oggi può diventare invece il
luogo per decostruire finzioni e per mettere in discussione certezze. Intelligente, ironico, sulfureo, il teatro di Sotterraneo si fa dunque soprattutto palestra di paradosso, allenamento al dubbio.
Maddalena Giovannelli, Il Sole 24 ore
Che un gruppo di quarantenni indaghi, da più di un decennio, quello che Julian Barnes chiamerebbe “il senso di una fine”, non può infatti passare inosservato. Era ancora un 2007 ignaro delle crisi economiche a vedere il debutto di Post-it, surreale pièce sulle conclusioni – di qualsiasi romanzo o della nostra vita – che terminava, sulle note di Atrocities di Antony and the Johnsons, con uno struggente decesso. Due anni più tardi, Dies Irae metteva in scena piccole e grandi estinzioni, e nel 2014 War Now! affabulava intorno a quella Terza Guerra Mondiale che oggi non sembra più così improbabile: ovunque – disseminati a margine di creazioni che esploravano altri nuclei di significato, oppure li ponevano al centro dell’attenzione – i segni di una morte prossima, di un’apocalisse imminente, emergevano dal discorso scenico di Sotterraneo con toni sarcastici, quasi divertiti.
Con Overload era infine la stessa scomparsa del gruppo, vittima di un terrificante incidente stradale, a essere evocata sul palco: una morte che non avrebbe concesso a nessuno di crescere, di lasciare alle spalle i privilegi e le ansie della gioventù, finanche di diventare un protagonista della scena teatrale nazionale. Quel pericolo è felicemente scampato, eppure ad agire nell’arte di Sotterraneo permane un’amara coscienza della finitezza, un disincantato ma irresistibile cinismo in virtù del quale irridere qualsiasi vago desiderio sul tempo a venire.
È una comprensibile difficoltà a immaginare il futuro, proprio o addirittura della nostra specie, che accomuna il gruppo composto da Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa a tanti altri autori, è un disagio ad abitare lo spazio del sogno, un’inclinazione per la catastrofe, un’ossessione per il tempo perduto verso il quale – si pensi anche alle creazioni di Marco D’Agostin – lo sguardo è costantemente rivolto. Come l’Angelus Novus di Paul Klee, un’intera generazione di artiste e artisti sta guardando soltanto al passato, intuendo che il domani verso cui ci stiamo muovendo sarà edificato su un presente di macerie.
Al celebre acquerello, a partire dalla visione del quale Walter Benjamin elaborò le proprie tesi di filosofia della storia, è dedicato L’Angelo della Storia, la nuova produzione di Sotterraneo che ha chiuso la settimana al Piccolo Teatro Grassi. Quell’esile figura sospinta senza requie verso il futuro, le cui ali si dispiegano al di sopra delle rovine sedimentate dalle epoche, fu per il pensatore berlinese l’ipostasi stessa del tempo violento e folle, oscuro e disperato, che calò sul mondo nella prima metà del Novecento; per i Sotterraneo essa è anche una chiave d’accesso a una riflessione sulla narrazione, sulla nostra coazione al racconto, sulla volontà di costruire storie.
E la drammaturgia, firmata da Daniele Villa, inanella con vertiginosa perizia i più disparati aneddoti, senza apparente legame tra loro se non una macabra quanto irresistibile ricorrenza di morti – suicidi di massa, decapitazioni, annegamenti, stragi – e una correlata tendenza, per gli sfortunati protagonisti degli episodi, a fidarsi e affidarsi ai racconti come vie di fuga dal vicino collasso. Su un palco vuoto sul quale si stagliano soltanto due flightcase e uno schermo di luci al neon in funzione di datario, a essere vivificati dall’ensemble sono così piccoli stralci biografici di figure gigantesche – Eleonora di Castiglia, Yukio Mishima, Ippaso di Metaponto, Carla Capponi – o di ignoti e bislacchi individui – uno strenuo terrapiattista, un addetto ai sistemi missilistici nucleari sovietici – colti in quei frangenti esistenziali che più sembrano manifestare l’esatta natura di un’epoca e di un mondo.
Sono microstorie, vicende che, come insegnato dal magistero di Carlo Ginzburg e Giovanni Levi, possono tuttavia illuminare le pieghe più oscure e nascoste del loro tempo: così Troffea, l’abitante di Strasburgo che per prima nel 1518 fu preda di una danza isterica che a poco a poco contagiò centinaia di persone e si protrasse per settimane, tradisce i turbamenti e le ansie sociali di un anno contraddistinto da carestie e tensioni politiche; così John Wayne, indifferente al pericolo rappresentato dai test nucleari svolti a poca distanza dal set di The Conqueror, mostra il prezzo di una fanatica adesione all’american dream. La scrittura non procede tuttavia con linearità progressiva, quanto per un rizomatico processo di sovrapposizione: le storie si rincorrono e si sfrangiano, defluiscono l’una nell’altra, esplodono in schegge di esistenze reali o fantastiche.
Con L’Angelo della Storia, Villa si impone come una delle voci più acute della nostra drammaturgia, alla quale – complice il ricorso a processi di scrittura scenica – per troppo tempo non è stato, colpevolmente, accostato: eppure la sua significativa capacità di fondere approccio filosofico e comicità avant-pop, l’attitudine a stratificare prospettive al di sotto dei giochi linguistici, il gusto nel mutuare strutture combinatorie dall’universo ipertestuale – già emersa in Overload – appaiono esemplari all’interno del panorama nazionale.
Ciò che Villa tesse è un arazzo di parole e immagini, i cui singoli fili narrativi si dipanano da un solo nodo – un primordiale tentativo di sfuggire all’assalto di una tigre dai denti a sciabola – e a un nodo solo tornano – una caverna di platonica memoria, sulla quale imprimere scene di caccia o le impronte delle mani – ma che nel procedere si accumulano con chirurgica efficacia, delineando una tavola sinottica che affastella ere e giorni, vite e ideali. E che infine mente, romanza, getta un velo di contraffazione sulla verità storica, scegliendo la strada del verosimile e poi dell’inverosimile, dell’innocua menzogna.
Al di sopra di questo millimetrico lavoro di drammaturgia, l’estro del gruppo costruisce una macchina scenica impeccabile: poche, misurate soluzioni registiche costituiscono il fondale sulle quali il lavoro attorale, mai così accurato, erige una teoria di azioni drammatiche, che si susseguono senza transizione. Frammentari, i lacerti biografici sono raccontati e progressivamente ricomposti dall’ensemble, ricorrendo a un tono espositivo documentaristico, storiografico: agli eccellenti Sara Bonaventura e Claudio Cirri – tanto rigorosa e cerebrale l’una, quanto sornione l’altro – si affiancano una volta ancora Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini. La loro partecipazione alle creazioni del gruppo, quasi un ingresso effettivo nel collettivo, ha costituito un felice modello di crescita, forse anche di sopravvivenza, della compagnia: e sembra necessario sottolineare quanto l’apporto interpretativo dei tre – la dirompente fisicità di Santolini, la soffusa grazia di Guerrini, quella malinconica ironia colma di dolore di Pennati – abbia arricchito la tavolozza dei Sotterraneo con sfumature recitative inedite.
I cinque combinano siparietti danzati con sequenze di improbabile canto corale o di beatboxing, dipingono quadri viventi, trasformano il palco sotto gli occhi degli spettatori, abitandolo ora con un’imponente balena gonfiabile, ora con una straziante immagine plastica dell’Angelus. Ormai pienamente padroni dell’arte dell’engagement, e perfettamente a proprio agio con il ricorso allo spettatore come latore di effetti teatrali imprevisti, i Sotterraneo limitano qui l’intervento del pubblico chiedendogli uno studiata partecipazione sonora: le sveglie di centinaia di cellulari suonano all’unisono 53 minuti dopo l’inizio dello spettacolo, restituendoci la straziante attesa vissuta da Benjamin a Portbou, quando una telefonata senza risposta lo convinse dell’imminente cattura da parte dei nazisti.
Convinzioni errate e cieche persuasioni, ipse dixit, teorie alla quali soggiacere con spirito più religioso che scientifico, costituiscono d’altra parte il fil rouge delle decine di storie affrontate, la cui costellazione delinea un feroce saggio sui modelli di realtà grazie ai quali interpretiamo il mondo e dai quali ci facciamo guidare nelle nostre azioni. Più che una violenza cieca e brutale, a uccidere i protagonisti degli aneddoti è l’incapacità di immaginare un paradigma diverso, è la caparbia adesione a un racconto – sia esso la teoria pitagorica, o la superiorità morale del Giappone dei samurai – al quale ciascuno ha prima dedicato e infine sacrificato la propria, irripetibile vita.
Ed è qui che L’Angelo della Storia opera uno scarto ulteriore, confermando la grandezza dell’operazione eseguita dal gruppo e distillando una preziosa ambiguità di fondo. “Ogni volta che la scrittura acquista spessore, il testo si sposta dall’intento primario e suggerisce orizzonti più ampi, se non contraddittori”, afferma Walter Siti in Contro l’impegno, e qualcosa del genere accade con L’Angelo della Storia. Allo spettatore permane il dubbio, parzialmente silenziato dalla mirabolante esperienza percettiva, che la narrazione – e stricto sensu, il teatro – non sia poi un’arte salvifica, che le notti di Shahrazād siano solo un’illusione, e che questo pervasivo storytelling, nel quale siamo immersi e che noi stessi alimentiamo, sia esso stesso una pena capitale.
“L’uscita dal racconto” implica quasi sempre la morte, ci ricorda Sara Bonaventura, eppure ci scopriamo a sospettare che Mishima non si sarebbe suicidato, che il terrapiattista sarebbe ancora vivo, che le balene non si sarebbero spiaggiate – se soltanto non avessero creduto al racconto. Sarà forse per questa ragione che, nell’erigere la grotta sulle cui pareti i primi sapiens iniziarono a disegnare, i Sotterraneo devono celare alla vista il palcoscenico: cancellando, per brevi istanti, tutte quelle storie che da millenni, là sopra, ascoltiamo.
Alessandro Iachino, Doppiozero.com
Sul fondale in alto un grande display manda a ciclo continuo una serie di date, simbolicamente tarate sugli avvenimenti presi in considerazione quali detonatori di un fraintendimento di senso che fissa una geografia possibile e dove il non detto e la verità relativamente alla Storia “organizzano” una linea di demarcazione opaca e personale del suo racconto, quel racconto fatto di biografie e scossoni epocali e che il pensiero estetico di Walter Benjamin ha delegato a suo tempo all’opera d’arte: è solo un’apparenza mistificante? La sua totalità di significato, d’altronde, si realizza nella frammentarietà dell’esercizio artistico, ragion per cui polverizzato dal tempo. E in questa accelerazione e ripensamento del tempo storico, frammentario e mappato come un “atlante” percettivo (nell’intuizione di Warburg, appunto), nel lavoro di Sotterraneo L’Angelo della Storia si avvicendano gli albori dei sapiens nella versione ricordata da Yuval Noah Harari, la spasmodica attesa della nascita di re Edward II d’Inghilterra (emblema non secondario nella cultura novecentesca, vedasi la versione teatrale di Christopher Marlowe più volte adattata nell’ambito della “ricerca” e quella cinematografica di Derek Jarman), il gatto erede di un patrimonio e il combattente giapponese Shōichi Yokoi rimasto nella giungla per ventotto anni, senza sapere che la guerra fosse finita, a presidiare una postazione inutile. Opzioni, dettagli della Storia, come lo sono le riunioni clandestine dei partigiani nell’appartamento di Carla Capponi nascoste dal suono del pianoforte e lo swing come refrain di un ultimo festoso e paradossale fotogramma prima dell’abisso di ghiaccio del Titanic che cola a picco (un immaginario più cinematografico che reale, ovviamente), oppure quanto l’auto-rappresentazione degli umani sulle pareti delle caverne o la decisione di non schiacciare quel bottone del soldato sovietico Petrov, salvando così l’umanità da una catastrofe atomica. Sono soltanto opzioni, si diceva, nell’opacità della Storia, informazioni temporanee che il gruppo “rilascia” allo spettatore in un crash della memoria, soggettiva e collettiva. Poco dopo l’inizio dello spettacolo ci viene chiesto di impostare il timer del nostro cellulare a cinquantatré minuti precisi, ovvero poco prima della fine; segniamo così una ulteriore nostra, personale narrazione di un tempo istantaneo, fermandone la durata, l’ossimoro, molto benjaminiano, del tratteggiare i dettagli e destreggiarsi in essi che definiscono la Storia quale ricognizione del passato nel leggere il presente. Scrive Benjamin: «C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese.
L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta» (1). L’angelo effimero di Paul Klee ha una rimembranza degli angeli della tradizione talmudica, quella trasparenza profondamente ebraica che Benjamin coltivava con l’amico Gershom Scholem, in una definizione apertamente dialettica con la propria identità, con alle spalle e sulle spalle una memoria ineludibile, che marca un modo di stare al mondo, e lo sguardo proteso, uno sguardo verso l’altrove e dov’è importante fermare l’istante che si sta attraversando. L’Angelo della Storia è Benjamin, il suo suicidio al confine tra Francia e Spagna nella fuga dai nazisti, ancora un frammento di cui si è a conoscenza, un documento segnalato dal display. Rimane una grande balena spiaggiata sul fondo, un pachiderma gonfiabile lì come un qualsiasi detrito di questo tempo dilapidato, un residuo abbandonato in scena o forse quel Titanic che non può affondare (Francesco De Gregori docet) o lo stesso Benjamin, corpo ingombrante, sproporzionatamente ingombrante. La scrittura è splendidamente convulsa, seziona con fulminea agilità andate e ritorni temporali facendo collimare tutto e i performer hanno una grande capacità di tenere la barra nell’architettura a scomparti che fa vivere microfoni, un ventilatore come oggetto “trascendente” e uno spostamento nel “ballo” e movimenti non dichiarati ma esperiti in quanto altri felici dispositivi scenici.
Paolo Ruffini, Limina Teatri
Siamo nella foresta dove l’uomo primitivo vive in uno stato di vigilanza tale da reagire istintivamente a ogni fruscio come possibile pericolo imminente perché “noi sapiens trasformiamo la realtà in un racconto già quando camminiamo nella foresta 10000 anni prima dell’anno zero. Il racconto ci fornisce un modello di realtà utile per sopravvivere: secondo questo modello ogni fruscio nel fogliame, ogni ramo spezzato, ogni movimento d’aria è sempre un predatore”. Altra data, altra gestione spaziale del ring dove si combatte questo match a suon di racconti. 1943, Roma, notte. Siamo nella casa di Carla Capponi, intellettuale antifascista, che ospita una riunione clandestina di partigiani e teme che i vicini o i passanti, sentendo i rumori della discussione, chiamino la polizia. Per coprire questi rumori suona al piano i “Notturni” di Chopin. Le note ci conducono in quell’atmosfera sospesa, tra paura e desiderio. E così via, circostanze assurde si alternano come in una centrifuga: alcune sono note, altre ai limiti dell’irrilevanza ma il tutto si mescola e trasforma sotto ai nostri occhi in una playlist, in una coreografia che a grandi balzi attraversa le storie tanto in maniera sincronica quanto diacronica. Non il semplice susseguirsi di fatti che attraversano le epoche – dunque – quanto una fotografia della realtà, disegnata dall’intuito di una compagnia che tenta di catturare l’istantanea sfocata della storia dell’essere umano.
Perché dunque sarebbe non solo importante ma fortemente consigliato portare delle classi a vedere questa ultima opera dei Sotterraneo? Per avere l’occasione di essere di fronte a una hystoria incarnata, alla possibilità cioè di vedere alcuni nostri simili porsi in ricerca. Storia nel suo significato etimologico allude al vedere. Vedere per sapere, vedere per conoscere. E dunque vedere degli adulti, professionisti, mettersi in gioco, in un corpo a corpo serissimo eppure divertente, cercando (forse vanamente) se non di afferrare, almeno di affrontare questo nostro oggi confuso, complesso, aperto a trasformazioni e trasformismi, ci allena a osservare questo nostro mondo e osservandolo, affrontarlo nelle sue complessità, nelle sue asperità. L’assenza di linearità inoltre è una occasione alla quale sovente gli studi di storia a scuola non ci abituano, troppo spesso ancorati a una visione falsamente consequenziale, fintamente lineare, artificialmente uniforme, lì dove sappiamo che se cause e conseguenze scatenano e conseguono a degli eventi, molti accadimenti intrecciano e confondono i piani, mescolano le carte.
Far sperimentare al nostro sguardo una dimensione di incertezza (narrativa, estetica, linguistica) mediata dalla lente di ingrandimento dell’arte ci fa comprendere che anche questa dimensione è una possibilità del reale. Che sia il teatro a sussurrarci nelle orecchie è elemento di ulteriore spaesamento, una feconda sospensione dell’incredulità e una spalancata porta d’accesso al dubbio.
Agnese Doria, Altre Velocità
Camuffandolo dentro un dispositivo che aggancia, avvince e incalza, mettendo in scacco con ingannevole piacevolezza l’equazione per la quale solo la seriosità è garanzia di profondità. La pedanteria, del resto, non è nello stile di questo gruppo che prevede parecchie intelligenze in azione insieme, moltiplicando possibilità, prospettive e competenze.
Più che una compagnia, un habitat adatto alle biodiversità. I crediti, da questo punto di vista, dicono parecchio: creazione di Sotterraneo, ideazione e regia di Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa, nucleo storico che nel tempo si è aperto a collaborazioni, frequentazioni, diramazioni, non necessariamente teatrali ma per riportarle comunque al teatro. Lorenza Guerrini, Daniele Pennati e Giulio Santolini, già in scena per Overload, tornano anche per L’angelo della storia. Con Bonaventura e Cirri compongono il cast di una partitura scenica piuttosto stupefacente, Villa resta dietro le quinte: è colui che di fatto scrive e garantisce il fatidico occhio esterno, ma Sotterraneo è appunto un collettivo. L’approccio è intellettuale, epistemologico e filosofico – supponiamo la loro biblioteca molto fornita, di classici e di contemporanei – ma è allergico all’esibizione saccente. La postura è adatta ad assorbire la fantasmagoria di stimoli di questa nostra epoca imbizzarrita e satura ma senza farsene intossicare. Affacciati sulla fine del mondo e, come vedremo, su quella della storia, introiettano l’apocalisse sopravvivendole anche con l’umorismo.
Si impossessano dei codici della comunicazione del nuovo millennio e li piegano ai loro fini che, al contrario, sono all’altezza di un umanesimo in via di estinzione. Hanno un rispetto quasi sacro per le parole, pur contaminandole spavaldamente con gli slang, la koiné dei social, gli anglismi pop, le sintassi spurie. Cercano il teatro dove meno te lo aspetti, perché, come Ronconi, sanno che può nascondersi ovunque, persino in un talk sulla sociolinguistica.
Ma veniamo all’Angelo della storia, titolo che dichiara il debito verso Walter Benjamin e le sue Tesi di filosofia della storia mediate dal quadro di Paul Klee, Angelus Novus. «Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo.» – scrive Benjamin – «Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo». Smentita la dialettica storica secondo Marx, aggiornamento materialista della teleologia cristiana, l’umanità arranca per accumuli disordinati di macerie. Dentro questo orizzonte, Sotterraneo compone una drammaturgia a frammenti (modalità per altro cara anche a Benjamin, che la riteneva l’unica espressione possibile della modernità) che si irradia sfondando l’ottimismo della linearità: del processo storico e di quello teatrale. Sul fondo della scena un grande display funge da calendario luminoso che aggiorna avanti e indietro nel tempo le date di vicende assemblate senza nessuna connessione apparente, vere e false, apocrife e aneddotiche, piccole e grandi, stupide e tragiche. A dar retta a Fukuyama, ma prima di lui a Kojève, la storia si sarebbe compiuta nel XX secolo. O forse no. E dunque il Medioevo di Eleonora di Castiglia e dei suoi sedici parti prima di generare il maschio adatto al trono d’Inghilterra, l’Italia fascista di Carla Capponi che suona tutti i Notturni di Chopin per coprire le voci di una riunione clandestina di partigiani, l’isola delle Filippine dove un tenente giapponese continua a combattere solitario fino al 1974, l’addetto al controllo delle attività nucleari americane in un bunker di Mosca. Nella smisurata e pressoché infinita enciclopedia degli eventi citabili, la differenza la fanno l’arte della scelta e la maestria del montaggio. Il seppuku tutt’altro che da manuale di Mishima, i pitagorici che affogano Ippaso di Metaponto, colpevole di aver teorizzato i numeri irrazionali minando l’armonia dell’universo, l’epidemia di ballo nella Strasburgo del 1518, il gatto che eredita milioni di euro, l’astronauta dilettante e terrapiattista con razzo casalingo, gli ufficiali delle SS incaricati di abbellire con delle piante i forni crematori di Auschwitz, la spedizione sovietica in Antartide per piazzare una statua di Lenin, lo strafatto William Burroughs che giocando a Guglielmo Tell uccide la moglie. Sugli stessi episodi, incrociandoli con gli altri, si torna a velocità diverse e variazioni continue, ogni giorno, mese e anno è «unico e irripetibile». Un’ovvietà che potrebbe essere smantellata. C’è anche Benjamin, in fuga dai nazisti. L’appuntamento con la notte del 26 settembre 1940 quando si uccide in una pensione al confine tra Francia e Spagna arriva con la collaborazione degli spettatori, a cui 53 minuti prima è stato chiesto di programmare i timer dei loro telefoni. Che suonano tutti insieme, come la telefonata del consolato americano arrivata troppo tardi. Le date si accavallano, si sovrappongono, si accostano per incongruenze e paradossi, si incuneano nello scarto di senso e nei millenni dell’evoluzione dei Sapiens, inchiodati dall’inizio dei tempi all’idolatria del racconto. Che è sempre correzione, mistificazione, consolazione, aggiustamento dentro i paradigmi e i modelli di realtà con cui ostiniamo a organizzare il mondo per dare un senso alla nostra presenza sul pianeta Terra. A tutto questo corrispondono la compattezza, la precisione e l’implacabilità dell’esecuzione performativa. Nel vuoto della scena, dove compaiono una balena gonfiabile, coniglietti verde fluo, l’angelo con le ali gonfiate da un ventilatore, i cinque protagonisti innervano una partitura di azioni, traiettorie, geometrie a incastro, sincronie e diacronie, coreografie, anatomie composite. C’è sempre il gusto della parodia, ma con una raffinatezza resa possibile solo da un controllo assoluto della scena e dall’affiatamento di chi la abita. Come se tanto lavoro di testa avesse stanato anche i corpi, portandoli alla ribalta non solo come veicoli del discorso ma come esigenza potenziata e imprescindibile dell’atto teatrale. Oltre il virtuosismo tecnico, a colpire è l’organicità corpo-mente, grande utopia novecentesca che Sotterraneo sembra ritrovare come punto di partenza per una nuova ecologia del teatro.”
Sara Chiappori, La Falena
ATLANTE LINGUISTICO DELLA PANGEA
I Sotterraneo si collocano al polo opposto rispetto alla silenziosa Chiara Bersani. Quasi a riprendere il modus operandi dell’ultimo spettacolo corale, il celebre Overload (2017), Atlante linguistico della Pangea cavalca di nuovo la postmoderna discontinuità logica. Se però allora l’appoggio narrativo era un’indagine-racconto ispirata alla vita e alle opere di David Foster Wallace, adesso l’elemento coagulante è ancora più tenue da un punto di vista drammaturgico: percorrere alcune parole straniere, intraducibili e prive di un corrispettivo in lingua italiana. Come per altro accadrà anche nella performance di Michikazu Matsune, le parole (con la lingua di provenienza e le loro definizioni) saranno proiettate sullo schermo centrale, mentre sul palco esse verranno agite, “illustrate” attraverso situazioni performative unite dal semplice scorrere delle parole. È proprio questa significazione interpretata, incorporata, realizzata e perciò smascherata logicamente a costituire una delle cifre stilistiche di Sotterraneo, attorno cui si sviluppano spettacoli di altissima qualità.
Questo allontanamento dalle lingue occidentali, questo scavo ironico sui segni e la realtà è rappresentato dal viaggio dei cinque performer, che appaiono in veste di campeggiatori. Fra giochi ironici, richiami pop, playback, canzoni e coreografie disneyane, i Sotterraneo tengono gli sguardi incollati alla scena, sciorinando una tenuta dei tempi e una ritmicità senza eguali. Il dispositivo parola/significato/azione permette al collettivo fiorentino di avanzare senza retorica, ma anzi di costruire un processo non privo di momenti alti, in cui il sorriso si blocca di colpo. È il caso di quando Lorenza Guerrini (in scena insieme a Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Pennati, Giulio Santolini) si chiede «posso pensare qualcosa che non formulo in parole? Se non la definisco, vuol dire che non esiste?». Questi agganci più o meno diretti al portato filosofico dell’argomento linguistico da un lato dimostrano l’ampiezza della ricerca e l’attenzione teorica dei Sotterraneo (che nel video Pangea calling, un documentario sulle ricerche alla base dell’Atlante linguistico, si spinge ad esempio fino a un Derrida particolarmente polemico con l’insegnamento scolastico), dall’altro danno il senso di un argomento davvero troppo grande per un solo spettacolo. La denuncia del colonialismo linguistico e la scomparsa di parlanti nativi, ad esempio, si ritrova in un momento molto delicato e sospeso, che poi viene subito sommerso nel magma postmoderno della performance.
Fra le macro-aree filosofiche che si aprono e si chiudono in uno spettacolo apparentemente semplice e ironico, quella su cui più giocano i Sotterraneo ci rimanda ancora a Overload: la lingua come rappresentazione del reale. Il rapporto foucaultiano fra parole e cose, l’ordinamento e la gerarchizzazione logico-formale della realtà nella cultura occidentale vengono esplorati e smontati attraverso l’espediente performativo dell’agire la significazione. All’interno di questo gioco esplorativo, i performer espongono allo stesso tempo il potenziale creativo e i rischi oppressivi della logica grazie a una trama debole, a un dispositivo scenico i cui contenuti non concorrono a un significato unitario. Atlante linguistico della Pangea si muove fra due poli: da un lato una lingua poetica (nel senso di poiesis, creatrice, nutrice di realtà), dall’altro una lingua che controlla e costringe la realtà in maglie da cui è difficile poi uscire.
E mentre in una delle ultime scene i Sotterraneo “parlano” con l’ultima parlante di una lingua che per filologi e linguisti è già scomparsa e archiviata, lo spettatore si domanda: cosa si stanno dicendo, davvero?
Riccardo Corcione, Stratagemmi
Qui adesso toccherà tirar fuori un po’ di fuffa critica su lingua, parole, importanza della parola nel contesto sociale.
Fuffa: Merce dozzinale, di scarsissimo o nessun valore. Figurato: Chiacchiera senza alcun fondamento o significato, discorso risaputo, luogo comune. Es: “I blog sono pieni di fuffa”.
Allora mi incuriosisco, e cerco l’etimologia di fuffa.
Secondo il dizionario De Mauro è da cercare nel sostantivo maschile fuffigno, che indica un ingarbugliamento dei fili di una matassa o di un tessuto.
Ma come? È una delle prima parole che viene presentata (ma in tedesco) in Dizionario illustrato della Pangea, la produzione ERT di Sotterraneo, il cui debutto era originariamente previsto a novembre 2020 e poi sospeso a causa della pandemia, e ora programmato allo Storchi di Modena per la ripresa della stagione. Esiste in tedesco una parola traducibile come l’azione dell’aggrovigliare oltre, nel tentativo di sbrogliare una matassa.
Al succo dello spettacolo: vengono proiettate su uno schermo parole di varie lingue del mondo, quelle la cui traducibilità è quasi impossibile, perchè incarnano la descrizione di una visione del mondo stesso, dello spazio emotivo umano, delle relazioni fra l’uomo e ciò che lo circonda.
Un gruppo di attori, i quali a un certo punto della recita si autodefiniscono «borghesi che propongono uno svago ad altri borghesi», sviluppa azioni che hanno per lo più relazione anticipata o ritardata con le parole proiettate.
Si parte quindi da un elenco di parole intraducibili nella lingua italiana e si cerca di darne spiegazione attraverso la rappresentazione, l’azione teatrale, la perifrasi logorroica.
Una sorta di resa al senso fulminante della parola, quando questa è precisa, appuntita.
Ora l’effetto didascalia fisica, ora il ritardo, ora l’anticipazione dell’azione scenica in relazione alla parola proiettata di cui si cerca di rendere il significato drammatizzato, creano un generale effetto di appuntita e goffa ironia, che sfocia nella intellettuale riflessione finale su quanto si vada a smarrire nella perdita dei dialetti, delle lingue, delle espressioni specifiche, quando la torre di parole e ricchezze geospecifiche cederà il passo all’esperanto anglofono planetario.
Un’ardita costruzione plurimillenaria di verbi, sostantivi, aggettivi crollerà sotto il peso di una banalizzazione lessicale, di una disperante perdita di valore, inestimabile: è come il fine di vita dell’ultima anziana depositaria di una lingua che con lei morirà, e che avverte la solitudine di non poter realmente parlare con nessuno nella sua lingua natale. Buio.
Senza troppa fuffa e anche con un’indulgenza al lirico nel finale, si potrebbe dire essere questo il senso di Dizionario illustrato.
Come loro stessi raccontano all’inizio della replica, doveva essere programmato l’anno scorso, ma poi… e qui toccherebbe riproporre la solita solfa dei teatri chiusi, del tempo sospeso, del bisogno di ricominciare, del teatro indispensabile, ecc.
Lo spettacolo viene ora riprogrammato con in scena Claudio Cirri e Giulio Santolini di Sotterraneo e gli attori della Compagnia permanente di ERT Paolo Minnielli, Maria Vittoria Scarlattei e Cristiana Tramparulo.
L’idea della creazione era nata dalla lettura di un libro durante il primo lockdown (forse Lost in translation ed. MarcosYMarcos?); poi ci avevano preso gusto, dopo aver individuato più di 200 realia (in lessicografia sono appunto i termini intraducibili), e a ottobre 2020 hanno lanciato una call su Facebook per arrivare agli idiomi più difficili da rintracciare.
Videointerviste con gente di tutto il mondo, che in alcuni casi vengono anche riproposte in scena. Incontri con tantissime lingue, comprese quelle parlate in territori o da popolazioni assai circoscritti, come Tuareg e ‘Ōlelo Hawaiʻi, fino a quelle appunto in estinzione, come lo Yaghan.
Vengono in mente i genitori della generazione precedente alla mia, i settantenni di oggi, il loro bisogno di affrancamento dalla cultura contadina, il loro voler segnare una distanza rispetto al dialetto, visto come lingua dell’arretratezza, dell’economia povera.
La lingua segue i poteri: si sceglie di parlare una lingua per costituire un potere, oppure per opporvisi. Per entrare a far parte di una comunità. Darsi una identità.
Sotterraneo pare darci ragione quando nelle note del foglio di sala leggiamo:”La ricerca e lo studio di questi termini nella fase iniziale di progettazione e il lavoro sul palcoscenico poi, ha messo in luce quanto il linguaggio sia un elemento essenziale per l’uomo per descrivere e creare la realtà in cui vive”.
Detto dunque dello spettacolo, del suo significato, della scena povera con i tradizionali oggetti o elementi mobili capaci di costruire piccoli ambienti immaginari, come in tutti i lavori di Sotterraneo dal fulminante Post-it di un decennio fa ad oggi; detto dell’estetica che come allora prevede il forsennato dentro e fuori dalla scena e la recitazione al bordo del finto vero o del vero finto; tutto quello che dovessimo aggiungere sarebbe un po’ fuffa.
Ma mentre scrivo vengo incuriosito dal vocabolo basorexia. Corro a cercarne il significato.
E penso che molto dell’intraducibile con una sola parola abbia a che fare con le emozioni che non si riesce a tenere a freno: in lingua inuit iktsuarpok significa “il senso di aspettativa che ti spinge ad affacciarti ripetutamente alla porta per vedere se qualcuno sta arrivando”.
L’intraducibile è sempre al confine, e di solito va oltre noi stessi.
Renzo Francabandera, PAC Paneacquaculture
A moltiplicare il linguaggio e l’immaginario riesce anche Atlante linguistico della Pangea di Sotterraneo (in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati e Giulio Santolini; scrittura di Daniele Villa), un lavoro ispirato alle tante “parole intraducibili” che esistono nelle lingue del mondo, ovvero a quei concetti racchiusi in un solo termine che hanno bisogno di un’intera frase per essere tradotti in qualsiasi altro idioma. Prima di entrare in platea assistiamo a un video coi dialoghi che la compagnia ha registrato nei mesi precedenti tramite videocall con diversi madrelingua in svariate parti del mondo, discutendo di questi concetti e della loro portata universale, nonostante appartengano a specifiche culture. Dietro a una semplice parola ci sono infatti mondi, popolazioni e costumi: alle Isole Trobriand, buritilaula significa “confrontare le proprie patate per risolvere una disputa”; in finlandese, poronkusema indica “la distanza che una renna percorre prima di fare pipì”; in tedesco, Vorfreude è “la pregustazione di un piacere che deve ancora arrivare”. Una volta che noi spettatori siamo seduti in platea, gli attori entrano in scena con zaini e attrezzature da campeggio: indossano le mascherine (che non si toglieranno mai durante tutto lo spettacolo), si spalmano il gel igienizzante sulle mani, allestiscono il loro accampamento e srotolano un planisferio, chiedendosi come il mondo stia affrontando la pandemia. Subito siamo proiettati indietro al lockdown della primavera 2020, momento dichiarato di gestazione dell’Atlante linguistico della Pangea, e lo spettro del Covid-19 aleggerà durante l’intera messinscena: in più momenti dello spettacolo gli attori si avvicinano a un’estremità del palco e scrutano l’esterno, ricordando gli eterni momenti in cui siamo stati tutti costretti a restare chiusi in casa e potevamo guardare il mondo solo attraverso la finestra, ma anche impersonando la parola inuit iktsuarpok, “il senso di aspettativa che ti spinge ad affacciarti ripetutamente alla porta per vedere se qualcuno sta arrivando”. L’intero lavoro è infatti impostato sulla messa in scena stessa delle parole intraducibili: con la sua consueta e coinvolgente cifra stilistica composta da tanti brevi quadri dall’ironia cinica e profonda, Sotterraneo costruisce rappresentazioni che ruotano intorno ai concetti linguistici proiettati sullo schermo nello sfondo (per esempio per rappresentare la parola giapponese tsundoku, “mettere sullo scaffale un libro appena comprato insieme agli altri ancora da leggere”, gli attori raccontano le loro esperienze personali di libri acquistati e mai aperti mentre impilano un’altissima torre di volumi, che a un certo punto inesorabilmente crolla), ponendo anche in relazione tra loro concetti di lingue diverse per aprire ulteriori e arguti squarci speculativi, e nel farlo si toccano questioni complesse e attuali come il ruolo dell’arte («forse sono solo una persona del ceto medio che intrattiene altre persone del ceto medio», dice uno degli attori durante lo spettacolo), i funzionamenti del linguaggio e della mente («puoi davvero pensare a una cosa, se non hai le parole per dirla?») e soprattutto l’importanza di preservare la biodiversità: affermando nel finale che «la scomparsa di una lingua implica la scomparsa di una visione del mondo», Sotterraneo nell’Atlante linguistico della Pangea compie un atto politicamente ecologista nel ricordarci l’urgenza di evitare l’estinzione dei linguaggi e per riflesso delle specie, di cooperare tra esseri umani adoperando le reciproche differenze come ricchezza anziché come limite, di svincolarci dal nostro innato egocentrismo come approccio necessario per costruire un “mondo del dopo” più complesso, multiforme e pertanto ecologista.
Come afferma ancora Carl Lavery in Performance and ecology: what can theatre do?, il teatro può definirsi eco-critico quando ha «la capacità immanente di influenzare i corpi, individualmente e collettivamente», a proiettarsi in «prospettive future ecologicamente progressiste» e «mutamenti di comportamento verso immersioni estatiche e incantate nell’ambiente e nella natura»: in questo senso, i nuovi spettacoli di Marta Cuscunà e Sotterraneo riescono ad attuare l’urgenza di contagiare gli spettatori con pensieri e stimoli per aiutarci a concepire il mondo in maniera più problematica, multipla e complessa rispetto a come siamo abituati a considerarlo.
Alex Giuzio, Altre Velocità
Parole intraducibili, parole che sono specchio di una civiltà e che non trovano corrispondenza verbale in una cultura diversa da quella da cui germogliano. È il caso di tukka in finlandese: branco di renne. Ubuntu nella lingua bantu è la consapevolezza che una persona è tale solo negli occhi dell’altro. O ancora in olandese gezzeling è il senso di benessere che si prova stando con le persone care… Sono queste alcune delle parole che compongono l’Atlante linguistico della Pangea dei Sotterraneo.
Quello che ora è uno spettacolo nasce durante il lockdown, nasce dal desiderio di continuare a viaggiare, nasce dalla voglia di andare in cerca di quelle parole che sono esclusive, che rispecchiano una cultura, un mondo. Tale bisogno è scattato nel momento in cui l’intero pianeta si trovava a vivere una condizione di condiviso e comune isolamento. È come se i ragazzi di Sotterraneo nel momento in cui la pandemia costringeva tutti a vivere la medesima condizione siano voluti andare in cerca delle parole che ci rendono diversi, dei lemmi che raccontano di un’unicità e che abbisognano di una frase per essere tradotte in un’altra lingua. Per questo i Sotterraneo si sono messi alla ricerca delle parole intraducibili e hanno interpellato persone che potessero spiegare il senso e l’uso di quei lemmi unici in tedesco, piuttosto che indi o nella lingua bantu. Ne è fuoriuscito un racconto video che ha documentato la condizione di lockdown da Covid, senza per questo parlare di Covid.
Tutto ciò è poi diventato uno spettacolo, un viaggio ironico e spiazzante, in cui gli attori/performer di Sotterraneo danno corpo e leggerezza alle parole, con zaini da viaggio chiedono allo spettatore di fare un giro intorno al mondo non in 80 giorni, ma inseguendo quei vocaboli intraducibili che raccontano di una condizione, che dicono di un groviglio di fili elettrici indistricabile come il tedesco kabelsalat, oppure di pile di libri che aspettano di essere letti, tsundoku in giapponese. Daniele Villa insieme a Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini danno vita a un lavoro graffiante, comico, ironico, capace di far sorridere e immalinconire, in grado di avere una grande leggerezza e al tempo stesso non temere la profondità del ragionamento. Atlante linguistico della Pangea è un esercizio di intelligenza, è un appello alla complessità, alla tutela delle diversità, alla conservazione del linguaggio e delle parole in tutte le loro sfaccettature con lo stupore che danno solo il desiderio vero di conoscere e la vertigine del mettersi in discussione. Questo i ragazzi (ci scuseranno… ma sono sempre ragazzi per la freschezza dei loro volti e sguardi) lo sanno fare bene, lo incarnano con allegria e un po’ di irriverente sarcasmo su ciò che diamo per assodato: possedere un linguaggio. E come sempre l’applauso non è che un ringraziamento all’intelligenza di un gruppo di artisti che sa lavorare di cervello e di cuore. Bravi!
Nicola Arrigoni, Sipario
SHAKESPEAROLOGY
Di una shakespearologia, non a caso, si tratta: una risultante performativa di un approccio scientifico al proprio oggetto di indagine, un discorso che dal padre del teatro moderno prende le mosse, e che a esso sembra circolarmente – e doverosamente – tornare. È forse possibile immaginare il teatro senza William Shakespeare? Se la risposta negativa a questo interrogativo retorico sembra scontata, Sotterraneo sembra qui condurla alla sua più radicale conseguenza: lungi dall’essere soltanto necessario, l’autore dell’Amleto – ma anche delle bistrattate Allegre comari di Windsor – è qui eletto a condizione sufficiente dello spettacolo. Accantonati il sovraccarico di idee e il ritmo vorticoso di Overload, con Shakespearology il collettivo fiorentino mette in atto un processo sottrattivo, che riduce gli elementi scenografici – uno sgabello nero, decorato con una stella bianca – così come la varietà di soluzioni testuali, qui ricondotte a un dialogo tra le voci registrate degli stessi Sara Bonaventura, Daniele Villa, Claudio Cirri, e l’unico attore in scena. Evocato come un fantasma dal sogno – comune a ogni donna e ogni uomo di teatro – di potere condividere con lui chiacchiere e confessioni, William Shakespeare appare sul palcoscenico vuoto con attitudine da rocker, l’outfit aggressivo di una star della musica, e una filologica gorgiera che ne incornicia il volto e l’iconica capigliatura. Oggi, forse, il Bardo racconterebbe così le proprie storie, come un cantautore maledetto o l’avventore bislacco di un bar; oggi Woody Neri, quasi irriconoscibile, dona corpo ed energia al più grande drammaturgo di tutti i tempi, virando ora verso le tonalità della stand up comedy, ora concedendosi squarci lirici e commossi.
Per meno di un’ora di durata – d’altro canto, come ci ricorda lo stesso Shakespeare quasi citando il tema cardine di Overload, la soglia di attenzione dello spettatore si è progressivamente e vertiginosamente accorciata – il drammaturgo, incalzato dalle domande, attraversa gli episodi salienti della propria vita: il matrimonio in giovane età, l’esperienza della paternità, il trasferimento a Londra, il crescente successo, la nascita della compagnia dei Lord Chamberlain’s Men e poi dei King’s Men. E tuttavia lo Shakespeare vulcanico di Woody Neri dileggia gli spettatori, affabula con compiacimento, mistifica e corregge le poche verità acclarate sul suo conto: inventa, come è naturale che sia, avventurosi episodi che sappiano conquistare la platea, ruba ad Anthony Burgess l’idea di un incontro fortuito con Miguel De Cervantes, inframmezza al racconto l’esecuzione alla chitarra acustica di classici quali Are You Lonesome Tonight? di Elvis Presley o Desolation Row di Bob Dylan.
È in queste frequenti aperture rizomatiche che Shakespearology tradisce ogni quieta aspettativa sul suo fulcro concettuale, e rivela di essere una surreale mise en abyme, un divertissement che illumina, più ancora che la biografia del genio di Stratford-upon-Avon, la sua sterminata eredità transdisciplinare. Il cinema, in questo senso, appare esserne la manifestazione più evidente, in grado di condurre verso inaspettati esiti kitsch anche la straziante morte di Mercuzio: replicata in uno spassoso playback, la sequenza di Romeo+Juliet di Baz Luhrmann ambientata sulla spiaggia di Verona Beach è occasione per Woody Neri di interpretare, con trascinante istrionismo, Leonardo di Caprio e John Leguizamo, per poi incarnare un’esilarante antologia delle più celebri morti che Shakespeare stilò per i suoi personaggi.
Ma Sotterraneo agisce il mash-up citazionista, a sua volta, come mero dispositivo atto a squadernare l’essenza stessa del “fare teatro”: ciò che Shakespearology compie, seppur nascondendosi sotto il mantello del più puro entertainment, è mostrare i meccanismi della costruzione drammaturgica, della scrittura del personaggio, della direzione degli attori, della creazione di una relazione con lo spettatore. A essere interrogato, più ancora che il fantasma di William, è lo statuto stesso di un’arte che da sempre sembra situarsi in pericoloso equilibrio tra la professione e la passione: oggi, così come nell’Inghilterra elisabettiana, sono la ricerca dei finanziamenti e il destino sempre incerto di uno spettacolo ad animare incubi e paure, a insinuarci il dubbio che in fondo il teatro non sia nient’altro che un azzardo. Eppure è al teatro che chiediamo, una volta ancora, di farci scoprire il rumore del mare: anche quando è a chilometri di distanza, anche quando non l’abbiamo mai ascoltato prima.
Alessandro Iachino, Teatro e Critica
«[…] Presentato in prima nazionale al Teatro della Misericordia di Sansepolcro, Shakespearology di Sotterraneo è un’incursione dissacrante ed esilarante nella figura di William Shakespeare e della sua arte, un one man show affidato al carisma e all’intensità interpretativa di Woody Neri. Sul palcoscenico vuoto, ad eccezione di uno sgabello nero decorato con una stella bianca, Neri in gorgiera e l’aplomb da rocker si fa avanti come un fantasma sbucato da un sogno e dialoga con le voci registrate di Sara Bonaventura, Daniele Villa e Claudio Cirri che lo incalzano di domande per riportarlo indietro agli episodi salienti della sua esistenza. Il matrimonio in giovane età, la paternità, il trasferimento a Londra, il crescente successo, lo Shakespeare di Neri canzona il pubblico con la sua narrazione compiaciuta e istrionica, inframmezzata da performance live alla chitarra acustica di grandi classici quali Desolation Row di Bob Dylan o Are You Lonesome Tonight? di Elvis Presley. L’eredità del Bardo ci conduce poi al cinema, con un’esilarante messa in scena in playback della morte di Mercuzio, replicando la sequenza di Romeo+Juliet di Baz Luhrmann. Neri intrepreta, al contempo, Leonardo Di Caprio e John Leguizamo, concedendoci, più tardi, una spassosa carrellata delle più celebri morti che Shakespeare ha destinato ai suoi personaggi. Dall’Inghilterra elisabettiana ai giorni nostri, con l’incertezza di un’arte, quella teatrale, in precariato continuo per la necessaria ricerca di finanziamenti. Shakespearology di Sotterraneo condisce l’orizzonte del divertissement con un affondo nei meccanismi stessi e nella pratica del fare teatro, messa in mostra, mentre è in azione, nei suoi dispositivi drammaturgici e di scrittura dei personaggi, nella relazione fra gli attori, nel coinvolgimento del pubblico. Un azzardo, il teatro, ieri come oggi, a cui però chiediamo ancora di farci scoprire l’ignoto.».
Valentina De Simone, La Repubblica
“Per riprendere fiato dopo le fatiche e i successi di Overload, i Sotterraneo si concedono un colto e ironico divertissement. Avete mai sognato di poter parlare a quattr’occhi con il vostro classico preferito? Daniele Villa (autore della drammaturgia) immagina un incontro ravvicinato con il Bardo, tra excursus biografici e folgoranti riflessioni sul senso del fare teatro. Sul palco, questa volta, c’è un solo attore un Woody Neri ispirato e trasformista che indossa con la medesima disinvoltura gorgiera e occhiali da sole. Claudio Cirri, Sara Bonaventura e Daniele Villa sono tre voci registrate che, quasi in stile Gialappa’s Band prima maniera, incalzano il Bardo one-man-show con domande, commenti e battute. Per il resto, il marchio di fabbrica Sotterraneo è ben riconoscibile, con il suo scanzonato citazionismo post-moderno: da Baz Luhrmann a Salinger, da Lord Chamberlain’s Men ad Anthony Burgess. Si ride, mentre si attraversa e si decostruisce con piglio surreale la vulgata didattica su Shakespeare – con tanto di infanzia a Stratford-Upon-Avon ed esordi artistici a Londra – e si passano in rassegna tutte le sue eufemistiche locuzioni poetiche per nominare l’organo femminile. Ma la voce e lo sguardo del re della drammaturgia servono soprattutto come lente per guardare il teatro, domandarsene ancora il senso, e per riscoprire la sua funzione; e si può spiare di nascosto l’effetto che fa spiegare a Sir William come funziona il sistema dei finanziamenti di oggi, o rivelargli che sulla scena contemporanea le storie sono un po’ passate di moda. L’ora di spettacolo scorre leggera (sarebbe bello che Shakespearology fosse visto da tanti giovanissimi), ma il nucleo è tutt’altro che superficiale. Aristofane, alcuni secoli fa, immaginò con Le rane di riportare sulla terra Eschilo ormai morto per dare consigli alla città e renderla migliore. Sotterraneo prova la stessa sfida, evocando “il più grande teatrante di tutti i tempi” per tentare di sottrargli il segreto di una forma d’arte sapiente e popolare, capace di arrivare a tutti senza perdere in complessità.”
Maddalena Giovannelli, Hystrio
«Shakespeare è come il mondo, o come la vita. Ogni epoca vi trova quello che cerca e quel che vuole vedervi». Così Jan Kott, nelle prime pagine del celebre saggio Shakespeare nostro contemporaneo. Parole che lustrano il mito e proprio per questo lo allontanano in un dorato, impalpabile empireo. Diversamente procede la shakespearologia, che, come ogni “logìa”, si articola nella raccolta e nella verifica di dati particolari, smascherando cliché e facili narrazioni. Farebbe così pensare a uno sguardo scientifico il titolo di Shakespearology, l’ultima fatica del collettivo Sotterraneo, visto al Teatro Biagi D’Antona di Castel Maggiore (Bologna) nell’ambito della disseminata rassegna territoriale di Agorà.
Come da titolo, la ribalta è tutta per il Bardo, cui dà corpo Woody Neri mattatore. Se nell’incredibile ciclo delle interviste impossibili realizzate da Radio Rai negli anni ’70 è mancata la puntata dedicata al drammaturgo inglese, ecco qui servito l’artificio: tutto quello che avremmo voluto sapere su Shakespeare ma che non abbiamo mai avuto la possibilità di chiedere, domandato per voce off da Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa. Un dialogo, dunque, che è in realtà un monologo, o meglio è un dialogo dissimulato con il pubblico, con l’inevitabile proiezione mentale che chiunque sia entrato in un teatro avrà elaborato a partire dai testi del Bardo.
Come ci figuriamo William Shakespeare? Belloccio, ma di una bellezza scavata da notti brave fra scrittura e gin nelle locande dei suburbs, dissimulante gli onori e la ricchezza conquistati? Con immancabili orecchino e gorgiera pseudo-elisabettiana, e nerovestito, di rimando alla melma delle strade intorno al Globe, o al cinerino cielo londinese? Sempre acuto, nostalgico, istrionico. Una sorta di moderna rock star, o forse più una rock star di venti-trenta anni fa, ché le ombreggiature maudit poco si addicono ai tempi di Instagram.
Tale e quale appare in scena Woody Neri, chitarra alla mano, cantando Are You Lonesome Tonight? di Elvis Presley o Desolation Row di Bob Dylan. Rivelando doti canore peraltro notevoli e straordinari cambi di registro fra brani di dolente intimità ed efficaci schemi comici. Cosa aspettarsi, d’altro canto, dallo spettro di un autore che dominava i generi della commedia, della tragedia, del dramma storico? Tanto basta dunque alla scena, che si riduce a quella maschera, uno sgabello e un porta-chitarra, in un allestimento minimo ed essenziale come un confessionale.
La necessità da cui tutto muove sembra chiara, ed è affidata alle parole che la stessa voce off di Cirri pronuncia citando Il giovane Holden: «Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere vorresti che l’autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono».
Ecco tracciata una cornice, una chiosa per lo spettatore: il desiderio di confrontarsi con un’icona, con un demiurgo della lingua teatrale stessa di una compagnia giovane in grado però di porsi fra i più incisivi agitatori della scena contemporanea. Un passaggio obbligato, una prova di maturità nell’unica forma possibile dell’invenzione necromantica (dato che i Sotterraneo non lavorano con testi a monte)?
Indubitabile, in effetti, che ogni teatrante abbia emesso i suoi vagiti con Romeo e Giulietta, o vagheggiato l’adagio amletico in qualche laboratorio adolescenziale. Forse anche perché in epoca moderna la materia shakespeariana si è prestata docilmente alla macchina da presa, con un picco di blockbuster sul finire degli anni ’90: da Romeo + Juliet di Baz Luhrmann con un puberale Di Caprio, a Shakespeare in Love di John Madden, passando per le più sobrie regie di Kenneth Branagh. Il Bardo, dunque, è diventato decisamente pop. E per capirne il motivo è sufficiente ricordare come «All the world’s a stage» appaia una profezia realizzata nella contemporanea società dello spettacolo. Ora, dal pop, è parso naturale ai Sotterraneo far spiccare al drammaturgo un salto ulteriore… nell’Avant-Pop. Termine che appare in ogni articolo, riflessione, comunicato stampa sul lavoro del gruppo fiorentino, a indicare un’arte che disinvoltamente rimesti materiali massmediatici (come i film di cui sopra) per corroborare nuove narrazioni, privilegiatamente digitali, open source, collettive. La finalità: una messa in discussione del circuito di consumo istituzionale dell’arte, dall’anello autore-produttore-consumatore a quello autore-partecipante interattivo.
Disegno in cui si inscrive pienamente l’interattivo e spiazzante Overload, premio UBU 2018 come Miglior Spettacolo; ma che illumina anche Shakespearology, sia pure in maniera meno lampante e strutturale.
Perché, attenzione, la scrittura di Sotterraneo è sempre disseminata di feconde trappole, giochi di specchi tagliati con la punta durissima dell’ironia: se la drammaturgia indica una direzione di senso, è per schiantarne, in fondo, l’autoreferenzialità, per estrofletterne la traiettoria e così mostrare, nella nuova curvatura, un paesaggio inaspettato. Se si delinea una cornice, è per trovarsene puntualmente al di fuori o, più spesso, a cavallo, con un piede di qua e uno di là.
Nel caso di Shakespearology, si perpetra un auto-sabotaggio performativo della stessa forma-dialogo impiegata, proprio secondo il progetto Avant-Pop di cui sopra. Invertire il circuito di consumo dell’arte, in tal caso, significa mettere alla berlina proprio l’impulso voyeuristico, vuol dire criticare la brama, ingannevole secondo questa prospettiva estetica, che ci fa evocare la funzione autoriale come medium necessario per relazionarsi a un’opera. Ebbene, quell’autore non sarebbe comunque conoscibile se non attraverso il gioco della biografia, che è sempre finzione e mai scienza.
Viene alla mente la battuta di Iago: «I am not what I am». Questo solo potrebbe dire, in fondo, un siffatto Shakespeare-personaggio. Ed è questo il discorso che sapientemente Woody Neri e Sotterraneo diluiscono nella scrittura, fingendo, solo per eluderle, pruriginose domande biografiche, tentativi naif di decriptare l’inconoscibile (come i sette anni misteriosi fra il matrimonio a Stratford e la fama londinese).
Quello di Sotterraneo non è, dunque, il tentativo di raccontare William Shakespeare, quanto piuttosto di reificare l’immaginario shakespeariano in un possibile William di cui tutto ciò che sappiamo è unicamente che non-è Shakespeare. Come nel caso di quelle inquietanti app che simulano l’avatar di una persona scomparsa, a partire dalla scrittura della stessa: ciò che il dispositivo della finzione non potrà restituire è esattamente l’io-sono del soggetto. Un dato di fatto che può essere indotto dalla banale constatazione alla critica performata di un format (come sempre nel caso di Sotterraneo), fino allo scuotimento della storia del linguaggio e dei costumi del teatro.
Si tratta infine di forme del racconto che esercitano un appeal proprio nella denunciata impossibilità del dialogo “fictionario”. In Shakespearology, questa piega sub-reale è occasione per mettere il linguaggio teatrale di fronte a se stesso, ai soggetti della scena (la parola, il gesto, il racconto, la maschera), esaltando la dimensione professionale, con le sue incombenze e i suoi regolamenti. Il personaggio-Shakespeare finisce per parlarci del duro lavoro di produrre a stretto giro drammi di ogni genere, che intercettino il favore del pubblico come quello del re. Circostanze decisamente metastoriche.
In tale dinamica la drammaturgia di Sotterraneo rivela la sua raffinatezza: nel corpus shakespeariano vaglia e seleziona alcune strutture compositive, le mette a nudo (qui sì con sapienza analitica) e ri-presenta in forma scherzosa ma puntualmente a servizio della concatenazione scenica. Come nella trafila delle morti tragiche che, spassosamente, Neri sciorina: da Macbeth a Desdemona, da Giulio Cesare ad Ofelia, un montaggio di scene del morire per preparare alla dipartita il già defunto Bardo.
Tutto qui? No, la scrittura di Sotterraneo non rinuncia mai a portare fino in fondo il suo puntuale auto-spiazzamento, a fare della scena un’irrisolvibile eterotopia. Compiuta la messa in crisi della forma scelta, Shakespearology chiude come ha aperto, risale nel segno della più smaccata curiosità che ci riconsegna alla fascinazione, tutta emotiva, per l’uomo dietro i capolavori. Shakespeare-Neri lascia la scena rilanciando quel dubbio più mitologico che storiografico, certamente marginale, ma ineffabilmente toccante: davvero il Bardo non ha mai visto il mare? (rumore di onde, sipario).
Andrea Zangari, PAC Paneacquaculture.net
Ordinario, regolare, solito: è normale tutto ciò che segue la norma, si conforma, aderisce al consueto. Per Kilowatt Festival 2019 (19-27 luglio) a Sansepolcro, in provincia di Arezzo, Partecipare è normale. Il manifesto della XVII edizione del festival ideato da Luca Ricci e Lucia Franchi, direttori dell’Associazione CapoTrave/Kilowatt, può descrivere o auspicare, diciamo, la (presa di) posizione dello spettatore, intendendola come la consuetudine ad esercitare attivamente il proprio sguardo. Forse, in caso, potrebbe essere ancora più appropriato l’aggettivo naturale. Da Aristotele in avanti si è capito che l’uomo è un «animale sociale»: partecipare è connaturato al nostro essere, per un verso o l’altro.
Certo, la normalità non si confà, invece, all’artista. La sua opera è degna di salire su un palcoscenico, di innalzarsi sopra gli altri e richiamarne l’attenzione, nel momento in cui rompe con la norma e indica le possibilità che stanno oltre, al di fuori del modo “prevalente”, del costume “più corretto” oppure, in alternativa, “più diffuso”. Aperture, prospettive, visioni che noi, dalla nostra altezza, non riusciamo a vedere.
L’insolito, l’irregolare, l’inconsueto, sono la materia di cui è fatto il racconto artistico, che, per questo, diventa esemplare, emblematico. È ciò su cui Pac ha misurato il suo metro di osservazione nel primo fine settimana di Kilowatt (19-21 luglio) e che qui riportiamo a proposito degli spettacoli di teatro. Alla strenua ricerca di chi rifugge il normale, soprattutto nella sua accezione più nociva: superficiale.
Un fantasma si fa avanti nel Teatro alla Misericordia. È il più grande spettro della scena, colui che ha creato personaggi più vivi della vita. William Shakespeare, infatti, non ha soltanto riflesso «la natura come in uno specchio»: ha inventato l’uomo, come sostiene il critico letterario Harold Bloom. Ha inventato me, te, ognuno di noi.
Dunque, anche i Sotterraneo. Con il rispetto e l’irriverenza di figli che hanno trovato la loro identità (non) ascoltando il padre, Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa, ribaltano i ruoli, le parti, e s’inventano il proprio Bardo in Shakespearology. Una “Shakespearologia”, cioè uno studio, una trattazione dell’opera attraverso la vita e dell’autore attraverso l’uomo.
Siamo di fronte a una pirotecnica scomposizione e sovrapposizione di luoghi, di situazioni e di tempi, che arrivano fino a ora, su questo palco. Un gioco a incastro che perfeziona e amplifica la portata dirompente del precedente Il giro del mondo in 80 giorni da Jules Verne.
Da solo, su uno sgabello «da pub» con una stella sullo schienale, Woody Neri è Shakespeare – peraltro abbastanza somigliante – e i suoi personaggi, incalzato dall’idea che il collettivo di ricerca teatrale ha dell’uno e degli altri, attraverso le domande registrate di Bonaventura, Cirri, Villa, che guidano l’azione da fuori campo.
È vestito di nero, ha occhiali tondi a specchio e una cinquecentesca gorgiera nera (costumi Laura Dondoli), come un attore, un’ombra, una presenza che, al pari di Maša ne Il gabbiano di Anton Čechov, porta il lutto per la sua vita.
Canta con verve da rocker maledetto, accompagnandosi alla chitarra, la popolarità di un Romeo e Giulietta o di un Otello con canzoni che vanno da Exit Music For A Film dei Radiohead a Che cosa sono le nuvole di Domenico Modugno. Ma tale finzione più vera del vero si è presa gli affetti, la famiglia: gli è costata tutto. Per avere più esistenze ha vissuto una vita al di fuori di sé. Shakespearology cerca di restituirgliela, dimostrando che ciò che lui ha perduto, in realtà, l’ha fatto guadagnare all’umanità intera.
Durante l’ora di spettacolo, la massima attenzione stimata dello spettatore (tema caro ai Sotterraneo e al centro del loro Overload, premiato con l’Ubu), Neri compie un vulcanico tour de force attoriale. Dolce e rabbioso, energico e delicato, ripercorre con ironia, venata di rimpianto, le tappe di una furia creativa che ha messo insieme la poesia con il successo. Stigmatizzando, di contro, la netta differenza dei giorni nostri, in cui le due cose appaiono inconciliabili, se non proprio impossibili.
Finiti la gioia e il furore, l’eccesso e il tormento, William Shakespeare ritorna sui suoi passi nel buio, come un Prospero senza più bacchetta. L’ultima magia è andare incontro al mare, che forse non ha mai visto, pur avendo vissuto sempre in Inghilterra. Il fragore di un applauso finalmente tutto per sé.
Matteo Brighenti, PAC Paneacquaculture.net
In prima serata Shakespearology che, nella forma, strizza ironicamente l’occhio a un format televisivo di successo (Mai Dire…) e, come sempre, anche in questa scelta stilistica si dà immediatamente la cifra dei suoi ideatori, Sotterraneo, che qui si avvalgono della presenza scenica di Woody Neri – il quale è, di volta in volta, mattatore, narratore di sé stesso e sagace provocatore. Le voci fuori campo, ottimamente utilizzate, danno il ritmo dello spettacolo aprendo squarci sulla Gran Bretagna all’epoca del Bardo, sulle dinamiche del piccolo borgo, ma anche sulla Londra elisabettiana evocata attraverso il brano Desolation Row, uno tra i tanti momenti musicali che fanno da contrappunto eppure ricreano il mood delle situazioni narrate. Vero e falso, aneddoti e dicerie, tessono il filo di una performance decisamente originale. Le provocazioni rispetto alle opere minori o all’essere più mercante che artista sono rintuzzate dal maggiore drammaturgo di lingua inglese a una a una, e sollecitano risposte a domande altrettanto imbarazzanti: “Cos’è il teatro contemporaneo? Con questo lavoro riuscite a mantenervi? Che genere di teatro fate e come definireste un Festival come quello che ci ospita?”. L’attualità entra in gioco e palesa, in poche incisive battute, tutte le difficoltà del settore, e di coloro che intraprendono questa strada con professionalità scontrandosi, quasi quotidianamente, con la scarsa redditività o addirittura la richiesta di prestazioni gratuite in cambio del proprio impegno. Non lascia un attimo di respiro, lo spettacolo, con sollecitazioni continue – tra passato e presente. La scenografia minimale è compensata dalla duttilità dell’attore – ottimamente assecondato dalle luci. Cantante e ballerino, Neri è in grado di stare al passo con i continui cambi di ritmo: le improvvise accelerazioni, i momenti d’introspezione, le restituzioni musicali che si intrecciano ai racconti – a volte epici, altre goliardici, senza dimenticare i rapporti con la famiglia, abbandonata a Stratford-upon-Avon, e con i potenti dell’epoca (Elisabetta I ma anche Giacomo I d’Inghilterra). Ma nella vita si muore solo una volta? Dipende. Se sei un drammaturgo, anche più volte e sempre in maniera differente. Alla fine rimane solo una domanda inevasa: “Questo, che teatro è?”. Al pubblico, la risposta. E la suddetta, al momento, è solo l’ultima, intelligente provocazione di Sotterraneo.
Luciano Ugge, Persinsala
Teatro Sotterraneo ha portato in scena al Funaro, in anteprima assoluta, “Shakespearology”, uno spettacolo “pop” che unisce autobiografia, indagine storica e letteraria, citazioni musicali e teatrali, dove la vita e le opere del Bardo – ma anche le profonde influenze che il suo teatro ha esecitato nei successivi quattro secoli – scorrono in una sorta di “chiacchierata impossibile” con “il più grande drammaturgo di tutti i tempi”.
Un one-man-show scritto da Daniele Villa dove William Shakespeare – interpretato dal bravissimo Woody Neri – entra in scena con chitarra e occhiali scuri, intona un pezzo rock, inizia a dialogare con le voci fuori campo che lo invitano a raccontare la propria vita, cercando di chiarire insieme a lui alcuni dubbi sulla sua biografia, di scoprire particolari nuovi, di soddisfare le curiosità del pubblico, che finalmente, dopo più di quattrocento anni, può godere di questo privilegio esclusivo e assoluto, di vedere dal vivo Shakespeare e, seppur per poco tempo, conoscere la sua vita attraverso le sue stesse parole.
È un dialogo serrato, a cui si accompagnano parentesi e divagazioni, ricco di “punzecchiature” e di osservazioni ora sarcastiche, ora piene di sincera ammirazione, che le voci sovrapposte degli attori fuori scena rivolgono al protagonista, in uno scambio rapido di battute un po’ nello stile della Gialappa’s. Shakespeare non si tira indientro: nei cinquantadue minuti dello show – un minuto per ogni anno di vita – il racconto della sua carriera teatrale, dalle origini provinciali all’arrivo a Londra, dai primi successi alla fondazione della compagnia dei Lord Chamberlain’s Men, dalla costruzione del Globe Theatre all’incontro con re Giacomo I, si intreccia con citazioni e riferimenti alle sue opere più famose, da “Romeo e Giulietta” a “La tempesta”, da “Amleto” a “Otello”, da “Macbeth” a “Re Lear”.
Tragedia e commedia, in entrambe le quali Shakespeare fu grande maestro, si riflettono nel tono del racconto e nel carattere stesso del protagonista, talvolta ironico, scherzoso e confidenziale, talvolta invece serio, riflessivo, malinconico. Ne emerge il ritratto di un personaggio complesso, del quale ancora restano molte cose da capire e da scoprire, ma che forse, dopo quattrocento anni, non si conosceranno mai. Sulla sua vita sono fiorite tante leggende, tante “tesi del complotto”, tante ironie che lo stesso Shakespeare, sentendole riferire, non può fare a meno di spazzarle via con una risata. Eppure la sua figura di drammaturgo e poeta è ancora centrale nella cultura occidentale e le sue opere hanno influenzato artisti, musicisti, registi e scrittori dell’età contemporanea: da Melville a Burgess, da Luhrmann a Pasolini, da Modugno a Bob Dylan, in tanti hanno visto nel Bardo un punto di riferimento e una fonte d’ispirazione.
Pur essendo riemerso dalla tomba dopo così tanti anni, lo Shakespeare di Sotterraneo è estremamente aggiornato sulla musica, sul cinema, sulla letteratura che hanno utilizzato le sue opere: un po’ meno, forse, sugli sviluppi del teatro “sperimentale” o “d’innovazione”, a proposito del quale avvia un gustosissimo colloquio con gli attori e i tecnici in sala.
Il pubblico segue con attenzione, il ritmo è veloce e tiene gli spettatori incollati all’azione, stimolando allo stesso tempo una crescente curiosità verso Shakespeare e il suo teatro: viene davvero voglia di conoscere, di leggere, di prendere in mano una sua opera e recitarla. Anche questo è un merito dello spettacolo, in grado di rivolgersi a un pubblico di tutte le età, mescolando diversi linguaggi artistici senza risultare mai pedante, ripetitivo o eccessivamente didattico.
Ma il tempo è ormai scaduto, è giunto il momento di morire di nuovo: “una cosa che mi riesce molto bene – afferma Shakespeare – nelle mie tragedie ho descritto decine di morti diverse!”. E mentre il Bardo si accascia sulla sedia, pronuncia le sue ultime parole, tratte dal finale de “La tempesta”: “noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, e nello spazio e nel tempo d’un sogno è raccolta la nostra breve vita”.
Andrea Capecchi, ReportCult
A seguire l’ultimo gioiellino dello scrigno di Sotterraneo, Shakespearology, interpretato da un magnifico Woody Neri – sempre in parte e mai mattatore – che dimostra quanto sia indispensabile una solida preparazione attoriale prima di salire su un palcoscenico, e come si possa poi scardinarla, padroneggiandola appieno.
Come una cipolla, l’ultimo spettacolo di Sotterraneo va pelato con cura perché possiede una serie di stratificazioni che lo rendono appetibile ai più diversi palati ma, nella loro complessità ben calibrata, hanno altresì la ricchezza di un bouquet da buongustai.
All’apparenza pop, con quel mix arguto di voci in stile Gialappa’s Band (interpretate da Sara Bonaventura, Daniele Villa e Claudio Cirri) e i rimandi musicali all’universo queer, pian piano mostra nuove facce: dal racconto epico del teatro elisabettiano al roast di un personaggio emblematico (ricordiamo l’Orson Welles Roast di Battiston ormai una decade fa), dalla tradizione del cunto in grado di ricreare interi universi al to play, inteso come tempo di gioco del fanciullo eracliteo. E ancora il j’accuse potente contro un mondo contemporaneo che ha svilito il lavoro dell’artista (ma anche di chiunque sia impegnato nella cultura in senso lato) riducendolo a hobby, gerantendo pari dignità all’amatoriale e al professionale, al volontario che fa un’esperienza di vita e all’attore, regista, scrittore o coreografo che dedica l’intera esistenza a quel preciso settore, impegnando il proprio tempo, investendo il proprio futuro, e pagandosi (prosaicamente) le bollette di luce e gas con i relativi compensi – sempre più magri.
Divertente, intelligente, con un ritmo preciso come quello di un orologio, in grado di far sorridere e pensare. Mai pedagogico eppure enormemente istruttivo.
Simona Frigerio, Traiettorie
A seguire un appuntamento imperdibile, la prima nazionale del nuovo spettacolo del collettivo fiorentino Sotterraneo. Shakespearology, un monologo sul più grande drammaturgo di tutti i tempi. Woody Neri è il tenebroso e malinconico bardo, elegante nell’impeccabile mise nera in cui viene intervistato dalle voci registrate dei componenti della compagnia, come una sorta di dialogo impossibile e serrato alla Mai dire…, il famoso programma televisivo degli anni ’90. Del resto da Sotterraneo ci si può aspettare di tutto, anche uno spettacolo in controtendenza con i canoni in cui viene da sempre (e per sempre sarà) interpretato William Shakespeare. Oltre la maschera l’uomo e oltre il personaggio un barbuto e stempiato performer dissacrante tanto con sé stesso e i suoi contemporanei che con la nostra, di contemporaneità. Caratteristica intelligentemente pungente della drammaturgia è infatti il capovolgimento dell’intervista al bardo, sbalordito dalle risposte dei suoi stessi interlocutori che dipingono l’attuale scenario teatrale italiano come poco (se non per nulla) remunerativo e invischiato in leggi e riforme che si mordono la coda. Shakespearology è il cilindro di un mago (un istrionico Woody Neri, sempre in parte per un’ora e un quarto di spettacolo) dal quale non esce semplicemente un coniglio, ma una sfilza di aneddoti e curiosità sdoganate, sviscerate, masticate attraverso doppiaggi cinematografici e canzoni interamente interpretate chitarra e voce dal performer, fino alla messa in scena del ruolo più paradossalmente difficile da interpretare per il più grande tragediografo di sempre, la propria morte. Uno spettacolo irriverente e dal ritmo incalzante, una semitragedia che restituisce un ritratto quasi inedito di Shakespeare, coniugandone con equilibrio dimensione professionale e umana, un one-man-show che tutti gli studenti di liceo (e non solo) dovrebbero vedere.
Erika Di Bennardo, Teatrionline
OVERLOAD
Anna Bandettini, La Repubblica
«Sembra di essere in un innocuo video-clip demenziale. E invece no.
Overload di Sotterraneo è “solo” la rappresentazione, ludica e agghiacciante, di un dato antropologico ormai conclamato: nell’era dei molteplici dispositivi digitali, la nostra soglia di attenzione si sta inesorabilmente abbassando e frammentando. 8 secondi contro i 9 di un pesce rosso. Aiuto!
In compenso siamo diventati multitasking. Ma a quale prezzo in termini di stress e di superficialità? L’overload (il sovraccarico) è in agguato e il rischio di non saper più distinguere la realtà virtuale dalla vita vera ormai quasi un dato di fatto. Questi, in estrema sintesi, gli spunti di riflessione alla base del nuovo spettacolo di Sotterraneo, costruito come un gioco con la partecipazione degli spettatori, pieno di aguzza intelligenza quanto beffardo nel propinarci un ritratto non proprio rassicurante di come ci stiamo evolvendo (o involvendo?).
A partire dal fatto che punto di partenza e di arrivo di Overload è la morte, forse l’unico dato di realtà a cui non si può sfuggire Primo a comparire in scena è infatti un tizio che dice di essere David Foster Wallace e tenta di raccontare la sua vita e il suo suicidio. Ma quanto siamo disposti a prestargli attenzione? Evidentemente poco se, non appena un altro degli attori alza il cartello con il simbolo di “contenuti nascosti”, chiedendoci se vogliamo attivare altri link, c’è sempre qualcuno che si alza in piedi per dire di sì e la scena cambia improvvisamente, facendoci sprofondare in un delirio di altre situazioni, connesse alla precedente anche solo per libere associazioni dettate da una parola. Ecco allora sfilare le microstorie, continuamente interrotte per passare ad altre, di Miss Universo, un pilota di Formula Uno, due tennisti, dei nuotatori, dei ballerini di hip hop, un Babbo Natale, un guerriero greco. due polli da combattimento ecc.
Ma quanto siamo noi a scegliere, in questo folle zapping mentale, e quanto invece stiamo mediaticamente manipolati? II ritmo è frenetico e le trasformazioni velocissime (chapeau agli interpreti!), non si fa neanche in tempo a ridere, e in generale a provare sentimenti. Finché, nell’ultima scena. smessi i panni dei mille personaggi, gli attori raccontano di come, usciti da teatro, siano morti tutti in un incidente stradale. E lì non c’è ipertesto che tenga».
Claudia Cannella, Hystrio
«[…] Per concludere, nel finale del loro spettacolo di Sotterraneo mette in scena una paura che tutti gli artisti in fondo hanno, una paura inconfessabile per scaramanzia e proprio per questo fantasmatica. Ma andiamo con ordine. «Overload», come racconta il titolo, scandaglia una delle tare più stringenti della contemporaneità: il sovraccarico di informazioni che ha portato la soglia di attenzione del genere umano ai minimi storici. Multitasking, concentrazione impossibile, sono tutti elementi studiati da scienziati e sociologi che stanno modificando le nostre coordinate cognitive (e secondo qualcuno arriverebbero persino a rendere del tutto impossibile una delle precondizioni su cui l’arte si è poggiata per secoli, la contemplazione).
Il Sotterraneo, per sondare questo aspetto, scomoda il fantasma di David Foster Wallace, autore geniale e maniacalmente attento al dettaglio nella scrittura, caratteristica che assieme al suo sguardo acuto sulla società americana e al suo talento letterario ne ha fatto un autore di culto. Al centro in un’ipotetica intervista all’autore morto – che è morto anche durante l’intervista e viene invitato a parlare del suo suicidio – c’è il famoso discorso dell’acqua che lo scrittore di Ithaca fece al Kenyon College, dove i pesci giovani non sanno cos’è l’acqua perché essendoci immersi totalmente non la sanno identificare. Forse anche Wallace, che teneva perennemente in testa una bandana (accessorio che lo rese un’icona anche visivamente) a causa dei mal di testa che lo assillavano, fu una vittima del sovraccarico delle società odierne, di cui pure fu uno dei massimi critici e cantori. È ormai un segno collaudato, quello del Sotterraneo, che mescola momenti di linguaggio televisivo alle deflagrazioni teatrali cronometrate al millimetro, che hanno il sapore della didascalia brechtiana senza essere noiosamente didascaliche. Ed è una lingua allo stesso tempo leggera e corrosiva, spinta al parossismo nella scena finale, quando la compagnia (ai membri storici Cirri, Bonaventura, Villa si sono aggiunti i bravi Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini) mette in scena la propria morte. In un buffo affondo metateatrale i ragazzi raccontano la fine dello spettacolo, il mettersi in macchina di notte, stanchi, l’auto che sbanda… insomma uno degli incubi per eccellenza di una comunità nomade come quella teatrale contemporanea, perennemente “overload” perché costruisce e smonta le proprie scene, carica e scarica i materiali, conduce i mezzi che usa. Quella comunità che è oggi un inno alla precarietà oltre che alla libera espressione (e forse le due cose combaciano non a caso). Ma in fondo a cos’altro serve il teatro se non ad evocare fantasmi?».
Graziano Graziani, Minima et Moralia
«Secondo un recente studio americano l’attenzione umana si starebbe avvicinando in modo preoccupante alla cosiddetta soglia del “pesce rosso”. Sostengono gli scienziati che il pesce rosso riesca a rimanere concentrato su un singolo stimolo o oggetto o azione, per non più di otto secondi. L’essere umano in questo momento storico raggiungerebbe una media di circa nove secondi. O per meglio dire, le nuove tecnologie (smartphone e computer) hanno predisposto i loro software per offrire impulsi ogni nove secondi, abbassando enormemente la soglia minima. Hanno scelto questo intervallo di tempo così breve, per avere più possibilità che il cervello, e il corpo umano, non si stacchi dalla macchina (smartphone o computer che sia). Può essere un segnale sonoro, un video, una finestra pop up, un messaggio o una notifica dai social, una mail eccetera. Ogni nove secondi accade qualcosa, in modo non così dissimile da quanto si sosteneva nei manuali di sceneggiatura dei film hollywoodiani. L’attenzione dello spettatore deve essere sollecitata continuamente, attraverso effetti speciali o colpi di scena narrativi o battute particolarmente spiritose, tutto questo perché il pubblico non si distragga. Adesso la differenza è che invece di manciate di minuti, si parla di secondi, e che al posto del consumo culturale si è sostituita la vita quotidiana. Si potrebbe poi aggiungere che non si vuole più intrattenere lo spettatore dentro una storia o una narrazione, ma si cerca di creare interruzioni al flusso del pensiero e di evitare la possibile sedimentazione della memoria. Già, ma cosa stavamo dicendo?
La notizia è uscita qualche mese fa e chissà se è vera. Sicuramente è credibile e i risvolti inquietanti sono sotto gli occhi di tutti. L’attenzione si è trasformata in una merce preziosa: più attenzione, più tempo, più soldi. Siamo nell’era dei neuroni specchio e di una pubblicità perenne che fa poco leva sulle fragilità dei desideri e che ha forse esaurito il serbatoio dell’inconscio. Si punta direttamente sui processi neurologici, sugli effetti delle sostanze psicoattive. I persuasori occulti descritti da Vance Packard sono materia da scuola elementare. Analisi e metodologie adesso vengono estrapolate da neuroscienze e psichiatria. Ed è per questo che si usano termini digitali anche quando si parla di fisiologia umana: il cervello oggi rischia l’overload, come i computer, cioè di andare in tilt perché sovraccarico di informazioni e di impulsi. Di tutto questo parla l’ultimo spettacolo di Sotterraneo, Overload, usando lo scrittore americano David Foster Wallace come Virgilio di un viaggio che è anche l’attraversamento di un’epoca: sintetizzatore delle tensioni e delle aspirazioni degli ultimi anni dello scorso secolo e in un certo senso precursore delle mutazioni in corso. Wallace è morto e si presenta al pubblico come tale. D’altronde sul palcoscenico i morti hanno la medesima cittadinanza dei vivi, ciò non crea nessun particolare problema. Ma non c’è solo la sopravvivenza teatrale di un personaggio defunto, si respira piuttosto la ludica permanenza di una figura assorbita nell’eternità digitale, dove i confini si fanno sempre più labili e si confondono nella persistenza delle immagini. Wallace vorrebbe parlare di “realtà”, o per meglio dire di come si può sopravvivere nell’epoca della saturazione delle informazioni.
Il discorso al microfono però viene interrotto continuamente da un performer che, con un cartello in mano, propone al pubblico di aprire un “contenuto nascosto”. In altre parole gli spettatori alzando semplicemente la mano possono far virare la narrazione in un’altra direzione, aprendo una nuova finestra, attivando il link. Nell’era offline, il motto fosteriano “only connect” aveva funzionato da guida sicura per creare confronti, accostamenti e portare avanti un ragionamento. Nei tempi 2.0 la possibilità della connessione si fa, più che tentazione, vero e proprio ricatto. Così il monologo di Wallace viene continuamente interrotto da nuove “finestre” sceniche che seguono una logica del tutto, o quasi, incongrua. Appaiono giocatrici di tennis, nuotatori, balli sfrenati, player di football, il tutto sotto lo sguardo di due pesciolini – meccanici – che nuotano nevroticamente dentro un acquario. È soprattutto il mondo dello sport a entrare prepotentemente in scena. L’impressione iniziale è che si riproduca la medesima dinamica del blob televisivo. Poi però la scena si allarga e alla sovrapposizione delle azioni si sostituisce la simultaneità, per una configurazione tridimensionale e analogica del processo di multitasking e del concetto di rete. È eccitante e divertente lasciarsi guidare in questo susseguirsi di assurdità e percepire una velocità di invenzioni che sotto il segno dello spreco e del consumo non lasciano tregua allo spettatore.
Sotterraneo è un collettivo nato una decina di anni fa a Firenze, che ha fatto della corsa e della velocità una cifra estetica. In La cosa 1, fra i primi loro lavori, ogni movimento sulla scena era compiuto di corsa. Sembrava che i performer-attori fossero costretti a muoversi incessantemente. La mèta di ogni affannata corsa era la definizione di una scenetta dai sapori comicamente deludenti. Microcostruzioni fallite, dialoghi disconnessi, sentimenti uccisi sul nascere da cinico autismo, crudeltà da guastafeste della domenica. In questo piccolo mondo la graffiante ironia e un’invenzione mai doma offrivano le uniche vie d’uscita, temporanee ma in fondo soddisfacenti.
Dieci anni dopo il discorso di Sotterraneo prosegue sugli stessi binari, aumentando di complessità e arricchendo e aggiornando il proprio immaginario. Si scrutano le mutazioni in corso sempre da un punto di vista biografico, che è anche generazionale. D’altronde l’idea dell’autoritratto ha avuto negli anni concrete trasposizioni sceniche: la vintage polaroid istantanea, la macchinetta fotografica usa e getta, il selfie del cellulare. Con Overload lo specchio della scena non vuole più ritrarre il pubblico, ma funzionare come lo schermo di uno smartphone o di un computer, dove la nostra immagine è totalmente scomposta in mille link, in disordinate analogie di interferenze pubblicitarie. Non c’è nessuno specchio nel quale sprofondare, perché lo specchio ha rubato l’io. L’inconscio che si riflette è stato chiaramente manomesso da qualcun altro. Allora rimaniamo ebeti e contenti. Sì, ebeti e contenti, perché come sotto l’effetto di una droga sofisticata, le nevrosi trovano uno sfogo facile, il mondo si contrae in pochi centimetri, e non c’è bisogno di molto altro. Finalmente autosufficienti.
Il merito di Overload – e di Sottoerraneo – sta soprattutto nella sfida di non aver paura di entrare nella bocca del lupo: lasciarsi attraversare da un policentrismo scenico vivace e potenzialmente ricco di sviluppi, tentare di inventare una propria lingua, che è una lingua di oggi, del nostro mondo, ma a suo modo resistente, ostinata. Il teatro, nel voler tradurre con i suoi antichi strumenti il mondo digitale sembra funzionare da antidoto, anzi pare quasi guadagnarci qualcosa, come tentativo di ibridazione e non perché si usino tecnologie sofisticate, al contrario, gran parte dello spettacolo in fin dei conti non è poi così lontano da una pantomima.
Lo specchio euforico che si costruisce sulla scena è fatto di carne. La consistenza del corpo umano, che è meravigliosamente imperfetto e vivo, non può nascondere i segni della fatica e dell’affanno, di un’energia pur sempre vitale. Lo specchio che si costruisce è quello di un’apocalisse quotidiana che ha anche il sapore inquietante della stupidità. La compagnia ha finito lo spettacolo e torna a casa in macchina con il proprio furgoncino. Niente di più vicino alla vita, niente di più quotidiano e ovvio. Così come niente di più comune è l’arrivo di un messaggino sul cellullare con irresistibile richiamo sonoro. È un attimo, un riflesso incosciente e immediato. Non è altro che uno dei tanti stimoli che ogni nove secondi riceviamo dai nostri supporti tecnologici. Ma arriva nel momento meno adatto, quando la stanchezza si fa sentire e il cervello non ha energie per sostenere nessuna opzione di multitasking che non sia tenere le mani sul volante e guardare la strada davanti a sé. È solo un attimo, quanto basta, per far sbandare l’automobile e mandare all’altro mondo il gruppo di attori. La scena è di grande impatto e costruita come una pantomima al rallentatore, in contrasto con tutto il resto dello spettacolo.
Nell’euforia generale della distrazione permanente, è la morte ad aprire e chiudere lo spettacolo: prima nelle vesti di un sorridente, intelligentissimo e suicida Wallace, poi nell’immagine inquietante di un incidente stradale. Potrebbe essere solo la trovata efficace di una pubblicità progresso, se non fosse che Sotterraneo distilla l’immagine alla fine di una corsa, la corsa nelle nostre reti, che è quella che viviamo tutti i giorni. Nel dibattito sull’uso degli smartphone anche a scuola, sarebbe salutare almeno che lo spettacolo venisse fortemente consigliato ai ragazzi e che fosse reso obbligatorio a professori, insegnati e genitori!»
Rodolfo Sacchettini, gliasinirivista.org
«Nel racconto si innescano continue divagazioni e amnesie, girando intorno al tema più che mai d’attualità della possibilità di una vita reale. Senonchè l’ascolto è continuamente frammentato, la scrittura prevede che gli spettatori possano richiamare dei “contenuti nascosti” quando compare l’apposito segnale. Sulla scena si proiettano allora una miriade di figure che in qualche modo si rifanno al mondo di Foster Wallace ma tradotto nel gusto pop del collettivo Sotterraneo. […] C’è soprattutto il richiamo ripetuto ad un mondo liquido che forse non è solo quello preconizzato dal filosofo Bauman. Fino all’apparire di un uomo pesce che può sopravvivere solo immergendo la testa nell’acqua dove nuotano i pesci rossi ma preferisce estinguersi pur di provare la gioia tutta umana di un ballo».
Gianni Manzella, Il Manifesto
«Per i fiorentini di Sotterraneo invece non c’è rinascita. Ironico e surreale, in Overload, imperniato sulla figura (e l’opera) di David Foster Wallace, accade di tutto, finanche la loro morte. Come in un giorno qualsiasi delle nostre vite. E finalmente sarà silenzio».
Mariateresa Surianello, Il Manifesto
«Overload di Teatro Sotterraneo è un gioco, molto serio eppure leggerissimo sulla distrazione e sull’attenzione, complice David Foster Wallace e il suo discorso per la cerimonia delle lauree al Kenyon college del 21 maggio 2005: Questa è l’acqua. Si crede che la riflessione messa in atto da Teatro Sotterraneo trovi una sua sintesi in un passaggio del discorso di Wallace, quando lo scrittore morto suicida afferma: «Vent’anni dopo essermi laureato, sono riuscito lentamente a capire che lo stereotipo dell’educazione umanistica che vi “insegna a pensare” è in realtà solo un modo sintetico per esprimere un’idea molto più significativa e profonda: “imparare a pensare” vuol dire in effetti imparare a esercitare un qualche controllo su come e cosa pensi. Significa anche essere abbastanza consapevoli e coscienti per scegliere a cosa prestare attenzione e come dare un senso all’esperienza. Perché, se non potrete esercitare questo tipo di scelta nella vostra vita adulta, allora sarete vera mente nei guai». La drammaturgia firmata da Daniele Villa e la forza attoriale di Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Marco D’Agostin mettono in scena la fenomenologia della distrazione e l’estinzione dell’attenzione. Sul discorso Questa è l’acqua Teatro Sotterraneo costruisce una sorta di ipertesto scenico, facendo del palcoscenico lo schermo di uno smartphone collettivo e chiedendo al pubblico di attivare il collegamento ipertestuali, i contenuti nascosti. Ne fuoriescono una serie di gag esilaranti, ma anche di inquietanti distrazioni in cui a farne le spese è lo scrittore David Foster Wallace e il suo discorso agli studenti.
Ciò che Teatro Sotterraneo costruisce – con ironia e leggerezza – è una riflessione acuta, intelligente, arguta e mai banale sull’ecosistema dell’attenzione, sulla capacità di riprendere il filo, sulla resistenza ai mille stimoli iconici, mediatici, distraenti a cui siamo sottoposti. Se possibile Teatro Sotterraneo con Overload dimostra una sua maturità di scrittura e di analisi accresciuta, sempre più capace di andare al cuore delle questione che il gruppo si propone di affrontare con momenti di straziante ed elegante poetica come l’abbraccio con quell’uomo pesce che nel suo mancare d’ossigeno tanto ci assomiglia, nel nostro vagare da un link all’altro in cerca di qualche verità, se va bene, oppure – nella maggior parte dei casi – in balia di uno stordimento collettivo e individuale che annichilisce ogni pensiero. Si esce da Overload divertiti e con qualche pensiero in più su cui riflettere, si esce coscienti della nostra debolezza e di come la frammentazione delle informazioni, la distrazione del pensiero e l’attenzione in via di estinzione ci consegnino ad un’incoscienza preoccupante, ci condannino a una incapacità di concentrarsi su ciò che realmente merita la nostra attenzione: l’essere uomini e nella nostra umanità condividere un’idea di mondo e di solidale rispetto dell’altro da noi.»
Nicola Arrigoni, Sipario
«Un sentimento di spaesamento cognitivo raccontato con efficacia dalla compagnia Sotterraneo in Overload, rappresentazione dell’attivare ossessivo di nuovi contenuti. Frammentazione babelica e soglia dell’attenzione inferiore a quella di un pesce rosso».
Magda Poli, Corriere della Sera
«Overload di Sotterraneo, come recita il sottotitolo, è invece un ipertesto teatrale sull’ecologia dell’attenzione. Anche qui tornano le caratteristiche precipue del gruppo: l’ironia paradossale che pervade la scena, il rapporto di sinergia e di sollecitazione con il pubblico.
Quanto può durare la soglia di attenzione dell’essere umano? Meno o di più di quella di un pesce?
Come cavia viene scelto lo scrittore americano David Foster Wallace, che entra in palcoscenico con le sue fobie, i suoi rimandi filosofici, frequentemente interrotto attraverso precisi avvertimenti da improvvisi accadimenti di grande divertimento, rapidi e stranianti, che il pubblico, alzandosi, può interrompere. Accadimenti repentini lontanissimi tra loro per consistenza e intensità, che rompono il flusso dei pensieri e che portano il pubblico verso mondi lontani da quelli evocati da Wallace.
Più straniante di tutti arriva il bellissimo finale, in cui il dovere dell’attenzione viene trasmessa in modo tragico, anche se ancora una volta paradossale, e a cui teatralmente partecipa l’intera compagnia che, finito lo spettacolo, in macchina, a causa di un incidente causato appunto dalla disattenzione, finisce tutta, incredibilmente, al creatore.
Uno spettacolo tragico non perché provoca morte, ma perché ci fa riflettere su come la mancanza di attenzione, in un mondo che va sempre più veloce, ci porterà inevitabilmente verso la distruzione e l’annientamento. Rimarrà solo un piccolo innocente pesce rosso?»
Mario Bianchi, Krapp’s Last Post
«Dopo aver scritto poche righe sul nuovo spettacolo di Sotterraneo Overload, mi è arrivata una mail e sono andato a leggerla. Poi ho ripreso, ma incuriosito da qualcosa che io stesso avevo scritto sono andato a cercare meglio su Google. Poi ho ripreso e dopo poco mi sono interrotto per dare un’occhiata a Facebook… Mi sono reso conto ormai da qualche anno della sempre maggiore frammentazione del mio periodo di scrittura: se prima riuscivo a scrivere ininterrottamente anche per ore, da tempo la mia scrittura è continuamente interrotta dalla facilità con cui posso – tra un pensiero e l’altro, tra una frase e l’altra – consultare qualcosa (di pertinente o no) grazie a internet. Un’esperienza che penso di condividere con tutti i ‘digitali’ che usano abitualmente e intensivamente internet e le sue possibilità. Una scoperta empirica che trovo suffragata da una ricerca della Microsoft di due anni fa che rivelò un dato piuttosto sorprendente: la capacità media di attenzione continuata degli esseri umani digitalmente attivi era scesa in 15 anni da 12 secondi (già incredibile di per sé) a 8 secondi. Considerando che la capacità di attenzione di un pesce rosso è di 9 secondi ci sarebbe di che allarmarsi. Eppure i ricercatori non la buttano sull’allarmante, anzi: la durata dell’attenzione si riduce, ma la capacità di fare contemporaneamente più cose aumenta, e questo risponderebbe a un’evoluzione antropologica evidentemente necessaria per vivere nell’epoca contemporanea. Questione evolutiva che evidentemente non si pone per i pesci rossi. E neanche per la pesciolina Dory di Alla ricerca di Nemo, che non rimpiazzava il deficit d’attenzione e di memoria con il multitasking, ma con un approccio alla vita inossidabilmente ottimistico e gioioso. Nove secondi ma vissuti appieno, verrebbe da dire, mentre sui nostri otto secondi graverebbe un sovraccarico di compiti e di sollecitazioni che rischiano di creare l’effetto opposto e di farci piombare nello stress, nell’ansia, nel senso di inadeguatezza. All’overload, al sovraccarico, Sotterraneo ha dedicato, appunto, il suo ultimo spettacolo, il cui meccanismo trasferisce in termini di azione teatrale le dinamiche di approccio all’esperienza cognitiva – o semplicemente relazionale – contemporanea: durante una scena compare un link e il pubblico può decidere di ‘cliccarci’ idealmente sopra, ben sapendo che questo comporterà uno switch, e quindi l’abbandono del discorso corrente per seguirne un altro. Insomma, Overload è uno spettacolo ipertestuale che racconta nel microcosmo della scena la trasformazione del mondo in ipertesto, e quindi la trasformazione della nostra esperienza in un terreno accidentato di continue interruzioni, che frammentano la conoscenza e al tempo stesso riducono sempre più la durata dell’attenzione. Non è un caso che l’unico elemento scenico permanente dello spettacolo sia una vasca con due pesci rossi, la cui attenzione a brevissimo termine è l’inevitabile pietra di paragone della nostra: la loro capacità di attrarre gli sguardi degli spettatori (richiamata anche durante lo spettacolo da una voce fuori scena) corrisponde all’attrazione che può generare uno specchio. Perché poi i pesci non solo non hanno attenzione, ma non hanno neanche percezione del loro ambiente: stanno immersi in qualcosa che non possono riconoscere, come noi siamo immersi (quasi) inconspevolmente in un contesto pervasivo che sta mutando la nostra evoluzione. Ci sono due giovani pesci che nuotano insieme e incontrano un pesce più anziano che dice: “buongiorno, ragazzi, com’è l’acqua?”; i due continuano a nuotare per un po’, e poi uno dei due chiede all’altro: “ma cosa diavolo è l’acqua?”. La storiella è stata raccontata da David Foster Wallace di fronte agli studenti del Kenyon College. E con questo abbiamo completato l’evocazione dei protagonisti di Overload: c’è un sedicente Wallace che ci racconta un certo giorno di settembre (il mese in cui lo scrittore si è suicidato), ci sono i due pesci rossi che non sanno di nuotare in un preciso ambiente, e ci sono gli studenti che – sempre in quel discorso – Wallace sprona verso la libertà della conoscenza, che “richiede attenzione e consapevolezza e disciplina”: gli spettatori.
Overload è un concentrato di trabocchetti. Il sovraccarico di azioni e visioni incalzanti non racconta solo la nostra esperienza di attenzione corta e di ipertestualità che è l’oggetto dichiarato della spettacolo, ma ci insinua il dubbio su ciò che sta ‘dietro’ l’evoluzione di quel sistema cognitivo nel quale siamo immersi senza (quasi) rendercene conto. Perché tutto è ‘reale’ e ‘fittizio’ al tempo stesso: che è concetto fondante del teatro in sé e per sé, ma qui assume l’ulteriore aspetto di un ritratto amaro della contemporaneità.
Lo spettacolo inizia con qualcuno che dice di essere e non essere David Foster Wallace e di voler raccontare quella giornata di settembre. E poi c’è qualcun altro che ci spiega le regole dello spettacolo: alla comparsa di un determinato segnale, il pubblico potrà decidere se cambiare l’andamento previsto e far accadere qualcos’altro: basta che almeno uno spettatore si alzi in piedi. In altre parole, il segnale funziona come un link ipertestuale che attiva un nuovo contenuto. Durante il discorso di Wallace, assistiamo così – grazie all’intervento decisivo del pubblico – all’attivazione di altri contenuti, che corrispondono sempre ad azioni sorprendenti, destabilizzanti, travolgenti (anche in senso letterale, come può sperimentare lo stesso Wallace, gettato a terra da un giocatore di football): apparizioni incongrue, ma determinate da quei link, e quindi strettamente connesse al discorso (per esempio, Wallace parla di acqua, ed ecco comparire una giornalista in mezzo a un’alluvione). Il gioco infinitodell’autore di Infinite Jest si ritorce contro di lui frammentando l’infinito nella finitezza di un discorso ridotto a brandelli (con una tecnica narrativa forse più vicina al classico cut-up), e perciò impossibile da seguire, per colpa di un tripudio ludico – di jest, appunto – che dovrebbe accrescere la nostra conoscenza su ciò che sta dicendo e invece la diminuisce fino alla sua completa dispersione. E’ questo il meccanismo ipertestuale che ci accompagna quotidianamente? L’illusione di un processo cognitivo di arricchimento infinito che invece si manifesta in una serie di deviazioni che restringe non solo la nostra durata d’attenzione ma la nostra stessa conoscenza? Insomma, è questo l’infinite jest dei nostri tempi, cioè il gioco infinito di tanti frammenti che costruiscono il caos della coscienza contemporanea? Alas, poor Yorick! I knew him, Horatio, a fellow of infinite jest, of most excellent fancy, dice il principe Amleto stringendo il teschio del buffone di corte nella più iconica delle scene shakespeariane: dov’è finito quel gioco infinito, dice il Principe che di “essere” e “non essere” se ne intendeva, se non nella finitezza della morte? E dove può essere ricollocato se non in una cornice di finitezza e di morte, come quella proposta da Overload, che inizia con la presenza in scena di uno scrittore che dichiara la propria morte e finisce ancora (come vedremo) con la morte?
Dunque, il discorso di Wallace è spesso interrotto dal pubblico che, alzandosi dalla poltrona per un istante, determina, al momento indicato, l’avvio di un link e l’apparizione nella scatola scenica di altri ‘contenuti’: pescatori, piloti, ballerini di breakdance, due tenniste (un richiamo di contenuto narrativo al libro di Wallace), e ancora un nuotatore, un soldato greco, una turista, e così via: una macedonia di personaggi che si attivano in microstorie, il cui senso non sta nella storia che portano, ma nella pura presenza di disturbo in sé e per sé. Un vortice incalzante che coinvolge fisicamente il pubblico – perché ‘attraversato’ dai personaggi o trascinato in scena a ballare o spinto a lanciare ortaggi sugli attori – e che arriva al suo apice in un frullato ormai incontrollato, dove a Wallace si sostituisce per pochi minuti Stephen King e dove esseri umani e animali (galli da combattimento o esseri sirenoidi come un uomo con testa di pesce) si avvicendano apparentemente senza più un rapporto causale con il filo principale del discorso. Finché i cinque attori compaiono sulla scena spogliati dei loro personaggi per raccontare, in una lunga scena conclusiva, cosa è successo dopo la fine di questo spettacolo: sono usciti da teatro, sono saliti in auto e hanno fatto un incidente dove sono morti tutti.
La fine dello spettacolo coincide, insomma, con una scena anomala che si sottrae al meccanismo ipertestuale dichiarato all’inizio e condotto fino a quel punto. Il racconto oggettivo/soggettivo (gli attori sono i personaggi – che peraltro sono gli attori stessi – ma al tempo stesso sono i narratori esterni di ciò che avviene) mette a fuoco una piccolissima storia banale che improvvisamente diventa ‘apocalittica’ in quanto racconta una “fine del mondo” (la morte di tutti) e in quanto rivelatrice. Ma rivelatrice di cosa? Dell’irruzione della realtà alla fine di un racconto tutto finto: è il testo che interrompe e si sostituisce all’ipertesto. Come dire: viviamo in una realtà in cui il continuum naturale è frazionato a causa delle mille sollecitazioni che riceviamo e che ci portano a un deficit d’attenzione, ma nel momento in cui la realtà si impone nella sua dimensione definitiva e assoluta non ci sono più scorciatoie, non ci sono più link che ci portino altrove: la vita va vista in faccia, e porta – naturalmente – alla morte.
Questo è interessante anche perché ricade proprio sullo spettatore. Contrariamente all’assunto di partenza (e cioè la riduzione della capacità di attenzione), l’ultima scena non soffre il minimo calo d’attenzione da parte del pubblico, e dunque nega ciò che è stato ‘dimostrato’ fino ad allora. Nel senso che, se c’è qualcosa di vero e vitale da raccontare, allora nessuno riesce a sottrarsi dal rivolgere a esso un’attenzione totale. Partendo allora dalla fine e riguardando indietro, occorre riconoscere che il gioco dei link, delle interruzioni, dell’attenzione intermittente, era dovuto all’assenza di “verità” e di “realtà”, come se la nostra abdicazione alla tirannia dell’ipertesto nasca dall’inadeguatezza di quel testo a farsi riconoscere come vero. Del resto, il presunto Wallace lo dice fin dall’inizio di essere già morto, e quindi di non essere lui: dunque si istituisce fin da subito un discorso di “falsità”, che inevitabilmente comporta dal punto di vista concettuale la “distrazione”, laddove il discorso di “realtà” della scena finale non può non scatenare invece un’attenzione assoluta.
Allora, se è così, lo spettacolo ha come oggetto vero non tanto il dichiarato discorso sulla durata dell’attenzione, ma piuttosto l’espressione di una esigenza di realtà e di verità. Verità che poi, a sua volta, è sottoposta alle regole del teatro, e cioè all’uso di strumenti ‘finti’ per esprimere il ‘vero’. Infatti, nella scena finale (quella che conterrebbe la ‘verità’) gli attori fingono platealmente, usando perfino una sorta di pantomima. E raccontano in modo oggettivo, quasi cronachistico, la propria morte, partendo da dati assolutamente realistici, anzi di prefigurazione futura di ciò che accadrà – anzi “è accaduto” – dopo la conclusione dello spettacolo che stiamo vedendo: scatenando, quindi, un’ulteriore vertigine temporale-concettuale, che potrebbe finire con il trascinare lo spettatore nella prefigurazione di cosa succederà a lui stesso una volta uscito da teatro.
Ma c’è un altro punto particolarmente significativo, che riguarda il meccanismo con cui si attuano le potenzialità ipertestuali che precedono la scena finale: in altre parole, la richiesta fatta agli spettatori di alzarsi in piedi per innescare lo switch. Una vera beffa, un vero jest. Perché è ovvio che ci sarà sempre almeno uno spettatore che, al palesarsi del link, si alzerà per innescare il cambio di scena, tant’è vero che gli attori in quinta sono pronti a intervenire esattamente con i costumi e per l’azione adatta al link sulla parola che crea lo switch. Insomma, Sotterraneo dice al pubblico: “se volete, alzatevi così inneschiamo una deviazione, altrimenti la scena continua con il semplice monologo di Wallace”, ma sa già che il pubblico vorrà sempre cambiare. E se il pubblico vuole sempre, allora non è realmente libero. La libertà richiede attenzione e consapevolezza, diceva Wallace agli studenti nel discorso iniziato con i pesci rossi. Ma gli studenti/spettatori di Overload, dopo aver abdicato all’attenzione per cedere con divertimento al rutilante avvicendarsi di scene da videoclip, rinunciano anche alla consapevolezza: il pubblico avverte di avere una libertà e un potere, che in realtà gli sono stati concessi dai direttori del gioco, anzi che non ha proprio perché non fa altro che agire esattamente come è stato già previsto. Lo spettatore che si alza non lo fa liberamente per cambiare la scena, ma obbedisce al richiamo come una scimmia ammaestrata. E allora, Overload – ancora una volta – ha come oggetto vero non tanto il dichiarato discorso sulla durata dell’attenzione, ma piuttosto un discorso sulla manipolazione.
E qui si ritorna proprio all’attenzione: cos’è se non manipolazione il sistema mediatico-connettivo che ci porta a cambiare sempre rispetto a ciò che stiamo facendo? In modo da non approfondire mai? In modo da non ascoltare mai davvero? In modo da non capire? In modo da credere di avere la libertà di decidere ciò che altri hanno già deciso per noi?
Dopodiché un altro ulteriore ragionamento innescato da questo spettacolo potrebbe essere che il Sotterraneo stesso sia… manipolato. In fin dei conti, Overload, che dovrebbe ‘denunciare’ il sistema di manipolazione del processo cognitivo ipertestuale che porta al calo di attenzione, è a sua volta ‘manipolato’ da questo sistema, perché lo spettacolo è costruito in modo perfetto per poter essere fruito proprio secondo i meccanismi dell’attenzione ridotta, del bombardamento di immagini e situazioni che irrompono frazionando la continuità. Insomma, per ‘denunciare’ questa cosa il Sotterraneo la assume nel linguaggio stesso e quindi ne è parte. E allora, la scena finale ‘apocalittica’ può anche essere letta come un tentativo di sottrazione da questo sistema: sì, è vero, ci siamo dentro anche noi, ci siamo resi conto che quello che abbiamo fatto è proprio quello che non ci piace, ma ormai nessuno può più sfuggire a questa logica (neanche voi spettatori che vi alzate per interrompere), e allora l’annullamento è l’unica soluzione… Discorso forse un po’ ‘nichilista’ e per certi versi anche un po’ pasoliniano: nel momento in cui mi rendo conto che l’omologazione (diceva Pasolini) ha vinto, non ho più speranze e l’unica possibilità espressiva è la visione apocalittica della realtà (Salò). E quindi la scena ‘vera’ e ‘apocalittica’ dell’incidente mortale che ha ucciso/ucciderà tutti gli attori dopo lo spettacolo si può anche leggere – nel paradosso temporale e logico nella quale è inscritta – come un riconoscimento del paradosso costituito dall’impossibilità di sfuggire da quel sistema (ricordate i due pesci rossi di Wallace nell’acqua che non sanno cos’è?). Proprio quel sistema che ci porta a una mancanza di attenzione continua (e quindi di annichilimento delle facoltà intellettuali e di pensiero… e quindi di azione: azione esistenziale, ma anche politica). E la volontà di sottrazione a questo sistema, anziché prefigurare una “rivolta” o un’alternativa, arriva a porre solo una sottrazione, anzi una auto-sottrazione, quella definitiva. Proprio quella compiuta da David Foster Wallace, in un giorno di settembre di qualche anno fa.»
Stefano Casi, casicritici.com
«L’intima consapevolezza del reale proposta da The Quiet Volume, diviene forza visiva e drammaturgica nello spettacolo dei Sotterraneo, Overload. Il ritmo incalzante qui non concede pause né silenzi, costringe a vivere un eterno presente dominato da un sovraccarico di informazioni, l’overload appunto. «È esattamente di questo che vorrei parlarvi stasera. Vorrei parlarvi della possibilità di una vita reale nell’epoca della saturazione delle informazioni». Così esordisce Claudio Cirri nei panni dello scrittore statunitense David Foster Wallace. Ma questo suo incedere nel racconto subisce rallentamenti, deviazioni, interruzioni, mediante l’apertura di una successione di finestre che lo spettatore è chiamato ad attivare. La scena si popola di personaggi – una coppia di tenniste, un pescatore, un pilota di Formula Uno, una donna in procinto di partorire, finanche due galli da combattimento – destinati a dissolversi nel giro di quei pochi secondi a cui è affidata l’attenzione (recenti studi stimano che la nostra soglia è scesa a 8 secondi, meno dei 9 di un pesce rosso). Non molto tempo fa, la serie televisiva britannica Black Mirror proponeva l’episodio 15 Million Merits, nel quale gli esseri umani, abitanti di un mondo asettico e claustrofobico, privati di qualsivoglia capacità critica, sono costretti a mantenere una soglia di attenzione costante davanti a schermi sui quali si susseguono programmi televisivi e spot pubblicitari. Un segnale acustico, simile a quello che precede l’attivazione del “contenuto nascosto” in Overload, funge qui da monito, in caso di distrazione, e obbliga a continuare la visione. I Sotterraneo non si limitano alla mera provocazione, propongono una lucida riflessione sulle contraddizioni che attanagliano il nostro presente, con un stile rigoroso e prorompente confermando un’autentica e schietta aderenza al reale. Ed è nel finale che, tolti gli abiti del personaggio, e concedendo una apparente distensione alla partitura verbale, attuano un radicale cambio di registro e mettono in scena la propria morte. Perché per sopravvivere, in questo overload, bisognerebbe restare in apnea, oppure imparare a respirare sott’acqua. O forse, ancora, mutare in forme nuove, diventare l’uomo-pesce che si aggira, infine, da solo, in questo presente «sommerso».
Giusi de Santis, Paper Street
«Ci sono due pesci che nuotano e a un certo punto incontrano un pesce anziano che va nella direzione opposta, fa un cenno di saluto e dice: “Salve, ragazzi. Com’è l’acqua?” I due pesci giovani nuotano un altro po’, poi uno guarda l’altro e fa “Che cavolo è l’acqua?”.
Nel maggio 2005, data in cui lo scrittore statunitense David Foster Wallace presentò questo aneddoto ai neolaureati del Kenyon College, si poteva ancora dire che fossimo pressappoco incapaci di condividere gli istanti così come adesso li sappiamo: Facebook aveva da poco registrato il proprio dominio e non era del tutto consapevole del suo raggio, Youtube appena s’affacciava alla rete e non un uomo avrebbe immaginato la potenza racchiusa nei 140 caratteri di Twitter. Quella di Wallace è una storia breve sull’intelligenza critica, sulla sensibilità di avvertire la banalità del reale ed esserle devoti.
Passano dieci anni, il dialogo del mondo è una babele magmatica d’informazioni, Wallace è morto suicida, maggio si ripresenta e stavolta è il quotidiano britannico The Independent a scrivere che a batterci sarebbero persino i pesci rossi (Our attention span is now less than that of a goldfish, Microsoft study finds) è il titolo dell’articolo del 13 maggio 2015). Uno studio di Microsoft stima che la durata concessa all’interesse individuale sia di circa otto secondi, inferiore a quella dell’acquatico vertebrato che nasce e muore mnemonicamente nel corso di un’esplorazione completa di una boccia.
Se il nostro lettore, quindi, contro ogni dettame di ipotesi sociologica, avrà avuto la pazienza di sfidare i pochi secondi affibbiatigli dalla ricerca, giunto fin qui si troverà a chiedersi quale sia la connessione che intercorre tra gli aneddoti scenici di uno scrittore e un articolo divulgativo dell’Independent: la congruenza sta in un acquario di pesci rossi su un palcoscenico.
Paiono molte le vie per codificare il contemporaneo, alcune costruite nell’intercezione dello spettacolo dal vivo, in particolare una si percorre a ottobre in quattro città dell’Emilia. A Modena VIE festival 2017, organizzato da Emilia Romagna Teatro, ha ospitato al Teatro delle Passioni la compagnia Sotterraneo, accogliendo dunque una sferzata all’inchiesta sui nuovi linguaggi; perché questo tipo di teatro è in divenire nell’attimo stesso del compimento, con una necessità di guardare al tempo e allo spazio pari a quella dell’avanzamento tecnologico e nel frattempo, per ogni verità che lascia emergere, si trascina appresso una componente di corrosiva mordacia e ironico fatalismo pronti a digerirla.
L’acquario di pesci rossi di cui sopra è collocato a margine della scena per allestire la scenografia altrimenti sgombra; vicino, un Foster Wallace trepidante (Claudio Cirri) porta avanti l’ennesima elucubrazione ad alta voce, ma ne sovrasta occasionalmente il discorso un’infinità di episodi sospesa nel limbo dell’inconscio, plausibile o inverosimile, che fa rumore, che sbigottisce nella risata o attedia fino allo sbadiglio e che potrebbe coesistere in una sorta di comune traffico cerebrale ad alta voce. Infatti, l’occasione di zittire lo scrittore è data al pubblico da altre quattro figure concitate (Sara Bonaventura, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini) che, con un’icona cartonata in mano, a intervalli regolari suggeriscono di attivare nuovi contenuti in scena attraverso un semplice “stand up”. Così, mentre Foster Wallace mantiene la propria identità per il tempo della pièce, i colleghi si perdono in un bagno riproduttore di umanità varia, in situazioni e luoghi diretti dalla platea che, così facendo, attiva un potere nei confronti del luogo originariamente pensato come primario: il palcoscenico. E la drammaturgia di Daniele Villa è calibrata inaspettatamente dalla volontà concorde di tutti. La mente non fatica mai e si apre libera a fagocitare ogni input scenico, tanto è breve, tanto qualcuno che ne ha abbastanza c’è sempre e se annoia ci si alza in piedi, ma non per andarsene, per cambiare direzione.
“Questa è acqua, questa è acqua”, pensiamo per risolvere l’aneddoto dello scrittore. Il tessuto dell’esistenza sta nell’economia dell’attenzione, nella scrematura di quelli che paiono brusii irrilevanti. Ma di quella beffa verso se stessi, di quella illusione di coinvolgimento nell’informazione per accumulo, ognuno è consapevole: non si può essere attenti – nella vita o in una boccia – senza essere distratti.»
Francesca Pierri, www.teatroecritica.net
“[…] E un’altra persona realmente esistita che ha scelto di infliggersi la morte, scrittore autorevole scomparso suicida nel 2008, David Foster Wallace è protagonista del nuovo spettacolo di Sotterraneo, Overload, andato in scena in prima nazionale il 21 e il 22 ottobre al Teatro delle Passioni di Modena per VIE Festival. Dopo Postcards from the future, il collettivo fiorentino fa un passo indietro e ritorna, più convincente e forte di prima, a una sorprendente verve comica della scrittura di Daniele Villa. Intelligente e originale nella costruzione dell’impianto drammaturgico, con l’obiettivo comico e irraggiungibile – dichiarato nel testo – di materializzare «la possibilità di una vita reale nell’era della saturazione delle informazioni», Sotterraneo applica in maniera brillante ed efficace il formato Facebook alla drammaturgia dello spettacolo: cartelli con il simbolo utilizzato in rete per la social-condivisione attivano dei veri e propri “ipertesti”, ovvero azioni sceniche e siparietti degli attori (Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini), che illustrano quanto labile stia diventando la nostra capacità di restare concentrati, di seguire il filo di un ragionamento o di un discorso più o meno complesso. Nell’epoca dell’ipertrofia delle informazioni viene soffocata persino l’autorevolezza del discorso tenuto da una celebrità defunta, cioè lo scrittore americano interpretato all’inizio con enfasi teatrale da Claudio Cirri («Non sono quello che dico di essere ma facciamo finta che lo sia»); in mano al pubblico, il potere di “cambiare contenuto” quando un attore ne dà il segnale: la regola – o forse dovremmo dire l’algoritmo? –, stabilita all’inizio, vuole che all’alzarsi in piedi di un solo spettatore entro cinque secondi quel potere sarà attivato. Così, le azioni a comando stanno allo spazio scenico come ipertesti o schede di un browser stanno a una bacheca virtuale.
Di questa società che domanda o lascia trionfare il virtuale sul reale, distratta e svuotata di logica, di vitalità (e qui potremmo ritornale alle “passioni tiepide” citate all’inizio), Sotterraneo presenta con leggerezza e profondità, ironia e impegno, un collage quasi fiabesco, denso di accostamenti incongrui, da cui scaturisce l’effetto di straniamento grottesco anche incarnato dalla scrittura letteraria di Wallace, simile a quella di un computer che verbalizza, esterna all’utente-lettore, la modalità del “pensiero” che precede l’azione.[…]”
Renata Savo, www.scenecontemporanee.it
«Lo sforzo di concentrazione richiesto da Conversation without Words appare sicuramente immane agli occhi di Teatro Sotterraneo che incentra il proprio Overload proprio su una riflessione sulla capacità di attenzione, a partire da David Foster Wallace e dal suo ultimo romanzo, Il re pallido.
Claudio Cirri lo porta in scena e ne rievoca l’ultimo giorno di vita; allusioni ai suoi romanzi e scritti così come alle sue interviste punteggiano lo spettacolo che, nondimeno, viene interrotto a intervalli non regolari da “contenuti extra” che il pubblico è chiamato ad attivare o meno, semplicemente alzandosi. Ma a un certo punto D.F. Wallace ha cambiato connotati e, dopo poco, è stato sostituito da Stephen King. Poi tutto cambia di nuovo e i cinque performer sono in auto, di ritorno a casa dopo una replica che, forse, è stata l’ultima.
Con la scaltrezza, l’ironia e il sorridente gusto del grottesco che li caratterizza, i Sotterraneo mettono in scena quanto quotidianamente ci perdiamo a causa della nostra rapsodica attenzione e della nostra ansia di accumulare azioni e parole. Una performance forsennata ma accuratamente meditata, con un finale che cancella le risate e costringe a ripensare da un altro punto di vista a quanto si è visto nei cinquanta minuti precedenti. E anche ad andare a (ri)leggere David Foster Wallace…».
Laura Bevione, PAC Paneacquaculture
«Con un’incessante – ed esilarante – interazione tra palco e platea, Overload mette in scena il sistematico sovraccarico di stimoli e informazioni, e il conseguente abbassamento della soglia d’attenzione dell’uomo moderno: tra cookies, rumore totale e quotidiano cortocircuito tra finzione e realtà, si vive in uno stato di eccitazione e obnubilamento senza scampo».
Francesca Saturnino, Che teatro fa / blog di La Repubblica
“Chissà cosa avrebbe detto Calvino di questo curioso esperimento teatrale. Lui che in un certo senso aveva “inventato” la multi-traccia letteraria con Se una notte d’inverno un viaggiatore, esasperando il tentativo di un povero lettore di portare a termine dieci incipit di opere fatalmente incomplete. In un certo senso il pluripremiato collettivo di ricerca teatrale Sotterraneo gioca sulla stessa problematica post-moderna: l’incapacità o l’impossibilità di portare a termine, un gioco meta-testuale che avrebbe di certo avvinto anche David Lynch “padre” cinematografico delle trame aperte.
In Overload tuttavia, spettacolo presentato dal gruppo fiorentino allo Short Theatre 2018 il 14 e 15 Settembre allo Studio1 della Pelanda, i “vip” culturali sono piuttosto Foster Wallace e Stephen King, il primo, vero “node” di tutto lo spettacolo, tanto per rimanere in tema. Sì perché il gioco narrativo di Sotterraneo è quello di un ipertesto teatrale, dove mentre Foster Wallace prima e Stephen King poi cercano di portare a termine un lunghissimo discorso, vengono “disturbati” da diverse interruzioni, decisamente “invadenti” è il caso di dire, vista anche la “fisicità” del loro invadere appunto la scena. E dunque mentre crediamo di assistere ad uno spettacolo sulla vita del geniale scrittore americano morto suicida a soli 46 anni, veniamo di continuo assaliti da proposte di nuovi contenuti attivabili dagli stessi spettatori in sala semplicemente alzandosi in piedi.
Nella miglior tradizione della mass-self-communication in buona sintesi Overload, che in inglese si traduce “sovraccarico”, causa primaria della nostra memoria così obliante, come in un racconto proprio di Wallace dal titolo Oblio, (dove il sonno di una moglie è di continuo “disturbato” dal russare del marito), propone al pubblico un Running Plot, costantemente interrotto dalla possibilità di accedere a nuovi Anthology Plot, come in una serie tv perversamente tesa verso l’inconcludenza.
Quanto dura allora la nostra attenzione? Secondo la scienza meno del più formidabile girotondista da boccia: il pesce rosso, che per 9 secondi ricorda la via circolare che ha percorso lungo la sua rotonda casa di vetro, dopodiché dimentica e ricomincia a girare. L’essere umano, pare, da recenti studi, riesca a mantenere il livello di attenzione per 8 secondi e come d’altra parte potrebbe essere altrimenti in un continuo bombardamento mediatico? Viviamo in un’epoca di sovrabbondanza tecnologica, dove le informazioni anche più inutili finiscono per fagocitarsi l’un l’altra in un infinito girotondo non troppo dissimile da quello del nostro amico Carassio Dorato (pesce rosso per i più).
Forse Overload vuole farci intelligentemente riflettere sulla disgrazia o la fortuna di una mente che dimentica in fretta. Uno spettacolo ben studiato, fatto a maniera da chi il teatro sa vivisezionarlo con la minuzia di uno scienziato alla ricerca tormentosa di risposte; movimenti di scena fra i migliori visti negli ultimi anni, precisione e coordinazione da manuale, non solo nella recitazione ma anche nel disegno luci e progetto audio, così come nei curatissimi costumi e negli oggetti di scena, ogni cosa messa al posto giusto insomma. Unica pecca magari l’idea di parlare già ad un pubblico “educato”, pronto a riconoscere citazioni e interventi, nell’economia di uno spettacolo meno emozionale e più riflessivo, laddove invece proprio quel che fa “mass”, rimane tagliato fuori dalla comprensione di certe chicche. Poco importa, c’è anche spazio per il più antico e democratico giudizio demoscopico: il lancio delle verdure agli attori, dopotutto leggenda vuole che perfino la Callas si sia beccata un sedano allo Scala!”
Fabiana Dantinelli, Fermata Spettacolo
«[…] Analisi conturbante della contemporaneità è anche quella offerta dal gruppo Sotterraneo con Overload […] La figura di Wallace, sempre sul filo del paradosso, continua a essere presente durante tutta la performance, che però viene interrotta costantemente da una sorta di ‘connessione multimediale’ […] Questo accorgimento permette agli attori – tutti bravissimi, anche dal punto di vista atletico – di scatenare le situazioni più assurde e impreviste, mentre la riflessione coinvolge argomenti cruciali della modernità, come la sempre minor capacità di attenzione dell’essere umano.[…] Uno spettacolo di grande visionarietà, che chiude al meglio Primavera dei Teatri 2018.[…]»
Leonardo Mello, Non Solo Cinema
«Overload di Sotterraneo è uno di quegli spettacoli che riconcilia col teatro, perchè dimostra che l’arte della scena può essere uno straordinario detonatore di pensiero. […] è un invito ad aprire la mente, è un gioco legato alle porte aperte dalla distrazione, a ciò che si perde, ma anche si acquista, fino alla scena finale che toglie il respiro e fa inabissare il sorriso. […] Sotterraneo ridà fiducia nella scena e incarna le possibilità infinite del nostro contemporaneo».
Nicola Arrigoni, La Provincia di Cremona
«Ad introdurre lo spettacolo – «Overload», presentato dal collettivo fiorentino Sotterraneo nell’ambito della XIX edizione del festival «Primavera dei Teatri» – sono due performer: l’uno nei panni dello scrittore statunitense David Foster Wallace, che annuncia di voler parlarci «della possibilità di una vita reale nell’era della saturazione delle informazioni», e l’altro incaricato d’illustrare il meccanismo di base dello spettacolo medesimo.
Questo meccanismo, in breve, è il seguente: ogni volta che comparirà il segnale «collegamento», basterà che un solo spettatore si alzi per scegliere se continuare ad ascoltare David Foster Wallace o attivare un contenuto nascosto. Il pubblico lo scoprirà solo nel corso dello spettacolo. Ma ogni volta che attiverà un contenuto nascosto perderà inevitabilmente parti più o meno consistenti del racconto dello scrittore.
Si capisce, dunque, che il tema dello spettacolo è la soglia d’attenzione. Proprio perché siamo letteralmente e continuamente investiti da un flusso inarrestabile d’informazioni, finiamo per non riuscire più a mettere perfettamente a fuoco l’oggetto singolo della nostra riflessione. Si affollano intorno ad esso altri oggetti che da quello ci distraggono. Siamo, insomma, come l’ubriaco al quale il troppo vino bevuto («overload» significa per l’appunto «sovraccarico») toglie la visione nitida di ciò che lo circonda. E stanno nella lucidità con cui viene individuata e sottolineata tale impasse l’intelligenza e l’attrattiva dell’operazione varata da Sotterraneo. Per l’esattezza, David Foster Wallace ci parla, fra l’altro, di pesci rossi, del suo celebre discorso «Questa è l’acqua», di una sua giornata di settembre di qualche anno prima, degli antidepressivi, di sua moglie Karen, dei suoi studenti, del nuovo libro a cui sta lavorando, «Il re pallido», del suo capolavoro «Infinite jest», del suo saggio sulle aragoste, della sua passione per il «Letterman Show». Mentre i contenuti nascosti riguardano, tanto per fare qualche esempio, una ragazza che vince il titolo di Miss Universo, tre «breakers» che irrompono in scena con una loro coreografia, il combattimento fra due galli giganti.
Ovviamente, c’è un elemento che, nel solco di una sagace e molto allusiva strategia, accomuna questi contenuti nascosti. E si tratta proprio dell’acqua che costituiva l’argomento del celebre discorso di David Foster Wallace citato: l’acqua, giusto, come metafora della situazione liquida in cui oggi annaspiamo. Ed ecco, allora, i contenuti nascosti relativi a una cronista che descrive un’alluvione, a un pescatore che attraversa lo spazio con la sua canna, a un nuotatore che si tuffa nel pubblico. E il parallelo stabilito con il suicidio dello scrittore s’incarna nell’incidente stradale che capita ai cinque performer mentre tornano a casa dopo lo spettacolo e che li vede morire annegati. È anche, s’intende, un’acre meditazione sull’attuale impotenza del teatro, determinata in primo luogo proprio dalla parcellizzazione della conoscenza per effetto di un’informazione «anarchica» che abbassa, nella fattispecie, la soglia d’attenzione dello spettatore medio. E non a caso, del resto, un’impagabile autoironia connota la sequenza in cui, al termine del suo colloquio con David Foster Wallace, l’intervistatrice invita il pubblico a lanciare verdure contro gli attori, sulle note di quei Nirvana che tanto piacevano allo scrittore.
Eccellente, infine, la prova degl’interpreti: Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati e Giulio Santolini. E insomma, una chiusura in bellezza per un’edizione di «Primavera dei Teatri» che, lo si è visto, ha alternato troppo di frequente le cadute ai voli.»
Enrico Fiore, www.controscena.net
«L’intera performance è acuta, irriverente, intelligente. L’impianto visivo procede di rivoluzione in rivoluzione. Ogni rapido cambio strappa una risata, un sussulto o un qualche altro tipo di esclamazione […].
Avrei volentieri visto Overload altre due o tre volte una dietro l’altra, e questo è senz’altro un indizio dell’impeccabilità di questa performance».
Will Amott, www.stagetalkmagazine.com
«In Overload il gruppo fiorentino Sotterraneo gioca con la progressiva perdita di attenzione dovuta all’abuso delle nuove tecnologie dell’informazione, portando gli effetti di questo supposto deficit cognitivo a estremi assurdi e surreali. Il risultato è una successione esilarante di scene nei contesti e nelle situazioni più diverse […]. Il risultato è di un ritmo trepidante che non diminuisce in nessun momento, grazie all’inventiva e all’ingegno degli attori in grado di connetterci con gli “argomenti di tendenza” che modulano la nostra esperienza quotidiana della realtà, come i “tweets”, i “podcast” o gli “screen shots”».
Gordon Craig, www.elheraldodelhenares.com
«Il loro approccio al teatro è qualcosa di unico, e il risultato è un divertente resoconto sulla condizione umana e su come la nostra capacità di attenzione si stia riducendo sempre di più. Dall’inizio alla fine è stato puro piacere, ed è un peccato che la performance sia durata solo 30 minuti. […] Il modo migliore per descrivere la performance forse è parlare di “caos organizzato”. […] Hanno fatto sempre divertire, e in maniera peculiare: ogni scena, della durata di circa dieci secondi, ha catturato il pubblico dall’inizio alla fine. Una comicità costante, da un coro gospel a un personaggio a metà tra uomo e pesce. Non c’era una vera storia, ma nonostante ciò era possibile seguire il loro filo rosso con facilità. La compagnia ha creato un’atmosfera chiassosa di totale e assoluto divertimento. […] Ci hanno restituito il meglio dei due aspetti: siamo stati costantemente deliziati dalla loro energia festosa, ma ci hanno anche fatto capire i meccanismi scientifici della mente umana con un approccio al teatro fattivo e davvero indimenticabile».
Elizabeth Halpin, www.behindthearras.com
«Overload è un’opera dalla simpatia dirompente e frenetica, ancorata ai fondamentali pilastri beckettiani. […] Il contenuto si presenta ben coordinato nel suo scompiglio, e porta avanti l’idea che oggigiorno, con l’arrivo delle nuove tecnologie, l’attenzione dell’essere umano non supera gli otto secondi. Come in ogni lavoro che segua questi principi, si mescolano irriverenza, commedia, assurdo, velati riferimenti sociali ed alcune idee che rimangono in sospeso. In definitiva, un buon lavoro ricco di ilarità».
Rafael Gonzáles, www.lacarcoma-criticas.blogspot.com.es
TALK SHOW
L’occasione di questa caustica sommossa scenica è Talk Show di Sotterraneo, la compagnia toscana già Premio UBU nel 2018 con lo spettacolo Overload, come d’altro canto ci ricorda compitamente Nicola Borghesi dei bolognesi Kepler-452, l’anfitrione glocal con loro in scena. Ma quello a cui assistiamo è in realtà un’inversione del format che Sotterraneo ha già proposto in diverse occasioni dal 2018, nel quale è la compagnia a porre una maglia di domande a colleghi attori, registi, coreografi, direttori artistici. Questa volta sono dunque Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa, a farsi interrogare dal padrone di casa che, come al solito, empatizza con l’uditorio grazie alla sua riconoscibile verve dimessa, alla timbrica trasognata e dialettale. Sulla scena un tappetino di erba sintetica, un tavolo con quattro sedie ed un laptop collegato in proiezione allo schermo sul fondale. Non mancano nemmeno le tazze da colazione a suggellare una scenografia homy, a metà fra una conversation piece nel salotto di casa e una conferenza.
Eppure, la proposta procede su un più sottile crinale metacomunicativo. Sin dall’incipit, con le voci fuori campo che restituiscono il dialogo scherzoso fra gli artisti prima di entrare al cospetto del pubblico, messo così in guardia sulla natura di ciò che sta per accadere. La scena si dà dunque nelle sembianze di un vero e proprio talk, ma mantiene quella profondità segnica che la distingue tanto dal dispositivo di mero intrattenimento che dal luogo della cronaca (sia pure quella specialistica), della biografia, dell’epifania del reale come rappresentazione naturalistica. Al contempo non c’è ragione di dubitare dei dati consegnatici come simboli della realtà, parametri di un’elaborazione complessa e contraddittoria. Non v’è da mettere in discussione l’accorato afflato politico, che è peraltro terreno comune per Sotterraneo e Borghesi, l’impronta civile di un modo di vivere il teatro come «scuola di intelligenza e cittadinanza». Un progetto tutto inscritto nella forma dialogata, intrinsecamente pedagogica ed agapica, che Talk show propone, ed in cui pure non viene meno quella tensione oppositiva ed irresolubile fra persona e personaggio (in una parola: il teatrale). I Sotterraneo ci tengono, per esempio, a portare il pubblico di fronte ai luoghi della loro infanzia, visualizzati a schermo grazie a GoogleMaps. Sorge spontanea, e feconda, la domanda: sono davvero quelle le case che hanno dato i natali a Bonaventura, Cirri e Villa? Dobbiamo crederlo solo per la cornice non dichiaratamente fictionaria del formato cui siamo di fronte? O non è forse vero che ogni talk show è funzione di una finzione?
Ma un crinale degno di tale nome è equidistante fra i due versanti opposti. Così distinguiamo scambi più diretti e sorgivi, alternati a gag e citazioni di lavori passati proiettate a video o performate. Il risultato è una corrente alternata di dialogo e spettacolo che mantiene viva l’attenzione del pubblico. Due modalità e due modi di vivere il tempo, il cui scorrere appare visualizzato negli orologi digitali appesi al tavolo, ostentatamente rivolti al pubblico. Si tratta, appunto, di due orologi: uno a segnare l’orario della giornata, valore assoluto che riporta all’urgenza dell’extradiegetico, l’altro a scandire il count down dei sessanta minuti che sono la durata della performance.
Si finisce così non tanto per darsi una risposta, ma per porsi davvero, nel proprio intimo, la domanda del sottotitolo: di cosa parliamo quando parliamo di spettacolo dal vivo? Un interrogativo che fa da intrigante cornice al PROGETTO SOTTERRANEO, prodotto fra vari enti e realtà emiliano-romagnole, e che porterà in scena di qui a luglio 2020 alcuni dei lavori del collettivo toscano, oltre a incontri e laboratori.»
Andrea Zingari, PAC Paneacquaculture
POSTCARDS FROM THE FUTURE
Simone Azzoni, www.artribune.com
«La performance interattiva Postcards from the future, in cui gli spettatori vengono divisi in players e observers per comporre dei tableaux vivants fotografati poi come cartoline spedite dall’anno 2066, 2616 e 3066, ha visto non solo il corpo del fruitore come protagonista, ma quello del performer come macchina umana al servizio del suo destino, un destino macabramente passivo, inerte».
Sergio Lo Gatto, www.teatroecritica.net
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
Recensioni de Il giro del mondo a puntate (Pistoia, 2015)
Il Sotterraneo in viaggio verso l’India
«I due narratori, tramite un gran cartellone da gioco di società rappresentante una mappa del mondo, ci portano dalla Londra (e dalla scommessa) di Phileas Fogg fino in India, facendo intervenire il pubblico con quiz a premi, penalità e imprevisti. La narrazione si accende di altrettanto ironici e divertenti inserti musicali di giovani strumentisti […]. In questa prima parte il reading gioca a evocare con brevi, efficaci tratti i diversi ambienti e atmosfere del romanzo, dalla rigida, abitudinaria Inghilterra vittoriana all’Egitto avventuroso e misterioso, all’India seducente di colori e animali esotici, in una corsa spesso insidiata da ostacoli e dai sospetti di poliziotti sulle tracce degli autori di un colpo grosso in banca. Insomma, l’avventura pura, riletta con un distaccato, curioso, complice sorriso».
Massimo Marino, www.boblog.corrieredibologna.corriere.it
«Daniele Villa, drammaturg del gruppo fiorentino, più che adattare l’avventura scritta da Jules Verne la scompone in episodi frammentando il racconto in un dispositivo da gioco. Il lavoro è firmato anche da Claudio Cirri e Sara Bonaventura: entrambi in scena si rimpallano i personaggi e i ruoli di presentatori/banditori di questo strano format che col passare dei minuti rivela proprio la capacità di rendere fertile e vivo il romanzo amplificando il ruolo e l’attenzione dello spettatore stimolandone continuamente la fantasia. Con una grande cartografia dell’epoca i due seguono il viaggio del protagonista (accompagnati e interrotti dalle giovani musiciste della Scuola Comunale di Musica e Danza “T. Mabellini” di Pistoia), come in un gioco da tavolo in cui l’atto di pescare le carte determina cambi di direzione, relazioni col pubblico tramite quiz lampo e deviazioni drammaturgiche apparentemente casuali. Immagino questo spettacolo/game a puntate nelle scuole, nelle piazze, per un pubblico dai 10 a 100 anni».
Andrea Pocosgnich, www.teatroecritica.net
«Teatro Sotterraneo scompagina il romanzo e lo riscrive facendoci sentire al fianco del protagonista, diretti complici dell’avventura o membri ingombranti del suo equipaggio. Pensato in quattro puntate dalla durata di venti minuti ciascuna (per un totale di 80 minuti), lo spettacolo è dislocato in quattro punti diversi della città di Pistoia […]. In scena Sara Bonaventura e Claudio Cirri, attori-narratori-conduttori di questa folle corsa contro il tempo. Vestiti come damerini dell’epoca, i due attori gestiscono tutti i ruoli del romanzo […]. Da un tavolino mobile, sollevano diverse tessere sulle quali leggono il testo dello spettacolo e incappano talvolta in carte che segnalano premi e vantaggi o, più spesso, imprevisti di diversa entità, catastrofi o super-catastrofi. […] Claudio Cirri e Sara Bonaventura si incolpano e si sostengono a vicenda, immedesimandosi nella furiosa cavalcata del viaggio di Fogg e facendo scorrere lo spettacolo a un ritmo velocissimo. La sintesi dell’opera di Verne, firmata nell’adattamento dal dramaturg e regista Daniele Villa, consente però ai due interpreti di indugiare su alcune scene del romanzo, riuscendo a non tradire la missione teatrale e trasmettendo un’immagine sempre integrale del viaggio.
Agli imprevisti e alle penalità si accompagnano quiz per il pubblico, che dando una risposta corretta o sbagliata determinerà o meno ulteriori ritardi sul programma previsto. Teatro Sotterraneo include continuamente i suoi spettatori e non esula dalla trama del romanzo; in più di un’occasione non mancano gli effetti speciali, indotti da divertite smagliature a opera della compagnia: nel terzo episodio, un vorticoso coast to coast da un porto all’altro dell’America del Nord, l’immaginario di fine ottocento si mescola al nostro più vicino paesaggio hollywoodiano con tanto di alieni a caccia di soggetti umani per i loro esperimenti […].
È un gioco? È uno spettacolo? È una lettura scenica? L’allestimento dei Sotterraneo utilizza peculiarità di questa e quell’altra forma, attingendo anche ai quiz televisivi e da tavolo, rimanendo fedele al nocciolo originario della questione: l’avventura. Sebbene diverso dai lavori della compagnia visti in precedenza (ma in parte ricorda Homo ridens, per la frontalità continuamente interrotta e un certo uso dei materiali iconografici) Il giro del mondo in 80 giorni di Teatro Sotterraneo non rinuncia a un atteggiamento cinico caro al collettivo. Si punta infatti l’occhio sui passaggi più incerti del romanzo, quelli dove per esempio emergono i cliché dell’autore nel raccontare i tipi umani che si avvicendano attorno a Fogg, che danno lo spunto per test al pubblico sulla xenofobia, con domande sull’omosessualità o il razzismo etnico. […]
Articolato, dislocato, ripartito, Il giro del mondo in 80 giorni di Teatro Sotterraneo è un viaggio che si muove tra le forme del teatro e gli spazi di una città, che fa di un romanzo un luogo di invenzione e gioca con gli elementi a disposizione per aprire parentesi e aggiungere pensiero. Un seria e smaliziata partita contro il tempo, a teatro, per spettatori avventurosi».
Serena Terranova, www.altrevelocita.it
«Teatro Sotterraneo incontra il romanzo d’avventura di Verne. Un ciclo di letture sceniche con inserti di musica dal vivo, giocate con la consueta sagacia e ironia del gruppo toscano […]. Accompagnati da Emma Longo al flauto e Sofia Morano al violino (di una bravura che stupiva data la giovane età) della Scuola di Musica e Danza Mabellini, i due protagonisti dall’eloquio fluido e accattivante, come si conviene per una recitazione su testi letti, si prodigavano per raccontare il viaggio tramite delle cartoline, quasi fossero dei presentatori televisivi. Un format simile ad uno dei tanti visti in televisione, con la differenza che visto nella magnifica Sala delle Carrozze, assumeva un fascino del tutto singolare.Incursioni nel mondo fantastico di Verne, grazie all’ausilio di una gigantesca mappa geografica su cui appuntare le varie tappe del Giro. Si va oltre alla realtà per accedere a paesi esotici, descritti, narrati, esaltati da una recitazione sempre di ottimo livello. Godibile come lo possono essere le favole moderne ricche di metafore, il pubblico è reso partecipe e sottposto ad prove, e risponde a domande. Un’interazione intelligente, senza rischiare di cadere nella retorica di una narrazione colta e illustrativa. L’ironia che da sempre distingue il lavoro di Teatro Sotteraneo è lo strumento più idoneo per far conoscere e divertire. Tra arrivi e partenze, compare sul fondo da un portone che si spalanca, un’auto d’epoca su sui salgono Sara e Claudio per andare via. Il viaggio prosegue…».
Roberto Rinaldi, www.rumorscena.com
«Nella splendida cornice di Villa di Scornio, va in scena la prima, godibilissima puntata de Il giro del mondo in 80 giorni, reading (ufficialmente, ma in realtà spettacolo compiuto) tratto dal celebre romanzo d’avventura di Jules Verne. Come sempre, Teatro Sotterraneo, utilizza una serie di mezzi propri del teatro, attingendo però anche all’arte dei cantastorie e al gioco da tavolo (soprattutto il Monopoli) per ricostruire sia il clima ideologico della Londra di fine Ottocento, sia l’universo fantastico che caratterizza le opere di genere di Verne. Senza alcun intento pedagogico ma con una grazia rara e una freschezza disarmanti, gli spettatori (adulti o bambini) si trovano catapultati nell’avventura della circumnavigazione del globo. A ogni tappa, sorgono i famosi imprevisti del Monopoli e si possono giocare dei Jolly (uno solo a puntata); il pubblico è invitato a rispondere a domande in stile Trivial Pursuit e gli attori sono chiamati a superare delle prove, come recitare un testo con convinzione (dimostrando così anche le loro doti interpretative). Nel frattempo, il viaggio si materializza di fronte ai nostri occhi grazie all’uso di un cartellone che rimanda sia agli espositori dei cantastorie di epoca medievale sia alle carte geografiche che affollano la filmografia di genere giallo – coperte di puntine, fili di spago multicolori e fotografie di possibili colpevoli. L’attenzione per l’immaginario pop rifugge però il cliché e si integra perfettamente con questa costruzione agile, che diverte interessando e fa pensare mentre ironizza, con classe, sulle idiosincrasie di un mondo – quello Occidentale – che, a distanza di un secolo e mezzo, continua a liquidare tutto ciò che è diverso da sé come barbaro o rieducabile. Interessante, infine, anche l’idea di proporre questo viaggio attraverso l’suo della musica dal vivo, accompagnandosi a generi e musicisti sempre diversi. […] Spumeggiante finale che ha suscitato un meritatissimo applauso anche per la capacità di Teatro Sotterraneo di utilizzare la meglio lo spazio, inventandosi uno spettacolo site-specific di notevole impatto visivo».
Luciano Ugge e Simona Maria Frigerio, www.persinsala.it
«Vestiti proprio come due damerini dell’Ottocento ma con un’eloquenza da moderni mezzibusti televisivi, Sara Bonaventura e Claudio Cirri di Teatro Sotterraneo ci danno le coordinate di questo “reading a puntate per due attori, musicisti vari e qualche colpo di scena”. La scommessa di Phileas Fogg di riuscire a circumnavigare il mondo accompagnato dal suo servitore Passepartout è riassunta su piccole cartoline, come quelle usate dai presentatori durante i telequiz. La sensazione è quella di essere immersi nella plancia ottocentesca di un odierno format preserale che governa la nostra conoscenza dei fatti; la notizia di cronaca del Daily Telegraph per cui grazie all’apertura di una nuova linea ferroviaria in India è possibile fare il giro del mondo più velocemente innescherà infatti un gioco di (alta) società da cui i più sono esclusi. L’unica differenza, forse, è che oggigiorno le cartoline con i quesiti sono state sostituite da schermi ultrapiatti: eppure qui – vien da pensare – siamo ancora nell’Ottocento! D’altronde lo scarto, il non-confine tra realtà e finzione, tra passato e presente, è un terreno che continua ad essere perlustrato, nonché talvolta forzatamente deviato, dalla Compagnia, e che stavolta trova materializzazione in una grande Mappa del Mondo.[…]
Ma il Tempo ora si è ridotto e la Terra ristretta grazie a una Grande Opera, così il tavolo da gioco di questo Risiko – in peace-keeping, diremmo oggi – ci narra le dis&avventure e le peripezie di un corto circuito entrato in loop tra un Ritorno al Futuro very british e un “Presente andato” too cool. Come in un Monopoli in 3D si attaccano le facce palesemente irriconoscibili dei protagonisti lungo la prima tratta sulla cartina mentre noi siamo estratti dal nostro incognito – alla parola solitamente “imprevisti” – e chiamati a fare la nostra parte: quanto impiegheremmo ora da Londra a Suez? Qual è il piatto tipico mangiato in India da Passepartout e Mr. Fogg? Tutto diventa espediente – con il rischio anche di diventare formula – per mostrare quanto anche uno dei più famosi racconti di genere può (de)generare restando fedele a se stesso e caricando un immaginario fino ai confini della realtà».
Manuela Margagliotta, www.paperstreet.it
Il giro (divertentissimo) del mondo in 80 giorni
«Con quelle facce un po’ così, quell’espressioni un po’ così, che hanno Sara Bonaventura e Claudio Cirri, il più è fatto. Se poi, a quei due tipi semiseri, aggiungete la loro creatività, musicale e fantastica, l’operazione-teatro esce alla perfezione. […] Mezz’ora scarsa, cronometri alla mano, per raccontare l’improvvida sfida del protagonista di riuscire, alle soglie dell’800, a compiere il giro del mondo, tra ferrovie, battelli e spostamenti improvvisati. Ma solo il primo tratto, quello che conduce il gentiluomo Fogg e il suo maggiordomo, Passepartout, da Londra a Bombay. […] Perché Fogg e Passepartout da Bombay si dirigano a Yokohama e poi da Yokohama arrivino a New York da dove ritorneranno al punto di partenza, la scenografia, minimalista, a quiz, spassosissima, bisognerà pazientare fino al 28 settembre, rappresentazione della seconda tappa e poi all’11 novembre, terzo e penultimo step.
Ogni rappresentazione, come quella di cui vi stiamo raccontando, sarà puntualmente replicata quattro volte ed è per questo che non ci permetteremo mai di svelare gli angoli di suspense, conditi da maestria ironica, di ogni singolo spostamento. Sofia Morano, al violino e Emma Longo al flauto, giovanissime strumentiste della scuola Mabellini, sono gli altri due elementi indispensabili alla vicenda: il sottofondo sonoro, ricercato, colto, ma sfrontato, fa parte del gioco complessivo di trattare, con l’intelligente simpatia che si deve all’autore, la trama fantastica di un romanzo che ha appassionato milioni di adolescenti; le contaminazioni contemporanee sono pertinenti, mai invasive, sistematicamente e puntualmente opportune, perfettamente allineate agli sguardi, distaccati, dei protagonisti, che mettono in risalto il loro camaleontismo, arma vincente della filosofia che dagli esordi contraddistingue la giovane compagnia teatrale. E ogni rappresentazione, molto probabilmente, confiderà nel mega schermo del mondo spiattellato, dove si appuntano identikit e banconote, come un vecchio Monopoli, con tanto di imprevisti e quiz, con i quali Sara e Claudio interagiscono ancor più massicciamente con il pubblico, preda, consapevole, della loro ilarità.
Uno sketch lungo meno di 30 minuti, un susseguirsi di storia racconta e letta su apposite brochure teatrali e battute improvvise, che sembrano appartenere al lirismo onirico di Verne, che si presta idealmente alla voglia di corretta rivoluzione che anima la coppia sul palcoscenico. Il Groove è esemplare, il risultato, stupefacente: vanno par che tornino, Sara Bonaventura e Claudio Cirri, sincronizzati alla perfezione nei tempi di un cabaret da piccolo schermo, dove incombe, regina, la pubblicità, che è l’anima commerciale delle loro rappresentazioni. Un lord inglese e la sua lady, che animano le conversazioni didattiche di Fogg e Passepartout e queste continue incursioni che altro non fanno che appassionare ulteriormente il pubblico già fortemente predisposto a lasciarsi cullare lungo la circumnavigazione della terra, con una calma incredibile nonostante la scena sia costellata dalla falsa ma riuscitissima adrenalina dei tempi tecnici, tanto del giro del mondo che della rappresentazione. L’uscita di scena, a bordo di una Lancia Fulvia che arriva da dietro una volta spalancati i portoni, è il degno epilogo a questo primo tratto di strada. Mancano gli altri tre, il viaggio è ancora lungo. Ci sarà da divertirsi».
Luigi Scardigli, www.lineefuture.it
Jules Verne spezzettato in frammenti, da Teatro Sotterraneo una compagnia che sa osare
«Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa sono le anime di una compagnia toscana che transita fuori dalle orbite canoniche e prestabilite del teatro contemporaneo. Si aggirano nel sottosuolo del linguaggio scenico, per scomporre e ricomporre classici o idee inedite, e poi risalire in superficie, in questo particolare caso, a Villa di Scornio (Pistoia). Riescono a stupire il pubblico con una nuova produzione, che parte come un normale reading e si trasforma in un gioco di società umanizzato, interattivo con il pubblico – in stile televendita -, dove il capolavoro di Jules Verne prende corpo.
Il giro del mondo in 80 giorni è un’opera universale e senza età, e Teatro Sotterraneo l’ha capito bene, scegliendo di districarla e restituirla alla purezza della sua scrittura apparentemente geometrica, vagamente impressionista. L’accompagnamento musicale dal vivo di due giovani allieve della Scuola Mabellini è una nota a margine, ma non ai margini, come una folata di vento improvvisa che trasporta in salotti ottocenteschi, come quelli in cui si muove quel personaggio enigmatico e misterioso che è Phileas Fogg. Eccentrico miliardario che accetta la scommessa di percorrere il giro del mondo in soli 80 giorni accompagnato dal suo fedele maggiordomo Passepartout. Un’avventura esotica al limite col reale, dove l’amore salverà la vita al suo protagonista. Teatro Sotterraneo ha ricalcato tutta la freschezza della narrazione, come una bottiglia di Champagne appena stappata. Fino alla sorpresa finale, inattesa, inaspettata. In scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri e un’imponente carta geografica, dove vengono segnate le tappe del romanzesco viaggio in nave, in treno e in sella a un’elefante, mentre i due attori stanno al gioco meta-teatrale di entrare e uscire dalle parti, per svelare i trucchi e i momenti caldi del racconto. Lo stratagemma di interrompersi per porre quiz al pubblico getta in un momento di spaesamento e insieme interesse che sollecita le sinapsi e rende il teatro un oggetto luccicoso, un carioca, un carillon in carne o ossa.
Incisive la presenza e la voce di Claudio Cirri, a cui si aggiunge l’indispensabile contro-parte femminile di Sara Bonaventura. L’idea alla base dello spettacolo pulsa, come una stella che sta per formarsi. […] Teniamo d’occhio Teatro Sotterraneo, cantiere in evoluzione della specie più protetta, i pensatori».
Tessa Granato, www.fermataspettacolo.it
«Dopo un brevissimo ma efficace riassunto si riparte. Continua il viaggio di Phileas Fogg e Jean Passepartout – interpretati da Claudio Cirri e Sara Bonaventura – brillantemente accompagnato dal polistrumentista Gennaro Scarpato, che si perizia di inventare musiche appropriate per ogni situazione e luogo geografico.
Le peripezie dei nostri eroi si susseguono con continui colpi di scena, mentre il pubblico si presta a essere, di volta in volta, cavia, coprotagonista, o concorrente di un quiz televisivo con domanda a tranello, contribuendo al procedere dell’azione. I momenti di suspense non mancano, soprattutto quando le vicende dell’impassibile sir con cameriere al seguito si scontrano involontariamente con le abitudini o tradizioni locali – tragicamente assurte alle cronache dei nostri giorni quando si tratti delle donne indiane, obbligate a seguire i propri mariti sulla pira funebre. Ma anche gli imprevisti si risolvono con genialità e ironia, intervallati ad hoc con un autentico giro del mondo musicale eseguito da Scarpato.
Lo spazio scenico, ridotto al minimo indispensabile, è brillantemente sfruttato per rendere al meglio – con l’ausilio di un oggetto o di qualche riga di descrizione – foreste selvagge, città brulicanti, cerimonie religiose, porti orientali, e i mezzi di trasporto più svariati. L’attraversamento dell’oceano su una goletta che si imbatte in una tempesta, è vissuto anche in modo tangibile dal pubblico presente (grazie al semplice utilizzo di uno spruzzino per le piante, con il quale Cirri irrora allegramente gli spettatori, tra il rullio della barca e il vento – quest’oggi anche reale – che fischia nella tempesta).
Ma le peripezie non finiscono qui. Perché Fix, il poliziotto che insegue Fogg credendolo l’autore di una rapina, deve fermare l’uomo a ogni costo. Il vino e l’oppio possono venirgli in soccorso e così, mentre il racconto descrive uno spaccato di vita del XIX° secolo, il tenero Jean si lascia andare a visioni che si materializzano nel giardino della Biblioteca San Giorgio – spiazzando lo spettatore ed entusiasmando il bambino sopito in ognuno di noi. Ma il tempo stringe, i minuti incalzano come i giorni che restano ai protagonisti per completare il loro viaggio. Il tempo sta per finire: l’uscita di scena, come nella tappa precedente, è inaspettata e spettacolare. L’appuntamento è già fissato a San Francisco: see you soon.
Pur essendo una prima rappresentazione, quella alla quale abbiamo assistito, i tempi sono già precisi e puntuali: persino la scelta di mettere in scena la seconda tappa all’aperto, con il vento sferzante che in alcuni momenti crea piccoli intoppi, mette meglio in luce la prontezza degli interpreti che risolvono le situazioni con battute brillanti. Le descrizioni o i monologhi troppo lunghi o mielosi sono stroncati con sintesi rapide ed efficaci. Mentre si alternano i racconti di situazioni e luoghi immaginari ma coerenti con il modo di pensare di un membro di quell’Impero Britannico fin de siècle certo del proprio diritto. In questa seconda tappa il viaggio, se possibile, si è fatto ancora più avvincente e ricco di colpi di scena. Restiamo in attesa della prossima puntata».
Luciano Ugge, www.persinsala.it
Il giro del mondo in 80 giorni sbarca alla Biblioteca San Giorgio a Pistoia. Esotico, affascinante, implacabile.
«Trasporre il romanzo di Jules Verne a teatro è, di per sé, un’idea brillante. L’insolita avventura è stata pensata dalla Compagnia Teatro Sotterraneo, collettivo di menti e attori, bravi a creare “pezzi unici” – con tutte le minuscole imperfezioni degli oggetti non seriali. Sara Bonaventura e Claudio Cirri diventano, a turno, i protagonisti di un’opera frizzante, narrata con realismo fumettistico, reso vivido e sfuggente dalla drammaturgia di Daniele Villa.
Suddiviso in quattro puntate (la prima è andata in scena a luglio), lo spettacolo si definisce reading ma è, in verità, performance racchiusa e, insieme, esplosiva; sottolineata dai suoni etnici del musicista Gennaro Scarpato, in scena live con un micro-cosmo di strumenti a percussione.
Lo stile è quello proprio di Teatro Sotterraneo: interattivo, imprevedibile, serrato – che amplifica il battito rocambolesco dell’originale letterario. […] I due giovani attori recitano ispirati alla tecnica del cosiddetto straniamento brechtiano, smettendo di interpretare Phileas Fogg o Passepartout, e tornando a essere loro stessi, in un gioco che coglie alla sprovvista, e mostra la finzione quasi come un oggetto della scenografia. Quest’ultima è, fra l’altro, imitazione di un gigantesco gioco da tavola a forma di carta geografica, dove scorrono i destini dei personaggi e dei pianeti, dove gli spostamenti e gli accadimenti avvengono apparentemente a caso, a seconda della cartella “pescata” dagli interpreti (un po’ come al Monopoli). Le domande al pubblico si fanno pungenti, in questo episodio; così come il contatto fisico e visivo con gli attori, i leggeri gettiti d’acqua vaporizzata sulle nostre teste, i souvenir inaspettati e improvvisi, i calmanti giri musicali del mondo, che trasportano in terre oltre oceano. L’immaginazione corre sempre più veloce, il tempo è capriccioso, il Teatro Sotterraneo diverte, il finale lascia, come sempre, a bocca aperta».
Tessa Granato, www.artalks.net
WAR NOW!
«WAR NOW! è il prezioso risultato di un lavoro produttivo che ha messo insieme diversi enti teatrali per poter vedere agita la regia collettiva del lettone Valters Silis e di Teatro Sotterraneo. WAR NOW! è costruito per mostrare pubblico e autori oscillanti tra adesioni estetiche a una realtà che è la nostra e il rifiuto di ciò che consideriamo inaccettabile. Un posizionamento forte e internazionalista consapevole di un presente così doloroso».
Lorenzo Donati e Nicola Ruganti, Il Giornale del Festival di Santarcangelo
«“I war you”. Devi scegliere, te lo chiede il sangue. Un cadavere è omicidio, tanti cadaveri sono politica. Chi uccidi? Chi salvi? La vita vale il suo sacrificio? A partire dal centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, WAR NOW! di Valters Silis e Teatro Sotterraneo, in prima assoluta al Festival, esplode sulla platea raffiche di domande ironiche e raggelanti, tutt’altro che a salve, preme paure ed esitazioni come il grilletto di una ‘pistola fumante’ che non finisce mai le munizioni. Sara Bonaventura e Claudio Cirri, con Matteo Angius della compagnia Accademia degli Artefatti a chiudere la triangolazione inquisitoria, sono tre pubblici ufficiali venuti a controllare la titolarità dei biglietti di viaggio della nostra sopravvivenza Prima, Durante e Dopo un ipotetico terzo conflitto mondiale. Nel loro continuo saliscendi tra la platea e la scena, ci colgono, manco a dirlo, impreparati, goffi, ridicoli, perché ormai diamo la pace per scontata e la guerra è solo immagini in azione sui giornali, in televisione, su Internet, a teatro: è immaginazione.
Dunque, l’allenamento al sangue versato, le domande del Prima che Angius, Bonaventura e Cirri rivolgono al pubblico sono la miccia, le risposte del pubblico sono l’ossigeno che la tiene accesa: rispondere ti mette nella condizione di pensarti lì dove cadrebbero le bombe. In teatro, adesso, durante lo spettacolo. Le parole, però, sono incerte, balbettate, insincere, nascondono il non sapere cosa dire di sé su qualcosa che non si è veramente vissuto, da vicino. WAR NOW! lo mostra con brutalità quando otto di noi vengono invitati sul palco a fare i Capi di Stato al summit internazionale che dovrebbe scongiurare il conflitto: restano in silenzio, non dicono nulla, perché non hanno niente da dire. D’altra parte, non sono stati chiamati proprio per questo?
La diplomazia fallisce e con essa la mediazione della realtà. Il Durante è perciò la rappresentazione della guerra come la conosciamo e comprendiamo: un po’ telegiornale delle 20, un po’ kolossal hollywoodiano, un po’ videogioco splatter. Angius, Cirri e Bonaventura entrano ed escono in rapida sequenza dal fondale (unico elemento scenico insieme a un tavolo), bocca atomica della finzione posticcia, polmone spettrale che respira le esplosioni di una macchina del fumo. Chiuso nell’ignoranza e nell’amorfismo, il pubblico è chiunque loro decidano che sia, tra gli estremi della vittima e del carnefice.
C’è un’unica cosa che riesce a dire di proprio. Arriva nel Dopo, alla fine di tutto. È la morte. Riguarda tutti, i vinti, ma anche i vincitori, che festeggiano la vittoria con discorsi cadaverici in cui l’umanità, il rispetto, il pudore sono spenti completamente. Siamo una lista di nomi incapaci di salvarsi, carne da cannone e da macello dello spettacolo contemporaneo del teatro e della società.
WAR NOW! dimostra, quindi, di avere una precisa visione della realtà che ci circonda. La prendono a cuor leggero e contento non per bamboccionismo, ma per precisa scelta artistica. “Combatti la nostra guerra” – dice Matteo Angius a un ragazzino a Terza Guerra Mondiale ancora in corso. Valters Silis e Teatro Sotterraneo sono adulti che non si sono dimenticati di essere stati bambini. E giocano non tanto per giocare, ma per creare uno spazio di libertà in cui riuscire a dirci l’orrore che siamo».
Matteo Brighenti, www.doppiozero.com
«Wanna play the game? Questa domanda grava su di noi, comunità estemporanea di spettatori, sin dal momento in cui ci riuniamo davanti al Lavatoio di Sant’Arcangelo di Romagna. Siamo in attesa di WAR NOW!, spettacolo nato da una collaborazione tra il regista lettone Valters Silis e la compagnia toscana Teatro Sotterraneo.
Formiamo una piccola coda in attesa che le ragazze all’ingresso scrivano i nostri nomi su un registro. Alla mia richiesta di spiegazioni rispondono vagamente, dicendo che saranno necessari durante lo spettacolo. Acconsento. Lasciare il proprio nome prima di uno spettacolo teatrale non può che sembrarmi un’azione innocua: l’informatizzazione contemporanea mi porta già a cedere i miei dati personali di continuo. É il primo abbandono, il primo, incosciente, gesto di partecipazione. Ho iniziato a giocare e neanche me ne sono accorta. Mi siedo in prima fila, con i piedi praticamente sul palcoscenico. Questo confine labile tra lo spazio del pubblico e quello della scena, é la prima cosa a colpirmi. Mi sento esposta.
Le luci restano accese quando lo spettacolo inizia, e i tre attori (in arrangiati abiti militari), iniziano la loro intervista al pubblico, creando una scottante situazione da talk show televisivo. L’atmosfera cambia, il brusio eccitato presente in sala si trasforma in imbarazzo nel momento in cui queste persone in divisa si fanno strada tra di noi, rivolgendoci quel genere di domande, scomode, che stanno come latenti nell’angolo della “probabilità remota” nella coscienza di ciascuno. “Hai mai ucciso?” La prima domanda mi sfiora, a rispondere è l’amica di fianco a me. Violenza, paura, sete di potere, non riconoscimento della reciproca umanità, mancanza di empatia nei confronti dell’altrui alterità (solo alcune delle scintille alla base di una guerra), ci riguardano e vengono dissodate attraverso domande sulla nostra vita quotidiana.
Intercettando qualche sguardo nelle file dietro di me, mi accorgo che siamo tutti in allerta, in attesa, incuriositi, intimoriti, cercando di prevedere le mosse degli attori e pensando a come reagirvi. Il contributo che ci viene richiesto, la nostra opinione su temi caldi, archetipici, sembra necessario allo svolgimento dello spettacolo. L’ironia con la quale incalzano le domande crea tante situazioni di divertimento, nelle quali il riso alterna il passo alla tensione, canalizzando le nostre risposte funzionalmente ad un discorso persuasivo, erede delle pratiche comunicative subliminali diffusesi con la nascita dei mass media.
Si tratta di un meccanismo partecipativo: le strategie propagandistiche inaugurate con la Prima Guerra Mondiale (il cui centesimo anniversario è proprio la sollecitazione fondante dello spettacolo) vanno a pizzicare corde emotive che portano ad immedesimarci in ruoli che via via diventano più scomodi e soffocanti. Nessuno, per quanto in difficoltà, si rifiuta di rispondere, tutti stiamo al gioco, per vedere come continua.
Questo susseguirsi di domande subisce man mano un cambio di rotta quasi impercettibile. Se inizialmente sembrano, infatti, volte ad una presa di coscienza della superficialità con la quale ci convinciamo di non essere coinvolti dalla violenza e dai conflitti, procedendo si trasformano in un’indagine di mercato volta a venderci l’inevitabilità di una Terza Guerra Mondiale. Veniamo, perciò, arruolati e sottoposti ad un addestramento al conflitto imminente.
La guerra inizia, le luci si spengono e io mi sento finalmente sollevata. Questa sensazione, però, dura solo un istante perché il ritorno al ruolo confortante di spettatore passivo viene utilizzato dagli autori del gioco come una trappola in cui siamo sottoposti ad un continuo ribaltamento di sguardo. Un momento siamo vittime e un momento carnefici, militari e civili, alleati e nemici, siamo costretti a posizionarci, nell’immobilità dei nostri posti, e a partecipare alla carneficina e al degrado dell’umanità.
Le situazioni messe in scena ci sono famigliari poiché attingono al repertorio variegato del nostro immaginario di spettatori. Arricchite dai toni epici dei kolossal hollywoodiani, sono state confezionate espressamente per golosi occhi di voyeurs. Quella a cui assistiamo è la rappresentazione della finzione massmediatica che viviamo ogni giorno, talmente integrata nel sostrato della ritualità quotidiana da essere divenuta banale.
Lo spettacolo dal vivo recupera la prossimità dei corpi. Annullata dalla mediazione di tecnologie come radio, televisione e internet, la ritrovata vicinanza genera un cortocircuito percettivo, dato dall’essere co-partecipi di una realtà che racconta una finzione che, a sua volta, racconta una realtà.
La rivivificazione di una realtà immaginifica svela, attraverso la compresenza degli attori e del pubblico, la struttura che la messinscena teatrale condivide con queste tecnologie dell’intrattenimento, un gioco di ruolo del quale siamo persuasi di essere i giocatori e del quale, invece, ci scopriamo oggetti/assoggettati.
Il gioco, sotto forma di rappresentazione teatrale racconta quella “società dello spettacolo” definita come “inversione concreta della vita, movimento autonomo del non-vivente”, dove i feticci visuali e culturali hanno il predominio nella riprogrammazione società, e le immagini, sviluppatesi ed accumulatesi fino al parossismo, hanno perso qualsiasi legame con la vita.
Il processo di “oggettificazione” dello spettatore si conclude nell’ultima parte del gioco, che coincide con la fine della guerra. Allora applaudiamo, attoniti, alla grottesca sequela di celebrazioni del trionfo della disumanizzazione dell’individuo. Non possiamo fare altrimenti perché, come sottolinea Giorgio Agamben, ci troviamo nella condizione di essere separati dalla nostra impotenza, abbiamo perso la nostra capacità di resistere. I nostri nomi vengono commemorati nella lista dei caduti. Siamo stati giocati, siamo tutti morti.
Il disagio insinuato da questo doppio gioco, a cui abbiamo accettato irresponsabilmente di prendere parte, evidenzia il bisogno di una partecipazione più consapevole, l’assunzione di uno sguardo critico verso l’apparente oggettività di ogni spettacolarizzazione, non solo della guerra, ma della vita quotidiana».
Carolina Farina, www.roots-routes.org
«La prima impressione è che si tratti in toto di un lavoro del Teatro Sotterraneo: è tipicamente sua l’evocazione di una terribile guerra nucleare attraverso i meccanismi di un’indagine di mercato (cosa fareste se questo edificio venisse bombardato? Chi si arruolerebbe?). È tipicamente suo il modo di interagire con la platea, trasformando gli spettatori in soldati o capi di Stato. È tipicamente sua la feroce terza parte, sull’inaugurazione di un ipotetico Teatro della Vittoria, con agghiaccianti discorsi delle autorità e stralunati contributi degli artisti. Meno riconoscibile, forse più estranea la parte centrale, relativa ai combattimenti, che fa pensare alla parodia di un film bellico. […] Ma anche gli spettacoli più apprezzati di Teatro Sotterraneo mescolavano d’altronde chiavi espressive diverse. E la capacità di affrontare temi importanti in un tono all’apparenza leggero e giocoso è l’aspetto che ha imposto il gruppo a livello nazionale».
Renato Palazzi, Il sole 24 ore
«Prendendo spunto dal centenario della Prima Guerra Mondiale, si immagina che sia scoppiata la Terza e come questo possa essere percepito/vissuto da chi, come noi, ormai la guerra è più che altro abituato a vederla in tv. Spettacolarizzazione dell’orrore che affascina morbosamente come un videogame. Non ci fa scoprire niente di nuovo il sotterraneo, ma è come lo fa dire/pensare pubblicamente agli spettatori, con le sue caratteristiche “inchieste”, a colpire, seppur in modo discontinuo, nel segno. Perché ammettere che, se ammazzi un topolino, sei un assassino, mentre se stermini un branco di topi ti stai solo difendendo, è un po’ come giustificare la necessità della guerra. E questa, e altre riflessioni simili, benché a tratti scivolino nell’ovvio, nel complesso funzionano. Soprattutto nella prima parte – l’addestramento per un conflitto prossimo venturo, un summit tra goffi premier reclutati tra il pubblico, il fallimento della diplomazia e della politica e lo scoppio della guerra – e nella terza dove la rifondazione post bellica è rappresentata dalla sinistra riapertura di un teatro popolato da tronfi militari, reduci rimbambiti, bandiere della pace in bianco e nero e bambini che declamano poesie guerrafondaie».
Claudia Cannella, Hystrio
«Se con Virgilio Brucia si rafforza il talento di Anagoor, Teatro Sotterraneo approda allo stesso esito grazie allo spettacolo WAR NOW!. Nell’anno della retorica della prima guerra mondiale, il collettivo costruisce, con l’ironia che lo caratterizza e una nuova cupezza che ferisce per la sua drammatica verità, le tre tappe di una possibile terza guerra mondiale, le quali anche in quetso caso palesano la stessa universalità tanto dell’agire quanto del subire umani […]. Con commovente intelligenza, entrambe le compagnie condividono con noi la riflessione sul fatto che nulla cambia, e per questo ci riguarda, in questo incedere propagandato delle ragioni e degli imperi sopra le nostre teste chine».
Claudia Gelmi, Il Corriere del Trentino
«Uno sguardo critico, posto di fronte a uno spettacolo del Teatro Sotterraneo, è costretto a muoversi in una duplice direzione: da un lato deve sostare sul palcoscenico, valutare le scelte registiche e l’intensità degli attori, il ruolo della musica e l’utilizzo dei costumi o delle proiezioni video. Dall’altro è tenuto a operare un cambio di prospettiva, quasi voltando le spalle al proscenio: a concentrarsi cioè sul pubblico e a osservarne le reazioni – spesso paradossali – che la celebre compagnia riesce a scatenare. Questa volta l’occasione è fornita dall’eventualità di un terzo conflitto mondiale: e gli esiti a cui conduce WAR NOW!, andato in scena sabato 15 e domenica 16 novembre al Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia, sono inaspettati e sorprendenti, forse anche tragici. Come una guerra. […]
Gli attori interrogano il pubblico: fino a dove possiamo spingerci, quando si tratta di difendere i nostri cari, o addirittura entità astratte come i nostri ideali o la nostra patria? Esiste una guerra giusta? Si può uccidere un nemico? Le risposte possono essere intelligenti, sagaci, addirittura ironiche: e il talento del gruppo risiede soprattutto nell’improvvisare con acume e sottigliezza per buona parte dello spettacolo, recependo impulsi e spunti da un pubblico imbarazzato e divertito. Già, divertito: e in questa risposta emotiva si situa il sottotesto di WAR NOW!
Prendendo in prestito il titolo di un saggio di Susan Sontag, sembra che “davanti al dolore degli altri” lo spettatore non sia in grado di provare alcuna empatia: anestetizzato da decenni di immagini televisive, si è ormai assuefatto a una dose pressoché quotidiana di orrore. E il pubblico del Piccolo Teatro Bolognini non fa eccezione: trattiene a stento una risata quando Bonaventura educa dei bambini immaginari a caricare una pistola, o quando Angius illustra come salvarsi fingendosi morti sotto una montagna di cadaveri. Non la guerra è oggetto del lavoro del Teatro Sotterraneo e di Silis, ma la percezione che di essa si ha attraverso i media: non a caso sul fondale vengono proiettate vecchie fotografie di città sventrate dalle bombe, o di colonne di persone in fuga.
Lo stesso fondale, opaco, serve nella seconda parte dello spettacolo a celare parzialmente alla vista un infanticidio eseguito con brutale freddezza: come la stessa Sontag notava, proprio l’impossibilità di distinguere con chiarezza il soggetto di una foto di guerra acuisce nell’osservatore il senso di turbamento. E tuttavia i tre attori ricercano un effetto volutamente grottesco: Angius, Bonaventura e Cirri mettono adesso in scena un un pastiche di segmenti cinematografici, reali o immaginati. Recitando muti, mentre il suono delle loro stesse voci registrate invade lo spazio, suscitano una strana e colpevole ilarità: sottratte alla sala cinematografica, le sceneggiature hollywoodiane sulla guerra risultano assurde, involontariamente comiche. Così come farsesca sembra essere la retorica post-bellica, la celebrazione ipocrita delle vittime e dei vincitori, il pacifismo comodo a cui il secolo appena trascorso ci ha abituato, e contro cui puntano il dito Teatro Sotterraneo e Silis nel segmento finale della performance.
WAR NOW! chiede moltissimo al pubblico, e dalle risposte degli spettatori dipende forse lo stesso successo dello spettacolo: è indubbio però che Silis e la compagnia di di Bonaventura, Cirri e Daniele Villa riescono perfettamente a stracciare quel velo di buonismo e falsa pietà con il quale non solo la politica e i mezzi d’informazione, ma anche noi stessi sembriamo celare un nucleo di indifferenza e distacco. Alcune risate, chiaramente avvertite durante lo spiazzante e geniale finale, sembrano confermare l’impressione: la guerra, purtroppo, non fa più paura».
Alessandro Iachino, www.teatroecritica.net
War Now! Noi, vittime di Teatro Sotterraneo e della realtà
«Non sono mai rilassanti, gli spettacoli di Teatro Sotterraneo. Non lo sono davvero, perché questo micidiale gruppo toscano ci ha dimostrato, da tempo, che l’interazione col pubblico è alla base del loro teatro. O dovremmo dire l’inte(g)razione: anche se le linee dello spettacolo sono inevitabilmente già scritte, e certi interventi degli spettatori vengono ricondotti in modo più o meno coatto alla direzione pensata, quella di Teatro Sotterraneo è comunque una drammaturgia partecipativa, tutta proiettata al coinvolgimento attivo della platea ed esposta ai suoi stimoli.
Ma con “War now!”, produzione dell’anno scorso ora presentata a Short Theatre 2015 (che finisce domani), non ci si può rilassare soprattutto perché è il nostro modo di reagire – emotivamente ed intellettualmente – ad essere talmente bombardato da stimoli da finire in tilt: un tilt positivo però, che esercita la nostra autocritica sulla vasta gamma di imbrogli cui ricorre la nostra logica mentre giochiamo ad un flipper grande come il mondo. […]
“War now!” si presenta come un trittico: c’è un “before”, un “during” e un “after”.
Al centro, lo scoppio di una Terza Guerra Mondiale che è non solo un memento, ma anche una rievocazione dei grandi conflitti passati, poiché lo spettacolo è nato in occasione del centenario della Grande Guerra. Il “Before” è una centellinata preparazione allo scontro. I tre attori sono, qui, puri performer in un palco vuoto. La scena si amplia e, astratta, include le risposte, le battute e gli imbarazzi degli spettatori interrogati. Uccideresti una zanzara? E un ratto? E un kamikaze, se ci fosse una ragionevole probabilità che stia per innescare l’esplosivo?
Con misura e arguzia, Teatro Sotterraneo governa il dialogo e le situazioni, sfruttando il registro ironico per trasformare con naturalezza un’azione semplice in dilemma etico, una questione di gusto in sfacciata violenza. Deridiamo la nostra inadeguatezza, come quando dobbiamo cercare maldestramente nello zaino, entro pochi secondi, gli oggetti indispensabili alla sopravvivenza. Ci stupiamo quando uno degli spettatori dà, ad una domanda molto generale, proprio la stessa risposta che stavamo pensando noi (come si fa in effetti a non avere antipatico il Liechtenstein?): un altro modo di sentirsi inadeguati, meno raffinati o originali di quanto vogliamo raccontarci, un altro modo di riconoscerci nostro malgrado prodotti culturalmente in serie.
Tra le tante opportunità aperte dalla drammaturgia partecipata, queste relazioni silenziose, innescate negli spettatori dalle loro stesse risposte, sono davvero un terreno fertilissimo da esplorare, che Teatro Sotterraneo sta già arando bene. […] E poi è di grande forza l’apparente facilità con cui scene sempre più violente s’innescano dalle altre: se siamo impreparati alla guerra, è giusto che la maestra insegni ai bambini come usare una pistola automatica («Bambini, NESSUNA PIETÀ!»); e sembra ancora un gioco, quando si tratta d’imparare a nascondersi sotto i cadaveri per avere più possibilità di sopravvivenza.
Il palco ospita un’inutile e improvvisata conferenza Onu: una decina di rappresentanti eletti lì per lì, soltanto a condividere il silenzio con i tre attori, che ormai sono soldati (anche nei costumi) e hanno preso il controllo della situazione.
Si entra così nella parte centrale dello spettacolo […]. Bombe, spari, torture, «tu resta qui», commiati romantici, mistica militare e bagliori nucleari: se non fosse chiaro, “During” è una parodia (in concentrato) dei film di guerra hollywoodiani. Coraggiosi, Silis e Villa, a spingere a fondo il pedale dell’azione, degli effetti (come l’uso massiccio dei bassi), insomma delle americanate: per mimare ancor di più la prospettiva cinematografica e far calare il pubblico nel circuito anestetizzante della narrazione bellica, ecco perfino la scelta (riuscita) di far recitare gli attori in playback. E conseguenza è anche che il pubblico torni, in questa fase, al suo ruolo osservativo.
Ma è nell’“After” che Teatro Sotterraneo dà il meglio di sé.
La scena è questa: a distanza di un anno dalla guerra, in ciò che resta del mondo post-nucleare s’inaugura un teatro fresco di ricostruzione. Taglio al nastro bianco e via, parte una carrellata d’interventi celebrativi al microfono (l’ambientalista, il direttore artistico, il reduce, la madre che ha perso il figlio) interrotta da mini-quadri performativi: la commozione scivola con nonchalance in parodia, in crudeltà, in tragedia, in virtuosismo (c’è anche una cosa a metà tra Stockhausen e il beat-box). Non si sa più, in sintesi, se ridere o piangere. O meglio: se si ride al grottesco, una parte di noi si sentirà davvero annichilita dal freddo gioco rappresentativo; ma cedendo all’emozione ci si sentirà stupidi, sapendo che mezzo secondo dopo l’attore avrà già smesso di disperarsi per la morte di un caro e ci starà proponendo i vantaggi del compost ottenuto dai sei miliardi di caduti.
Così, con la capacità di simulare ogni genere di format culturale, performativo, spettacolare, perfino emotivo, “War Now!” lascia gli spettatori – dopo averli tanto coinvolti – paradossalmente soli. Nel bel mezzo del diaframma tra finzione e realtà.
Non è uno spettacolo contro la retorica di guerra, questo: è uno spettacolo su come tutti subiamo i duplicati della realtà. Perché spesso è il nostro stesso pensiero a funzionare attraverso duplicati della realtà. E forse non possiamo farne a meno. Ma c’è una cosa che si può fare: non illudersi di essere salvi. Perché la lista delle vittime ci include, nostro malgrado; chissà non ne nasca un po’ di leopardiana solidarietà».
Michele Ortore, www.klpteatro.it
«Due giornalisti del Novecento, ossia Goebbels – autentico maestro di propaganda – e Orwell – il veggente un po’ orbo che ipotizzava una società dominata da un Grande Fratello (molto prima e molto più intelligente del reality, è ovvio) – si erano già accorti che il controllo delle masse passa attraverso il consenso e tale consenso può essere estorto manipolando informazioni e, soprattutto, codici linguistici. A questo punto la domanda conseguente è: cosa potrà mai accadere in una società come la nostra, globalizzata e monopolizzata da un pensiero sempre più unico? E, soprattutto, come tradurre in uno spettacolo teatrale – che non sia pedagogico o, peggio, demagogico – simili domande? Valters Silis – regista lettone di grande talento – e Teatro Sotterraneo – collettivo di ricerca teatrale pluripremiato e a ragione – riescono a coniugare perfettamente le istanze, confezionando un prodotto finale convincente e avvincente, che stupisce, diverte e fa pensare.
Sempre più spesso in Italia, infatti, è lontano dagli Stabili (e solo i politici sembrano non accorgersene) che la vera ricerca teatrale produce testi, regie, interpretazioni e messinscene che sorprendono e conquistano pubblico e critica. Ci vengono in mente tante formazioni […] che, come Teatro Sotterraneo, sperimentano nuove strade e ridanno linfa a un teatro troppo spesso da gerontocomio.
WAR NOW! è questo. Un incipit spiazzante con le luci che si spengono e poi si riaccendono, improvvisamente, per far partecipare il pubblico a una specie di talk show sul tema della guerra. Quando il pubblico medio (come afferma proprio una spettatrice) pensa di essere finalmente al sicuro e di poter staccare il cervello per un’oretta, ecco che – frizzanti e con un ritmo perfetto – Matteo Angius, Sara Bonaventura e Claudio Cirri iniziano a porgli domande sempre più problematiche, suscitando risate e silenzi – molto spesso imbarazzati. […]
Ma passiamo oltre, se prima della guerra ognuno ha la propria idea sul tema, è durante la guerra che non si può deviare da alcuni dogmi propri di qualunque conflitto: il nemico è di per sé disumano e Dio sta dalla nostra parte perché siamo noi ad avere ragione. Partendo dalla Prima guerra mondiale fino a un’ipotetica terza – quella che, secondo Einstein, avrebbe riportato l’uomo ai tempi delle caverne – i protagonisti di questa farsa grottesca mettono in scena tutte le situazioni più bieche e trite, tanto care all’immaginario collettivo, in un excursus sul film bellico dagli anni Quaranta a Salvate il soldato Ryan – uno dei peggiori polpettoni demagogici made in Usa.
Ma il peggio per questa nostra umanità deve ancora venire. La guerra finisce – quelle mondiali, a differenza di quelle locali, hanno almeno questo pregio – e quale occasione migliore per festeggiare la vittoria, della riapertura di un teatro? Un luogo dove celebrare la morte, umiliare i vinti, indottrinare i bambini, usare la pornografia del dolore per rinsaldare i legami di una popolazione stremata intorno alla leadership vincente. Finale in crescendo con la lettura dei nomi delle prime cento vittime del conflitto. Attenzione: perché potreste essere tra di loro».
Luciano Ugge e Simona Maria Frigerio, www.persinsala.it
«Un efficace ed intelligente lavoro sul tema della guerra che – come quello sull’amore – rischia in scena l’autodeflagrazione, a meno che non tratti, trasfigurandole, le idee e certi copioni traendole dai classici. Così non è stato per WAR NOW!, in prima regionale, che sembrerebbe pescare, ma non è così o almeno non solo così, dai linguaggi dei video games. In realtà molto è giocato, fin dalla costruzione drammaturgica dell’incipit, sull’interazione col pubblico. […] Il plot narrativo, solo apparentemente sconnesso, procede per azioni sceniche interattive col pubblico fra flash back e incursioni nel futuribile, quale fosse un fantasy per microstorie di famiglie davanti la TV. Ci sono molte azioni fisiche sopra e sotto il palcoscenico, fra il pubblico, una narrazione franta, domande e dialoghi in presa diretta con gli spettatori secondo lo stile di Sotterraneo, ritmo veloce che per questo potrebbe sviare verso la visionarietà estetica un po’ prossima alla forma delle video performances.
In scena tre attori di grande forza espressiva (Matteo Angius, Sara Bonaventura e Claudio Cirri), che si immedesimano in situazioni di guerra. […] E provano a raccontarci una storia impossibile sullo scenario mondiale, attualissimo al punto che nella estrema azione di coinvolgimento del pubblico – assai consenziente – portano sulla scena gli “attori” afoni di una impossibile trattativa diplomatica internazionale. Il tutto con leggerezza mescolata alla ferocia indossata dalle loro tute militari, dalle loro maschere fasulle fra strazio e cinismo etico ed etnico – e qui l’influsso della co-regia di Silis è pulsante..
Ciò che emerge da questo laborioso complesso lavoro è la disinvoltura del catturare il pubblico per, alla fine, rovesciare i ruoli da attivi in passivi e viceversa: insomma alla fin fine il coup de théatre è che i morti siamo noi.Questa operazione fa riflettere sulla tragedia delle guerre. Perché ci induce a soffermarci sul fatto che l’odio chiama odio. L’ultima sezione […] rimbalza sulla umanissima, purtroppo, condizione di chi dopo eccidi ed eccidi, anche di fronte alla Terza, evocata, Guerra Mondiale, dichiara che vorrebbe riprendere ad ammazzare tutto e tutti. Ma l’occhio per occhio, si sa, non può che produrre ulteriori lutti, e questo meccanismo psichico umano del “te la farò pagare” è molto ben rappresentato in WAR NOW!.
Questo bel lavoro è un inno al pacifismo, al far riflettere sullo stereotipo così umano della vendetta che può solo chiamare e sviluppare a sua volta odio e sangue: ma quali bandiere sventolare se alla fine nessuno vince e tutti siamo sconfitti? È un lavoro contro la retorica dei vincitori. […] Perché la guerra è adesso e dobbiamo, da vivi, vigilare. I mostri sono fuori e dentro di noi tutti».
Renzia D’Incà, www.rumorscena.it
«Teatro Sotterraneo e Valters Sīlis presentano invece uno spettacolo che immagina cosa accadrebbe se gli uomini entrassero nella terza guerra mondiale. Esso si divide in tre parti: una prima che descrive il periodo pre-bellico, una seconda che rappresenta il conflitto in atto, una terza che mostra la fondazione di un nuovo teatro, dedicato alla memoria dei caduti e che intende lanciare il segnale per il quale la ricostruzione di un’umanità nuova parte dalla cultura. Il livello di approfondimento di ciascuna sezione non è omogeneo. La parte centrale è ad esempio meno convincente delle altre […]. Decisamente più interessanti sono le altre due sezioni, dove i performer guidano gli spettatori, a volte coinvolgendoli in dei role-playing o interagendo direttamente con loro, ad accettare la guerra come qualcosa di normale e persino provvista di una propria attrattiva estetica. […] Nella seconda sezione, si allude in maniera anche non troppo velata che, dietro le belle parole, il teatro che è stato appena fondato pensa la cultura come uno strumento di esaltazione delle guerre trascorse e di apologia di quelle future. Qui, infatti, si presentano concerti ispirati ai bombardamenti, spettacoli che rievocano gli atti eroici o criminali condotti nel conflitto precedente e si creano installazioni visive che usano quale materiale primo i corpi dei caduti. WAR NOW! mostra così come l’arte teatrale possa edulcorare l’orrore e anestetizzare il dolore di cui una guerra è intessuta, fino a farla diventare addirittura piacevole».
Enrico Piergiacomi, www.teatroecritica.net
«“Nooo… e io che credevo di venire a teatro tranquilla. Ora, pensavo, si spengono le luci e invece…”. Risponde così uno degli spettatori al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia e nel frattempo WAR NOW! è già iniziato: con le luci riaccese sulla platea e con Matteo Angius (Accademia degli Artefatti), Sara Bonaventura e Claudio Cirri (Teatro Sotterraneo) che scendono in mezzo al pubblico e lo bombardano di domande a bruciapelo. Non ci sono certezze, non c’è una consolatoria distanza tra un “noi” e un “loro”. […] L’interrogatorio sembra caricato da mortaretti futuristi che deflagrano in un instant war game in cui ci sentiamo pesci fuor d’acqua. D’altronde la Terza Guerra Mondiale è ora! Per gioco? Neanche questa domanda ha una risposta sicura e sembra che il punto esclamativo dello spettacolo le faccia franare il terreno sotto i piedi. […] Il tavolo della diplomazia, cui alcuni di noi partecipano salendo sul palcoscenico, fallisce, perché non c’è dialogo. Il risvolto machiavellico dell’arte di trattare sulla scena mostra l’altra faccia, quella di sconosciuti silenziosi. Gli anfibi neri, i pantaloni chiari e la polo bianca dei tre attori lasciano allora il posto a tute nere militari, mitra e maschera antigas: è il tempo del Durante e del buio in sala.
Un collage di scene belliche, un assemblaggio per accumulo su un teatro di guerra che, sì, non ci mostra nulla di nuovo, ma a inquietare non è tanto il “cosa” bensì il “come”. Violenze, dettagli splatter, urla, mitra puntati: una sorta di lungo piano sequenza che se da un lato sembra incedere nell’ovvietà e nei parossismi dei war movie americani, dall’altro – e forse proprio per questo – ne denuncia l’affastellamento anestetizzante in cui tutto è equiparato su uno stesso piano tecnico mono-tono.
In questa maniera allora il Dopo non è che un’ulteriore provocazione, in cui tornano anche i toni sarcastici e grotteschi del Prima (nonché l’abbigliamento iniziale). È giunto infine il tempo di ripartire e lo si fa dalla cultura: l’inaugurazione di un sinistro e cinico Teatro Vittoria, con tanto di taglio del nastro e commemorazioni arlecchinesche, in cui i “colori” sono solamente sfumature di grigio. È la Guerra – ora! – ad esser confezionata come un ready-made. Una Guerra cui siamo ormai indifferenti e che viene rimessa provocatoriamente in scena, in modo lucidamente ludico, per tentare di sottrarla alla banalità: a noi infine la responsabilità di scegliere se contemplarla o coglierla attraverso uno sguardo altro».
Manuela Margagliotta, www.paperstreet.it
«I tre ragazzi di Teatro Sotterraneo crescono di recita in recita, copione in copione e stavolta, a differenza delle precedenti uscite, tutte pregevoli, utile ricordare, si sono messi all’anima una scrittura particolarmente impegnata, più che impegnativa, dove il surrealismo fassbinderiano rappresenta puntualmente l’incipit, per poi scendere e sviscerarsi tra i meandri del tragicomico, in una corsa sonora e sincopata, verso la fine.
L’esordio è quello che li contraddistingue: Sara Boventura, Claudio Cirri e Matteo Angius si spacciano puntualmente per conduttori radiofonici, con un invidiabile ritmo da emittente privata, facendo confusione, tanta, ma senza sovrapporsi mai, l’uno all’altro. Si spintonano verso i blocchi di partenza come se ognuno volesse che il testimone per la prima batteria lo prendesse un altro, ma quando lo start spara in aria, chiunque debba coprire il primo tratto, parte a razzo, senza incappare mai in una falsa partenza.
Ieri era la terza guerra mondiale l’ordine della serata teatrale, introdotto con il panegirico della diretta con il pubblico, che in un modo o in un altro, con risposte guidate o stravaganti, al nastro, il copione, lo portano puntualmente. Idea e regia, stavolta, seppur manipolate dagli artefici, arrivano da fuori le quinte, con Valter Silis, e il percorso si muove veloce, senza pause. Anche i cambi repentini di scena e di umore vivono una diretta adrenalinica degna di professionalità: il feeling cresce, come la dimestichezza. […]
Anche la scenografia inizia ad impreziosirsi: tute mimetiche, amplificazioni stereofoniche, maschere antigas sono meno artigianali del materiale da gags delle precedenti esibizioni; restano, tutti e tre, molto keatoniani, ma senza trincerarsi dietro un mutismo che non reggerebbe. Anche il coinvolgimento fisico ed emotivo si è fatto più tenace, meno marginale, più invasivo. […] Dolore, morte e atrocità continuano imperterriti a vivere e convivere con un sarcasmo sadico, che fa comunque sorridere».
Luigi Scardigli, www.lineefuture.it
«WAR NOW!, di Teatro Sotterraneo e Valter Silis, […] è una dura e partecipata riflessione sul tempo storico che l’essere umano sta vivendo, nella ricorrenza del centenario della Grande Guerra.
In una scena grigia, senza vita, tre attori irrompono immediatamente nella vita del pubblico facendolo partecipare attivamente ad una grande riflessione sulla guerra. Ci si trova di fronte ad un vero e proprio addestramento verbale al “Facciamo finta di essere in guerra, qui e ora”. Sono state chieste opinioni brusche sulla morte, sull’omicidio, sull’alterità, intervallate da informazioni pratiche sul cosa fare in caso scoppiasse una terza guerra mondiale all’uscita del teatro. L’addestramento partecipato è sfociato in una scena da film americano in cui il pubblico è tornato ad essere spettatore e ha assistito a parodie sul patriottismo, provando amarezza, paura, senso del ridicolo.
La guerra poi finisce, l’atmosfera post-atomica è densa e, nonostante la sempre presente immagine di spocchiosità patriottica creata dal nostro secolo, si assiste ad una carrellata di situazioni post belliche, quotidiane, umane, che alternano le lacrime alla volontà di combattere. Pillole molto veloci, sketch, assaggi di situazioni che tutti noi abbiamo visto solo nei colossal americani, sempre con in sottofondo la rimembranza del “non si sa mai”. Un momento molto particolare suggella lo spettacolo, un richiamo al pubblico usando una modalità differente di interazione, più intima e toccante, che preferiamo non svelare».
Giovanna Rovedo, www.nucleoartzine.com
BE LEGEND!
Renato Palazzi, Il Sole 24 Ore
«Con BE LEGEND!, dove immagina l’infanzia tradita di Amleto e Giovanna d’Arco, Teatro Sotterraneo prosegue nel depotenziamento del teatro e fa intravvedere nuove strade».
Anna Bandettini, La Repubblica
«I Sotterraneo […] sono ancora pieni di trovate, mai fini a se stesse, di ganci, di appigli, di quel quid che fa poesia, gag che diventa pensiero, gesto che si fa riflessione. Leggero e profondo che vanno a braccetto e s’intersecano come il vortice del dna. Come la vita. […] Immedesimazione, rappresentazione, identificazione. Chi siamo, chi siamo diventati, chi avremmo potuto essere, è la grande riflessione alla quale, tra le risate, il loro codice di scardinamento, ci costringono i Sotterraneo. Il mio nome comune sarebbe potuto diventare vessillo da bocca in bocca nei secoli? Non si tratta soltanto di essere “famosi”. […] Ecco la trasversalità, la commistione di eterno e attuale, di modernariato d’idee, di rimescolamento, frullato, centrifugato di storia e presente. Bambini che avrebbero potuto essere tutto l’infinito che non sono stati. Crescere è come entrare in un tunnel dove ad ogni passo altre porte si chiudono e si diventa sempre più ciò che stiamo divenendo fino al punto di non ritorno che non è la morte ma l’adultità. Gli eroi son tutti giovani e belli. […] Come a dire che altri Amleto, altre Giovanna, altri Hitler adesso, oggi nel 2013, sono piccoli ma stanno crescendo, oppure siamo ancora in tempo a cambiare, migliorare, far virare il loro destino. Sono in mezzo a noi […]. Non esiste destino, la storia di ogni uomo è la somma, e le scelte, di ogni giorno vissuto».
Tommaso Chimenti, www.rumorscena.com
«Daimon, vocazione, ricerca di identità e catastrofe. Questi i temi affrontati da Teatro Sotterraneo in BE LEGEND! e in BE NORMAL!, due nuove differenti produzioni, autonome e allo stesso tempo legate da una scrittura drammaturgica (e scenica) in fieri, che non solo si modellizza sul dispositivo televisivo (nello specifico il format del serial) ma che assume valore nella continuità e nel riflettersi dei due differenti progetti. Da un lato l’infanzia, il lottare per l’essere al mondo, o, più semplicemente per dare una risposta alle motivazioni di quello stesso essere. Eroi tragici e personaggi storici sono portati in scena attraverso una reinvenzione del loro passato, attraverso un lavoro di immaginazione sulla loro infanzia, concretizzata, in scena, nel corpo di bambini scelti e coinvolti nel luogo in cui si svolge la performance. Dall’altro una coppia di adulti sorpresa in una quotidianità standardizzata, unico appiglio di una vita consumata e senza prospettive. […] Da un lato il ricordare perpetuo, la tensione verso un’aspettativa di vita, la fragilità del mondo infantile, dall’altro le macerie di un universo che supera la postmodernità e che si proietta verso un “the end” brandizzato come fotografie postprodotte in cui trovare rifugio».
www.dreamcatcher2013.iltamburodikattrin.com
«Bisogna ammettere che Teatro Sotterraneo continua ad avere voglia di sperimentare. Sara Bonaventura e Claudio Cirri si muovono tra i testi scritti da Daniele Villa con il consueto tono dimesso, il ritmo alto, il coinvolgimento diretto del pubblico, il sarcasmo pronto nella manica e la vis dissacrante».
Sergio Lo Gatto, www.teatroecritica.net
«Sara Bonaventura e Claudio Cirri accompagnano, accudiscono, angariano con alterne fortune tre bambini che interpretano un’idea di infanzia “celebre”, o meglio un’idea di infanzia sconosciuta di vite – reali, mitiche o immaginate – celeberrime.
Il daimon è un’entità proveniente dal complesso pantheon greco che sta a metà tra l’umano e il divino, e che dell’umano era considerato responsabile e stimolo di certi comportamenti. Eros per esempio era un daimon, così come lo era quello che Socrate indicava come suo prediletto suggeritore. Oggi da dove arrivano gli stimoli che ci rendono ciò che siamo? È questa la domanda della drammaturgia di Teatro Sotterraneo (testi di Daniele Villa) che […] compie uno scarto ambizioso quanto delicato nel lavoro “leggendario”.
Il climax perfettamente costruito – con ampio uso di referenti pop, ironia, sdoppiamenti tra voce narrante e personaggio dei due attori in scena – ha il suo apice con l’episodio del piccolo Hitler (la scelta non è immune da momenti controversi, che sollevano dubbi, tutto sommato legittimi, sull’opportunità di esporre i bambini in scena a immagini esplicite dell’Olocausto, a fargli mimare la morte, a ballare avvolti in una bandiera con la svastica). Sarà stato davvero così cattivo “il male assoluto” a nove anni? E quanto è cattivo pensare una Storia senza di lui? Se potessi uccideresti il piccolo Hitler per fermare l’orrore che è destinato a provocare?
L’infanzia è un’entità complessa, un tempo decisivo e aperto alle influenze più disparate e per questo è soprattutto un tempo dell’uomo protetto e controllato. Scegliendo di inventarsi tre gioventù celebri Teatro Sotterraneo solleva – come detto anche radicalmente – una campana di vetro dall’infanzia contemporanea.
Le ragioni non sono solo nel lavoro con i bambini – che si sentono raccontare la fine tragica della loro storia – ma soprattutto nella spericolata indagine sugli stimoli e le prassi della crescita, sulla distanza tra sogno e destino, innocenza e colpa. E se il tono generale è apparentemente lieve, sorridente, ironico le implicazioni sono tutt’altro che innocue, andando a mettere il pubblico nella scomoda posizione di domandarsi, moralmente, quali effetti la propria prassi quotidiana – prima ancora che la società in cui siamo immersi – provoca nella formazione della personalità di un futuro adulto».
Giacomo Lamborizio, www.paperstreet.it
«Nel teatro l’utilizzo di attori bambini e di animali presenta sempre qualche problema. Nello spettacolo in questione l’animale era un orsacchiotto, mentre il bambino aveva un istinto innato per i tempi comici. Il che non guasta se impersonifichi il giovane Amleto, ignaro delle avversità che la vita gli proporrà e illuminato da un candore infantile. L’anno scorso Teatro Sotterraneo riuscì a lasciare gli spettatori del BE Festival a bocca aperta, ed è per questo che la compagnia ha fatto il suo ritorno dopo un periodo di residenza presso il Warwick Arts Centre. Un ritorno ancora una volta sensazionale, con una collezione di brevi biografie di personaggi famosi. Secondo il format dei live show (sulla scia del genere dei mockumentary) il giovane Amleto viene rappresentato come un bambino cresciuto nella bambagia, in un ambiente opprimente, il quale custodisce gelosamente una collezione di cose morte. Il pubblico è invitato a osservare, comprendere e provare empatia verso questo ragazzino affetto da angosce, la cui infanzia (qui pensata in modo esilerante) lo porterà a vivere una vita in declino come descritta dalla penna di Shakespeare. Spesso capita di assistere a un’opera teatrale senza domandarsi quale siano gli eventi passati che hanno portato i protagonisti ad essere ciò che sono o il perché agiscano come agiscono. In questo spettacolo ci viene concesso di seguire uno dei ‘passati’ possibili, in cui la vita di palazzo viene descritta in modo sagace; ciò permette allo spettatore di figurarsi il personaggio in tutta la sua interezza, e non come fosse stato ibernato e scongelato solamente al momento di salire sul palco. Qui sta la bellezza dello spettacolo di Teatro Sotterraneo, ovvero la sovversione di ciò che supponiamo essere vero e la manifestazione di opinioni convergenti. E’ lecito non trovarsi d’accordo sulle modalità qui adottate per rappresentare l’infanzia di un personaggio immaginario, tuttavia al contempo è necessario rispettare il modo scelto per trasmettere tale idea, resa spassosa, divertente e accessibile anche grazie all’uso di alcuni passaggi celebri della piece originale, atti a rafforzare il personaggio e a radicare il giovane Amleto nel contesto di eventi passati. In scena troviamo solamente una casa giocattolo dove Amleto nasconde la sua collezione di cose morte; la semplicità ed eccellenza di tale scelta scenografica sta nella sua creatività. Le canzoni scelte (‘Creep’ dei Radiohead e ‘Hard Knock Life’ di Jay-Z) sottolineano l’intento di illustrare il tipo di personaggio che Amleto ricopre e ricoprirà, mentre gli scampoli dal futuro si rivelano espressione di un umorismo nero se dati in mano a un bambino di dieci anni. Uno spettacolo di alta qualità, pertanto non sorprende che Teatro Sotterrano sia stato nuovamente invitato quest’anno a presentare il proprio lavoro nell’ambito del BE Festival: dobbiamo aspettarci senza dubbio una piacevole sorpresa».
Kirsty Emmerson, www.ayoungertheatre.com
«Solo a quei pazzi di Teatro Sotterraneo poteva venire in mente di prendere tre bambini di 10 anni da un laboratorio per fargli interpretare personaggi “storici” del calibro sinistro di Amleto, Jeanne d’Arc e Hitler. BE LEGEND! è un esperimento seriale, una sorta di spassosa docufiction ideata e diretta da Daniele Villa, Sara Bonaventura e Claudio Cirri, incentrata sull’infanzia di alcune delle superstar della letteratura, dell’arte e della storia. La formula è semplice: trasferire in teatro la ricetta vincente delle web-series. Velocità, ironia, irriverenza diventano così gli ingredienti chiave di questi tre mini-spettacoli acuti e divertenti, eppure mai noiosi o scontati. Tre pezzi di geniale bravura».
Cakes, Milanozero
«In tre quarti d’ora di spettacolo si è riso, e molto […]. Il duo adulto ha portato sul palco i tempi comici giusti per dare forza alle trovate surreali di “Be legend!”. Quando, però, il microfono è stato passato ai genitori di Eugenia e Marco, perché raccontassero le giornate dei loro figli, il sorriso si è trasformato in emozione. In un crescendo, c’è stato pure qualche occhio lucido in sala nei finali in cui Amleto e Giovanna d’Arco hanno interpretato la loro morte da adulti. Bravi, bravissimi, i Teatro Sotterraneo per uno spettacolo che tra umanità e originalità è stato una sintesi di B.Motion 2013».
Lorenzo Parolin, Il giornale di Vicenza
«Un bambino e una bambina vestono i panni di Amleto e Giovanna D’Arco: quello che vediamo è impressionante perché mostra quanto sia disarmonica e dissonante la condizione di bambini rispetto al futuro di vita (tragica) che li attende. È questo confronto che sciocca lo spettatore, questa infanzia che sfugge dalle mani, ma resta nei corpi dei piccoli. Vediamo così un piccolo Amleto di otto anni provare la sua morte o una Giovanna D’Arco non rinnegare nulla di quello che ha fatto (anzi che farà). E allora la domanda “Cosa vuoi fare da grande?” si spreca, restano parole nel vuoto di un destino già segnato. Teatro Sotterraneo porta in scena una preziosa intelligenza di scrittura e di pensiero che sa anche fare ridere, ma soprattutto sa segnare nel profondo chi è presente e osserva i bambini in scena».
Ilenia Carrone, www.doppiozero.com
«BE LEGEND! è un lavoro ironico sulla domanda spesso rivolta ai bambini “Cosa vuoi fare da grande?”. Piuttosto che dare spazio ai sogni e alle aspirazioni dei tre bambini in scena, Sara Bonaventura e Claudio Cirri sono gli adulti che li mettono di fronte ai sogni e alle aspirazioni possibili di tre figure storiche: Amleto, Giovanna d’Arco e Adolf Hitler.
Non è chiaro se queste figure assegnate loro siano state pensate a partire da alcuni comportamenti visti nei bambini, o se quello che alla fine fa ridere il pubblico è proprio la dissonanza tra i piccoli personaggi ignari e gioiosi, su cui gli adulti hanno riversato queste aspettative tanto epocali, e la predestinazione a compiere ogni genere di efferatezza. […] Di fatto, i bambini in scena non sono attori, ma agiscono l’imposizione del loro personaggio, anzi vi reagiscono. E vi reagiscono contrapponendo sempre la voglia di giocare e di non curarsi per niente dei drammi degli adulti. Amleto, infatti, vuole giocare a pallone, ma il suo destino d’erede al trono lo sottopone a un regime in cui tutto è controllato. I cibi vengono assaggiati, i palloni forati, qualsiasi cosa possa essere toccata dal giovane principe è prima distrutta dai due attori che rappresentano il controllo della sua storia a fini più grandi. Jeanne d’Arc è invece un’esplosione di euforia, una trottola che schiva la determinazione imposta dagli adulti, anche quando ride della sua futura morte sul rogo. Allo stesso modo, la figura di Hitler è duramente imposta a un bambino che reagisce ripetendo in loop “io non sono il male assoluto”, “io non sono il male assoluto”, “io non sono il male assoluto”, per cui, la reazione al dover a tutti i costi “diventare qualcuno”, in questo caso sembra risolversi in un’altra forma di disagio. Per fortuna il finale grottesco sulle note dance di Eins Zwei Polizei (Mo-Do) trascina via l’ansia del pubblico e riscopre il gioco delle parti»
Mariaenrica Giannuzzi, www.nucleoartzine.com
«Le aspettative erano alte e i “ragazzi” di Teatro Sotterraneo ci hanno ripagato pienamente con un’altra chicca. Tre anni fa, l’apocalittico Dies irae della preziosa compagnia di ricerca fiorentina era arrivato dritto nella pancia come una scheggia. E BE LEGEND! […] ha nuovamente insinuato dubbi, incrinato certezze. Ha fatto riflettere, ridere, commuovere. Un gran bel pezzo di teatro, ma di un teatro al cubo, rovesciato come un calzino, frullato con la vita vera, tra realtà, storia, fantasia e finzione, narrazione, performance e laboratorio, per restituire uno spettacolo originale e spassoso, scritto con dissacrante intelligenza e condotto con acume e sapienza. BE LEGEND! mette nelle mani di tre (bravissimi) bambini non-attori (reclutati ogni volta di città in città) l’infanzia e la storia di altrettante figure storiche colossali: Amleto, Giovanna D’Arco e Hitler. […] Il destino di morte che li accomuna si svela gradualmente in un profluvio di piccole gag, cinica ironia, tagliente sagacia, in cui i bambini lottano caparbiamente per affermare la loro attitudine e i grandi (sineddoche delle istituzioni tutte) stentano a capirli per poi poterli guidare, sostenere o correggere. E alla fine, come testimoni imbelli, non fanno altro che infliggere loro una sorte già scritta».
Paolo Schiavi, Libertà
«Sara Bonaventura e Claudio Cirri hanno allegramente riproposto il loro repertorio didattico-drammaturgico dando un esilarante non senso a tre vite storicamente incancellabili, come il dubbioso personaggio shakespeariano, la martire francese e il dittatore tedesco. L’esperimento, anche stavolta, è riuscito […]: in questa circostanza il connubio tra cultura – termine che sovente stride con la magnifica innocenza e spensieratezza adolescenziali – e infanzia è veramente felice, produttivo, mirato. Si affrontano tematiche importanti, per le quali occorre necessariamente documentarsi; si recita, rispettando a pieno i canoni del palcoscenico e ci si diverte, parecchio, protagonisti e spettatori, dando così alla comunicazione i suoi migliori contenuti».
Luigi Scardigli, www.lineefuture.it
«Tre personaggi storici riportati all’infanzia e all’ingenuità del loro essere, prima di tutto, esseri umani. […] Tre divertenti riduzioni all’assurdo, che poi così assurdo non è, in cui il mito si fonde e confonde con la realtà grazie all’alternanza di commedia e dramma. Giovanna, ad esempio, dopo aver brandito con rabbia una spada di legno confessa alla madre e al pubblico di voler far la cuoca: in quel momento la realtà subentra prepotentemente ricordando ai giovani che il destino, o meglio, la storia, ha in serbo altro per loro».
Michele Galardini, www.reportpistoia.com
BE NORMAL!
«Due i lavori da applaudire: uno è BE NORMAL! versione definitiva, con cui Teatro Sotterraneo ritrova l’efficacia del suo linguaggio teatrale secco e ironico, un “misurato irrealismo” sulla dura vita dei trentenni […], creando spazi diversi e una sovrapposizione di tranche de vie sempre più parossistiche e amare».
Anna Bandettini, La Repubblica
«Il linguaggio inconfondibile del Sotterraneo […] chiude il dittico con BE NORMAL!, il funerale (con tanto di piccola bara) di una generazione […]. Un’altra loro analisi vivace che fotografa l’amara realtà di aspirazioni stellari e squallide frustrazioni terrene».
Tommaso Chimenti, Il fatto quotidiano
«Non solo ironico, spiazzante e ben ritmato – come quasi ogni spettacolo del Teatro Sotterraneo – BE NORMAL! sa riflettere in modo originale sul conflitto fra generazioni di oggi, sui giovani che si confrontano con ambizioni spesso irrealizzabili… […] Divertente e denso. Complimenti davvero. Da vedere».
Gherardo Vitali Rosati, www.gherardovitalirosati.it
«Ecco ora una storia di ordinaria normalità. Quella di una coppia di trentenni, un maschio e una femmina, che si trovano ad afrontare una giornata qualsiasi […]. Ma la cifra di Teatro Sotterraneo, che certo non è mai stato incline né al realismo né ai piagnistei, imprime quello scarto da straniamento brechtiano in versione pop capace di affondare la lama nella carne viva di un problema ridendoci sopra. […] Un fuoco di fila di arguti paradossi scandisce la loro giornata: […] sono brevi, diaboliche scene scandite dalle ore di una giornata senza prospettive. Si ride per non piangere di questa quotidiana lotta generazionale più per la sopravvivenza che per la cura del proprio daimon. Ma è anche vero che la beffarda “rabbia giovane” ndel gruppo fiorentino è un invito tra le righe a non arrendersi».
Claudia Cannella, Hystrio
«“Nella società c’è posto solo per uno dei due: voi o il vostro demone. A voi la scelta”. E la scelta pare che Teatro Sotterraneo l’abbia fatta con una certa chiarezza, in questo BE NORMAL!, spettacolo – parte del più ampio Daimon Project – tutto orientato alla devastazione del proprio daimon, cioè le proprie ambizioni, sogni, destini.
Però, come in quasi tutti i lavori di questo gruppo, le cose non sono così semplici come sembrano. Perché, da un lato, tutti i micro-episodi di cui è composto BE NORMAL! si fondano sulla messa in discussione, in ridicolo e alla porta dei daimon (voglio fare l’artista, sogno di fare l’astronauta…), che non possono sopravvivere in tempi di crisi come questi, in cui appunto si fa già fatica a sopravvivere in senso stretto; dall’altro, è proprio attraverso l’arte che Teatro Sotterraneo sceglie di raccontarlo. Come se il punto di equilibrio fra l’influenza del proprio daimon e le condizioni reali, fra le proprie ambizioni e la sopravvivenza fosse invece un punto di disequilibrio che vibra della tensione che si innesca fra i due poli.
È qualcosa di fortemente identitario, radicato, determinante. L’esito è quello di un autoritratto generazionale spietatissimo. Dove i giovani sono costretti ai lavori più umili, mentre i potenti li rapinano del loro presente e del loro futuro; dove la gerontocrazia impera a scapito delle nuove generazioni; dove queste ultime si trovano spiazzate, bloccate in un eterno presente che non consente possibilità di crescita; e dove l’aspirazione alla realizzazione dei propri sogni e ambizioni viene esclusa a priori (c’è addirittura il corso, supportato da vignette videoproiettate, su come uccidere il proprio daimon fin da bambini).
L’esagerazione è la norma in questo spettacolo. Ma se sembra grottesca la scena del colloquio di lavoro gestita da una voce computerizzata che, alla fine, per la “prova pratica” ordina al candidato di uccidere un ostaggio, la cosa non risulta poi così surreale, se si pensa che ai colloqui vengono richieste le competenze e disponibilità più impensabili, anche oltre ogni ragionevolezza, buon senso e magari anche limite di legalità. E se può parere eccessivo che i rappresentanti della gerontocrazia imperante vengano scelti fra Paperon de’ Paperoni e la regina Elisabetta (pannelli presto abbattuti dalle palline scagliate dal pubblico), sarà forse utile fermarsi un attimo a riflettere che si tratta di un potere che domina in concreto, ma anche e soprattutto nell’immaginario (da Sophia Loren a Babbo Natale).
Ad ogni replica, lo spettacolo coinvolge un artista come “ospite speciale”. Gli vengono poste alcune domande-chiave: che lavoro fai? quanto guadagni? riesci a mantenerti col teatro? È un’indagine sociologica di un certo interesse. Ma, dopo, la situazione si ribalta: siamo in troppi – constata Sara Bonaventura – possiamo risolvere il problema facendo qualcosa insieme; ma non nel senso comune del termine: l’ospite di turno deve sfidare uno degli attori alla roulette russa, ne rimarrà uno soltanto e forse così, nel piccolo e incrinato mondo dell’arte e del teatro, ci sarà più spazio per gli altri.
E sembrerà atroce il passaggio in cui una giovane figlia stressata ingozza di fretta la povera madre, ormai scheletro in carrozzina, o troppo caricata la storia dello stuntman licenziato che sfascia una sedia; ma a pensarci bene non sono situazioni poi così distanti dalla realtà, e nemmeno troppo “deformate” o rimesse in forma ai fini del teatro.
BE NORMAL! intreccia immagini e azioni surreali, così spietatamente eccessive fino a sfumare amaramente nel grottesco (e dunque nel reale, più che nella finzione), sorta di ready-made atroci che si rivoltano contro la realtà che li ha creati; riflessioni di un certo respiro socio-culturale, frammenti di indagini statistiche con tanto di grafici e proiezioni e anche qualche momento di rara poeticità. C’è altrettanta disarmante potenza nella mappa che descrive con un’animazione video l’invecchiamento della popolazione mondiale, prima del corso che istruisce su come affrontarla, quanto nel dialogo fra due casse che si chiedono come sarebbe lavorare al concerto dei Rolling Stones invece che al Teatro TaTà, e si preoccupano del futuro, del rischio perenne di non essere all’altezza e di venire sostituite (ma “non servono pezzi di ultima generazione – constata una delle due – perché siamo noi l’ultima generazione”).
BE NORMAL! è soltanto una giornata come le altre, con un orologio che ogni tanto ricorda il passare del tempo, il sunto di un’Apocalisse quotidiana che bene o male ci si trova ad affrontare tutti i giorni per davvero. Comincia con un messaggio in segreteria lasciato da Shakespeare, che con forte accento inglese consiglia ai Sotterraneo di smettere di fare teatro; finisce con una coppia che sclera (apparentemente) perché non ha i soldi per ordinare la pizza a casa e con Perfect day di Lou Reed.
Quello di Teatro Sotterraneo sembra quasi prendere le forme di un teatro-inchiesta costruito per e con il pubblico. Però è un teatro che non rinuncia allo spettacolo, ma che piuttosto ne usa gli strumenti per indagare la realtà e allo stesso tempo usa la realtà per fare spettacolo. Insieme alla scelta di un tema caldo a livello politico e socio-culturale, è presente con evidenza una ricerca linguistica di tutto rilievo, visibile ad esempio al livello drammaturgico.
Il testo esplode in ogni direzione oltre quelle consuete e si appropria di qualsiasi supporto espressivo. Non ci sono solo le parole da dire, espresse dagli attori; ci sono quelle delle canzoni, cantate o meno; i sopratitoli e le didascalie, quindi su un piano visivo; ci sono le voci registrate, computerizzate, automatizzate; e poi, quella potente del pubblico, su cui ultimamente sembra concentrarsi molto il lavoro Sotterraneo (non tanto nella direzione ormai trita e vana della libertà co-autoriale, ma ragionandoci proprio – sembrerebbe – come elemento drammaturgico in senso stretto). È una parola totale quella con cui sono scritti e rappresentati i testi di questo gruppo, che invade ogni livello della scena, attinge stimoli dal mezzo con cui viene veicolata e assume nuova forza dalla sua declinazione in luoghi e supporti altri rispetto alla parola detta (su cui comunque viene fatto un lavoro di spessore).
E se pure – per la scelta di un tema così caldo, così noto, oppure per i linguaggi di un certo disincanto post-pop con cui lo si affronta – qua e là si possa cogliere qualche rischio, c’è da rilevare il coraggio con cui questi artisti scelgono di parlare apertamente di questioni del genere, in maniera profondamente irriducibile, senza scampo e senza scrupoli (anche per se stessi). Alcuni diranno che è un discorso triste e amaro, magari già sentito; oppure, al contrario, si può pensare che è uno sguardo cinico e spietato; forse la ricchezza di questo approccio al teatro sta nel mezzo, fra l’irriducibilità con cui si guarda al mondo in cui si vive (quindi anche a se stessi, a noi stessi) e la necessità di raccontarla in scena (anche correndo il rischio di toccare nervi scoperti, temi caldi, questioni all’ordine del giorno su cui tanto è stato detto). In ogni caso, quello di Teatro Sotterraneo è un teatro che si assume la responsabilità di affrontare il proprio tempo, dentro e fuori dal teatro e dai suoi linguaggi. E di parlarne in pubblico senza mezze misure, in tutta la sua complessità. Il che, in questi anni, è già qualcosa di importante, che fa di molto la differenza».
Roberta Ferraresi, www.iltamburodikattrin.com
«Sara Bonaventura e Claudio Cirri danno vita ad uno spasmodico e frenetico rincorrere ideali di realizzazione sociale destinati a fallire. Impotenti di fronte alla frustrazione nel dover vivere in quella che viene chiamata “triste realtà”, la sfiducia di chi tenta ostinatamente nel cercare di alimentare i propri desideri, che altro non sono che sogni e tali resteranno. Il meccanismo drammaturgico si fonda sulla rappresentazione paradossale di come la vita quotidiana possa sembrare assurda nella sua banalità. Un riconoscimento sociale che tarda a venire, obbligati a sacrificarsi per ottenere ciò che più si ama. O si desidera. […] Lo spettacolo diventa così un tentativo riuscito di analizzare il comportamento sociologico che sta alla base del vivere di tutti i giorni. Un uomo e una donna come possono essere chiunque, presi dalla strada, mostrano l’alienazione nel ripetere all’infinito (ogni giorno) gesti e abitudini come regolare la sveglia per alzarsi molto presto la mattina, correre per andare al lavoro, salire sui mezzi pubblici, immersi in una nevrosi collettiva dove può accadere di tutto e quel tutto sembra ahimè far parte della normalità. Perfino una rapina a mano armata o essere licenziati da un momento all’altro. Un annullamento della propria coscienza che annaspa per cercare di restare a galla in un mondo che non le appartiene più. Un frenetico e compulsivo agire che fa fare ai due interpreti azioni come fossero automi. […] L’impotenza come condizione esistenziale fine a se stessa. La potenza visiva si associa al messaggio che arriva al pubblico con una forza emotiva incredibile. E veritiero! BE NORMAL! sembra dirci che non c’è futuro e il non sense delle loro azioni è la chiave di lettura per desistere a cercare un finale consolatorio. Non è una storia che inizia e ha un fine. Senza alcuna retorica da parte loro, i due bravi interpreti cercano il contatto con il pubblico, lo coinvolgono in gag esilaranti, tipiche della loro sprezzante ironia e comicità surreale che non va distinta dall’impegno di cercare di sondare i tanti malesseri della nostra condizione umana. Il reale si mescola con la finzione ma non è quello che accade al giorno d’oggi quando ci vengono propinati falsi modelli dove le istruzioni per l’uso le detta la televisione. La vita tutto sommato non è altro che un format propinatoci senza possibilità di scelta. […] Un giovane che non ha un futuro è il fallimento per tutti. Il mestiere che fai? “L’attore”. Ma è sufficiente per chiamarlo un lavoro? La domanda resta inevasa e il riso che ci hanno regalato gli attori e il loro regista ci lasciano ancora una volta increduli nel disincanto generale che ci accompagnerà uscendo da teatro. Non c’è finale che ci possa far credere di essere stati semplici spettatori per quanto sia finzione e il cinismo non è altro che la crudele verità a cui noi ci siamo assuefatti».
Roberto Rinaldi, www.rumorscena.com
«Si trattava di BE LEGEND!, una serie di brevi appuntamenti attorno alla figura del personaggio leggendario (che fosse Amleto o Giovanna d’Arco) incarnato in scena da un bambino, diverso in ogni episodio, come a voler indicare che la leggenda non fosse altro dall’estremizzazione di quel “daimon” primario, quell’inclinazione istintiva appartenente all’uomo come un’orma nell’anima.
Successivo – ma di parallela elaborazione – è invece BE NORMAL!, che sta al primo come naturale contraltare, reindirizzamento verso la condizione dell’umano e attualizzazione del mito nel mondo contemporaneo che ne disfa la virtù esplorativa, la linfa vitale, che riduce la vocazione in forma di passatempo, quando va bene, o sempre più spesso a orpello di origini fanciullesche da ingoiare nel banchetto famelico della vita adulta. “Cosa fai per vivere?”, esordisce il foglio di sala. Per vivere, cerco di vivere. Si dovrebbe rispondere per stare al gioco, che gioco non è.
Sul palco del Teatro Sotterraneo […] c’è un’intera geografia che prende corpo per estensione percettiva: là dove c’è solo un fondale nero e due colonne non previste nel mezzo, quel loro gioco rivela una metropolitana in attesa di passeggeri, strade, semafori, supermercati, ma invece di geo-soffocare il mondo-palcoscenico lo intreccia a quelle ipotesi figurali in un continuo straniamento che è un po’ una misura stilistica di riconoscibilità e connota la loro ricerca di arguzia e affilata ironia. Non ne manca, anche quando si mette in scena un colloquio di lavoro per entrare nella Mafia, quando una figlia isterica accudisce una madre ridotta a scheletro, quando si illustra una guida pratica per l’eliminazione degli anziani, distribuendo palline da lanciare alle sagome di vecchi simbolici: da un lato la regina Elisabetta, il creatore di Playboy Hugh Hefner, Paperon de’ Paperoni, dall’altro il più temuto, il vero nemico giurato del giovane che non può crescere, il “vecchio generico Mario Rossi”. L’unico – caso o necessità – a rimanere in piedi.
Amaro decorso dell’evoluzione – in linea con il sorprendente Dittico sulla specie – questo spettacolo si segnala per una doppia linea espressiva cui ricondurre una visione totale. Se dietro lo spazio scenico un display silenzioso decorre freddamente l’intera agonizzante giornata tutta da sopra-vivere, è possibile che ci si riscaldi paradossalmente quando i corpi sono usciti di scena per diventare voci, è possibile scoprire l’amore seguendo la storia di due casse della Pelanda, le nostre emozioni dalla loro muta, scomoda vicinanza; è possibile farsi battere qualcosa nel petto quando una piccola bara bianca arriva in scena, accompagnata dalle note di The sound of silence in una incantevole versione a cappella. È possibile. «Nella società in cui c’è posto solo per uno dei due io: voi o il vostro demone», è possibile che la vera leggenda, il vero mito da conservare, non sia altro da quello nato con noi, da noi stessi annientato».
Simone Nebbia, www.teatroecritica.net
«Di alta fattura e senso […] è BE NORMAL!, ironica e dissacrante ricostruzione del rapporto dell’artista con l’arte […]. Interpretazioni consistenti nella loro leggerezza, un sapiente coinvolgimento del pubblico, la capacità di materializzare e ridicolizzare gli stereotipi di chi considera quello dell’artista un vacuo divertissement («Certo, teatro – ma di lavoro?»), una pervasiva e surreale ironia (dal colloquio di lavoro con la Mafia all’amorevole figlia dei tempi moderni che non si accorge di accudire una madre ormai scheletrica, passando per il tentativo di eliminazione fisica del competitor Gianni Farina di Menoventi) sono infatti figli di una grande padronanza e presenza scenica, ma, soprattutto, di profonda consapevolezza drammaturgica. Cui, giustamente, il pubblico non ha potuto non tributare un lungo e meritato applauso».
Daniele Rizzo e Simona Ventura, www.persinsala.it
«Dallo spazio al gesto, alle azioni, all’opera, al senso dell’essere autore dell’opera. Disperatamente scende alla pratica “Be Normal!” di Teatro Sotterraneo, proponendo l’invito a trovarsi un lavoro vero, a schiacciare i vecchi che non ci lasciano il loro posto e i loro soldi, e far fuori questo tumore dell’essere artisti, che ci porta al fallimento. Inattuabile ma golosa la “modest proposal” che suggerisce una eliminazione fisica su basi statistiche degli artisti di troppo, che intasano il mercato».
Carlo Lei, www.klpteatro.it
«BE NORMAL! di Teatro Sotterraneo ci mostra per schegge minime, senza ornamento, la fenomenologia del quotidiano. Un uomo e una donna colti nei loro gesti abitudinari: mettere la sveglia all’alba, alzarsi, prendere la metro, fare un certo cammino calcolabile in misure di palcoscenico/strada: sul cui selciato si alza una specie di onda criminale, come se d’improvviso accadesse qualcosa di insolito e di violento, un omicidio, un annuncio d’apocalisse nel tessuto opaco dei giorni e delle notti. I gesti si insabbiano e il respiro muore dentro, mentre da qualche parte il mondo va in fiamme».
Katia Ippaso, www.glialtrionline.it
«Daimon, vocazione, ricerca di identità e catastrofe. Questi i temi affrontati da Teatro Sotterraneo in BE LEGEND! e in BE NORMAL!, due nuove differenti produzioni, autonome e allo stesso tempo legate da una scrittura drammaturgica (e scenica) in fieri, che non solo si modellizza sul dispositivo televisivo (nello specifico il format del serial) ma che assume valore nella continuità e nel riflettersi dei due differenti progetti. Da un lato l’infanzia, il lottare per l’essere al mondo, o, più semplicemente per dare una risposta alle motivazioni di quello stesso essere. […] Dall’altro una coppia di adulti sorpresa in una quotidianità standardizzata, unico appiglio di una vita consumata e senza prospettive. Come informazioni lanciate su internet, nutrendosi del videoclip, della performance, del telefilm e del cinema, la scena di Teatro Sotterraneo è il luogo in cui si esplica una raccolta di frammenti di immaginario. L’apocalisse, la fine del mondo, sta nel frantumarsi dell’immaginazione, dell’accavallarsi di immagini prive di memoria. Da un lato il ricordare perpetuo, la tensione verso un’aspettativa di vita, la fragilità del mondo infantile, dall’altro le macerie di un universo che supera la postmodernità e che si proietta verso un “the end” brandizzato come fotografie postprodotte in cui trovare rifugio. Un mondo che nella scansione temporale di una giornata, votato al fallimento, perde lo stesso senso del tempo».
dreamcatcher2013.iltamburodikattrin.com
«Come sopravvivere in un mondo dove tutti camminano in cerchio? L’unica soluzione sembra uccidere il proprio Daimon, il “demone” che risiede dentro di noi, quello che alimenta i nostri sogni, le nostre aspettative verso quello che vogliamo fare nella vita, quello che vogliamo realizzare, quello che vogliamo essere. […] Sara Bonaventura e Claudio Cirri per la scrittura di Daniele Villa, portano in scena una generazione che tenta disperatamente di stare a galla, che si alza presto alla mattina, che fa colloqui per i lavori più disparati (interessante il fatto che i colloqui sono sempre per ottenere il posto di “eliminatore”, vuoi che si tratti di gente comune o di “morti viventi”) che tenta di sopravvivere in un mondo dove non c’è più spazio per i giovani, dove si sono rovesciati i ruoli […]. Sembra non esserci soluzione o un lieto fine, Teatro Sotterraneo mette in scena la “triste” realtà, le difficoltà di chi si ostina e persevera nella lotta quotidiana di mantenere vivo il proprio sogno, lo fa senza aloni di vittimismo o banalità, ma lo affronta nella maniera che contraddistingue i lavori di questa giovane compagnia, con ironia, cinismo e cruda realtà. Il Sotterraneo non fa teatro rappresentativo, ma sviluppa il discorso del non io. Non ci troviamo quindi davanti ad una rappresentazione, ne di fronte ad una storia lineare, gli attori tentano sempre un confronto col pubblico, lo invitano ad agire […]. Nonostante la “disperazione” dei fatti, non si può non ridere, si ride per quanto assurda può apparirci la realtà, nonostante l’evidenza, si ride per non piangere. Lo spettacolo assume in alcuni momenti le sembianze di un corso di sopravvivenza, con statistiche alla mano, tecniche di difesa, consigli di salvezza…salvezza per lo spirito e la mente in un periodo difficile per chi come tanti giovani, soprattutto coloro che vogliono vivere facendo ciò che più amano e son costretti a fare sacrifici enormi per essere quel minimo riconosciuti dalla società, quel tanto che basta che possa permetterti di rispondere con tranquillità alla domanda: Ma tu, che fai per vivere?».
Cristina Zanotto, scatolaemozionale.blogspot.it
«BE NORMAL! presenta due personaggi trentenni in scena che ci raccontano una storia, una giornata come un insieme denso, inizia alle otto di mattina e per ora – lo spettacolo che abbiamo visto è uno studio – si interrompe all’ora di pranzo. Durante la giornata i due personaggi, mentre vengono licenziati, mentre tornano da lavoro, si imbattono in un rapina, azione simbolica del limite di sopportazione raggiunto dalla società della crisi economica, quella contemporanea. I rapinatori hanno la maschera di Berlusconi ed è naturale vederli così, sembra materializzarsi quella teoria della mercificazione dell’età giovanile che Stefano Laffi teorizzava ne Il furto. Tutto scontato, in teoria, ma la rappresentazione ha il compito di mettere in crisi i meccanismi autoconsolatori, e proprio su questo punto BE NORMAL! apre con cattiveria un discorso sulle colpe. […] Le fotografie brucianti e sovraesposte che Teatro Sotterraneo ci ha consegnato negli spettacoli precedenti alludevano a un contesto letto con cattiveria e restituito come uno sfondo con cui fare i conti. Adesso in quel contesto si presenta un personaggio, un giovane uomo, che disadattato dalle regole d’ingaggio della società vacilla ed esplode per sussulti intermittenti, nella coazione a ripetere di un licenziamento, del tai chi, di un lavoro fatto indossando un costume da hot dog oppure uno sfogo con la maschera da wrestler. Possiamo parlare di colpe? Sembrerebbero egualmente ripartite tra quelle maschere e una giornata “archetipica”, così come le possibilità per uscirne imboccando la strada con intenzioni politiche e intime speranze. A forza di essere ossessionati dall’immaginario che ci ha scazzottato per vent’anni, Teatro Sotterraneo ci getta in faccia la storia di una giornata (a oggi, mezza) in cui l’abbraccio postatomico davanti all’eclisse non è da reduci, ma è anzi il simbolo di un teatro di crudele sopravvivenza».
Nicola Ruganti, www.minimaetmoralia.it
«Ci sono momenti in cui coloro che stanno in scena e coloro che stanno in platea sentono istintivamente di condividere qualcosa. Come se si aprisse un secondo canale di comunicazione, una strisciante e silente empatia, un tacito accordo tra pari. Si può definire contesto, mondo morale, comune consapevolezza di trovarsi sulla stessa barca. È come se con un gioco di sguardi finalmente ci si accorga del proverbiale elefante nella stanza. Spesso è una zona che si cerca di raggiungere a forza, si tende e scolpisce la propria arte per farla entrare nello stretto canale che va a toccare le corde più sensibili del pubblico. Tanti giocano carte truccate per arrivarci. A volte invece tutto questo si crea naturalmente, tutto sommato semplicemente. Vuoi perché il consesso è ristretto e fortemente caratterizzato, vuoi perché il contesto non permette vie di fuga tanto è stringente e ingombrante, vuoi perché chi sta in scena è semplicemente molto bravo a crearlo. Sul palco di Short Theatre, Sara Bonaventura e Claudio Cirri di Teatro Sotterraneo hanno saputo sfruttare un po’ di tutte queste cose insieme. BE NORMAL!_ Daimon Project è un orologio che scandisce una giornata di ordinaria vita difficile di una giovane coppia. Una serie di quadri, situazioni, venate di surreale ironia e continua ricerca della comprensione e della collaborazione del pubblico. Un po’ messa in scena distorta della lotta quotidiana per un salario, un po’ istruzioni per il soffocamento di quel daimon che ti suggerisce la distanza tra il reale e l’immaginario, tra la volontà di distinzione e promozione che ognuno coltiva e la necessità quotidiana di scender a patti con l’attualità e la desolante realtà delle cose. Lo spettacolo va avanti per episodi, costruito con la collaborazione di proiettore e microfoni, uscite di scena che raramente sono tali, essendo sempre presente, almeno con la voce, l’attore. Si entra e si esce dai personaggi, si entra e si esce dalla storia, creando così una composizione giustapposta i cui legami a volte appaiono leggermente sfilacciati ma senza che questo pregiudichi il senso o la godibilità dello spettacolo. Lo spettacolo di Teatro Sotterraneo entra così in quella zona di confine e di empatia con lo spettatore naturalmente, senza ricercarne furbescamente l’apprezzamento. Lo fa grazie alla sua sensibilità pop, alla sua consapevolezza che se, come ammoniva Flaiano, «la situazione è tragica ma non è seria» non si può raccontarla rinunciando a un sorriso ironico».
Giacomo Lambrozio, www.paperstreet.it
«Teatro Sotterraneo torna a Short Theatre con una produzione dello scorso anno, BE NORMAL!, nella quale analizzano una giornata tipo di due giovani trentenni scandita dalle ore che passano, alle prese con la ricerca del lavoro, gli espedienti per trovarlo, i colloqui nei quali viene chiesto loro di uccidere esseri umani (per una cosca mafiosa) o degli Zombie, […] le vicissitudini di chi il lavoro lo perde e di chi non lo trova. Lo fanno con un organico ridotto – in scena solo Sara Bonaventura e Claudio Cirri – e una inesauribile verve inventiva: l’eliminazione a colpi di roulette russa di Sara o del componente ospite di un’altra compagnia (a Short Theatre era Enrico Castellani di Babilonia Teatri); la scena in cui una ragazza va a trovare la madre su una sedia a rotelle per farle compagnia, imboccandola velocemente perché va di fretta, e la madre è interpretata dal manichino di uno scheletro (e vedere il cibo che dalla mandibola scende sullo sterno e poi sul bacino mentre lei chiama lo scheletro mamma è uno di quei momenti di teatro che non se ne vanno più dalla testa). Con uno stile ormai inconfondibile Teatro Sotterraneo mette dinanzi il suo pubblico, le idiosincrasie e le contraddizioni delle nostre vite quotidiane con un gusto pop e una buona dose di cinismo che non è mai fine a stesso ma rimanda sempre a un portato etico e politico che va affrontato concretamente nella vita reale. Più abbozzato e meno definitivo dei lavori precedenti – ma si tratta sicuramente di una scelta stilistica – lo spettacolo sottolinea le precarietà, anche quella degli attori e delle attrici e di autori e autrici di un teatro sempre più incerto, incapace di garantire una sopravvivenza dignitosa a chi lo fa […] ma, ciononostante, ancora ben capace di ragionare e far ragionare il pubblico».
Alessandro Paesano, www.cultura.gaiaitalia.com
«In BE NORMAL! il gruppo porta una finestra sulla vita normale di due attori trentenni; trasformano, attraverso i loro occhi sensibili di artisti convincenti, quello che vedono, in satira dissacrante. ‘Cosa fai per vivere? Teatro. Certo ma di lavoro?’. E, c’era una volta, l’intera generazione di lavoratori del settore, che si rispecchiò, con tenerezza».
Antonella Vercesi, www.niuodeon.com
«Scadente e ahinoi scaduto è ormai il fattore umano e i due giovani attori […] è attorno al totale svilimento umano che lavorano con abnegazione, professionalità e sacrificio. Requisiti che Teatro Sotterraneo evidenzia sistematicamente: la scelta rigorosa e particolarmente ricercata delle scenografie semoventi e trasportabili; la sincronia scenica, emotiva, fisica con i supporti elettronici; la velocità con la quale si immergono in personaggi epocali e generazionali e quella con la quale riemergono per tuffarsi nuovamente in un’altra sit; la velocità radiofonica con cui ridono di atrocità e fingono di temere vendette, l’intonazione timbrica con la quale affrontano, a cappella, Mad world, di Gary Jules e Perfect day, omaggio allo scomparso Lou Reed, motivo con il quale, in un’eclissi solare, generano il buio e chiudono la rappresentazione. Avevano ancora il fiatone, entrambi, dopo essere rientrati dietro le quinte per la sesta volta, al termine dello spettacolo […]: erano sfiniti da i continui andirivieni, ludici, ma professionali escamotages con i quali hanno tenuto in tiro l’arco della scena […]. Senza omettere di sottolineare la genialità delle loro intuizioni: sadiche e sarcastiche gag che si muovono con divertente velocità, con una virtuale incombenza da spot che sembra ricordar loro che dopo pochi minuti la parola passerà alla regìa, per qualche consiglio pubblicitario».
Luigi Scardigli, www.quarratanews.it
«BE NORMAL!, un tentativo disperato di provare a spiegare come può un giovane sopravvivere in questo Paese senza dover essere precario a vita. Sara Bonaventura e Claudio Cirri tentano, in scena, di cercare una soluzione per superare questa condizione eternamente instabile in cui sono immersi i trentenni di oggi. E lo fanno, come sempre, araverso l’arma dell’ironia e un continuo coinvolgimento del pubblico. Il suggerimento sembra essere uno solo: rinunciare ai propri sogni, fino all’atto estremo di Sara che ogni sera chiama un artista ad affiancarla in scena. In due sono troppi, dunque uno deve essere eliminato. […] Chi sopravviverà? Questa è la vera domanda a cui siamo tutti chiamati a rispondere. E forse, la soluzione, sta proprio nel titolo: “be normal”, ovvero siate normali e rinunciate alle vostre ambizioni. Sarà vero?».
Francesca De Sanctis, francescadesanctis.wordpress.com
«Di alta fattura e senso, nella sua apparente minore pretesa drammaturgica, l’ultimo spettacolo cui assistiamo in questa decima edizione del Festival internazionale della creazione contemporanea è Be normal – Daimon Project, ironica e dissacrante ricostruzione del rapporto dell’artista con l’arte di Teatro Sotterraneo, giovane compagnia che, come scriveva la nostra Simona Frigerio, «sperimenta nuove strade e ridà linfa a un teatro troppo spesso da gerontocomio» (dalla recensione di War Now). Un riferimento che Sara Bonaventura e Claudio Cirri, non a caso, giungono a rappresentare attraverso le sagome della regina Elisabetta, di Hugh Hefner (Playboy), Paperon de’ Paperoni e l’anziano medio Mario Rossi esposte al lancio delle palline del pubblico.
Interpretazioni consistenti nella loro leggerezza, un sapiente coinvolgimento del pubblico, la capacità di materializzare e ridicolizzare gli stereotipi di chi considera quello dell’artista un vacuo divertissement («Certo, teatro – ma di lavoro?»), una pervasiva e surreale ironia (dal colloquio di lavoro con la Mafia all’amorevole figlia dei tempi moderni che non si accorge di accudire una madre ormai scheletrica, passando per il tentativo di eliminazione fisica del competitor Gianni Farina di Menoventi) sono infatti figli di una grande padronanza e presenza scenica, ma, soprattutto, di profonda consapevolezza drammaturgica.
Cui, giustamente, il pubblico non ha potuto non tributare un lungo e meritato applauso».
Daniele Rizzo e Simona Ventura, www.persinsala.it
«Be Normal! dei Sotterraneo non è uno spettacolo che si possa “raccontare”; o meglio, potremmo anche provare a fare una sintesi di quanto accade in scena, ma così facendo, con tutta probabilità, compiremmo un’opera di vivisezione inutile, che non restituirebbe il senso intrinseco di questo spettacolo, senso che sta precipuamente nella sua frammentazione, nell’idea di discontinuità che percorre e trasmette, nella forza evocativa di una pratica di scena che parcellizza, tritura, rimastica e sputa, con un’ironia graffiante, un discorso sulla società del nostro tempo che, partendo col mettere al centro il rapporto vecchi/giovani (e poi non solo quello), affronta alcuni dei nodi cruciali attorno a cui s’attorcigliano i rovelli di un consorzio sociale la cui crisi strutturale si riverbera nelle dinamiche lavorative, nei rapporti umani e persino nel mondo dell’arte (e del teatro, come precisi passaggi di Be Normal! rimarcano).
Michele Di Donato, www.ilpickwick.it
HOMO RIDENS
«Non era facile, per Teatro Sotterraneo, compiere un passo successivo – dopo l’impegnativo “dittico” sull’origine e la fine della specie – senza ripetersi, e senza cali di tensione. Bisogna dire che con Homo ridens, il provocatorio spettacolo che ha debuttato nel vivacissimo programma del festival Inequilibrio di Castiglioncello, il gruppo fiorentino è riuscito alla grande nell’impresa, confermando di essere non a caso una delle espressioni di punta del nuovo teatro italiano. Che cos’è Homo ridens? È una sorta di ingegnoso esercizio post-teatrale – destrutturato, apparentemente del tutto informale – sui feroci meccanismi della risata, sulla fisiologia della risata come risposta agli aspetti più crudeli della realtà. Secondo consuetudine, i 4 bravissimi attori non indossano dei costumi, non interpretano dei personaggi: si presentano faccia a faccia davanti al pubblico, proponendogli dei buffi esperimenti sulle sue reazioni di fronte a situazioni che, in se stesse, non dovrebbero risultare affatto divertenti. Gli esperimenti riguardano gli effetti più o meno esilaranti – provocati ad arte, attraverso surreali “tormentoni” e imprevedibili spiazzamenti emotivi – di fronte a immagini atroci dei lager o dei bambini africani affamati. Quanto può essere comica la ricerca di vari metodi per suicidarsi? Chi sghignazza assistendo a un violento pestaggio? Ma c’è anche la truce barzelletta del bunga-bunga, e il mistero di un Cristo mai ritratto sorridente. Al di là dell’ostentata leggerezza, in tutto questo, sia chiaro, non c’è nulla di cabarettistico: quella praticata da Daniele Villa è una neo-drammaturgia spigliata ma chirurgica, che picchia duro denunciando gli abusi di risata da parte del potere, e le nefaste conseguenze della nostra assuefazione alle tragedie quotidiane. I finti test pseudo-scientifici si traducono in uno scomodo percorso introspettivo: ci costringono a guardarci dentro per ciò che siamo, a scrutare in certe nostre ambiguità interiori».
Renato Palazzi, Il Sole 24 ore
«Il gruppo toscano conferma il suo stato di grazia anche in Homo ridens, che prosegue la chirurgica ricerca nello sfascio quotidiano, analizzando stavolta il ridere e i suoi comportamenti. Si cita Bergson, si fanno test sul pubblico ma i momenti più intensi sono quelli in cui la riduzione a risata di tutto quello che vediamo è la vera tragedia».
Anna Bandettini, La Repubblica
«Altra densità ha la breve performance di Teatro Sotterraneo, […] che conferma i toscani fra le realtà più solide di questa generazione. Difficile pronosticare se sarà l’inizio di una nuova avventura, quale è stato il loro “dittico” su origine e fine della specie. Per ora è una sorta di gioco o di esperimento (anche teatrale) che coinvolge il pubblico in un esercizio sui meccanismi della risata, con una apparenza di scientificità sottilmente derisa. I mezzi sono quelli che gli conosciamo, le magliette informali con cui si presentano in scena i quattro interpreti, i dialoghi e le azioni veloci, la drammaturgia povera ma insinuante. Una ricetta semplice ma niente affatto accondiscendente. L’esito è sempre un po’ destabilizzante».
Gianni Manzella, Il Manifesto
Ridere, morire, offrirsi, lottare
«Teatro Sotterraneo conferma la sua intelligenza capace di mettere in imbarazzo, smontando con sorridente ferocia, apparentemente sui confini dello scherzo, la nostra società della rappresentazione. Homo ridens si presenta come una (cinica) indagine sui meccanismi della risata: quelli più crudeli, che con opportuno dislocamento ci fanno ridere di una distesa di cadaveri o di un bambino nero gonfio per la fame. Ridiamo dei colpi sparati a ripetizione a uno che tenta di fuggire e cade, si insanguina da pagliaccio, si rialza, viene colpito ancora, fino a che la pistola non fa cilecca, e poi ancora, di nuovo, annullando quasi la coscienza della finzione con la teatralità della ripetizione. Siamo dalle parti di un’apocalisse con risata finale, in una festa dei folli che somiglia alla nostra società e al nostro vivere, con un linguaggio che si presenta scientifico, statistico, asettico, e che nasconde in sé ogni ambiguità e falsificazione. E appare perfino la barzelletta del “bunga bunga”, interrotta, dagli applausi compiacenti dei cortigiani, prima del finale, da risate prima del momento di ridere, prima della battuta risolutiva. In bilico come noi gli attori-scienziati-clown, in un inesausto stare nel varco tra due mondi, senza sapere da dove si venga, dove si vada, come la preghiera di una (troppo facile e inoffensiva) risata».
Massimo Marino, www.corrieredibologna.it
«Teatro Sotterraneo possiede la disinvolta arguzia scenica e la matura intelligenza critica per trasformare la spensieratezza che accompagna la risata in inquietante amarezza: così, al termine dello spettacolo, i quattro performer fiorentini, gentili e amichevoli, ci inchiodano al muro, chiedendoci perentoriamente conto della nostra colpevole leggerezza».
Laura Bevione, Hystrio
L’intelligenza sulfurea di Teatro Sotterraneo
«Questa volta facciamo un gioco. Se io dico “teatro civile”, voi cosa pensate? Senza possibilità di sbagliare troppo, azzarderei il Vajont di Paolini e Radio clandestina di Celestini. Risposta esatta. O quasi. […] Con le risposte che si infilano nelle asole come acqua, ce ne andremmo volentieri a dormire. Ma poi accade un fatto strano: con due veloci, fulminanti colpi d’ali, la compagnia toscana Teatro Sotterraneo passa prima al festival “Inequilibrio” di Castiglioncello e poi a Santarcangelo con un manualetto di antropologia ludica (Homo ridens), e allora le cose non vanno più al posto assegnato e bisogna re-imparare tutto. Re-imparare, per esempio, che “teatro civile” non equivale a “teatro di narrazione”, (anche perché dovremmo convincerci che il resto della scena italiana sia “incivile”, e noi non lo vogliamo credere, vero?). Per quanto ci riguarda, l’esperimento condotto con gli spettatori sulle varie forme di riso, è uno dei più alti esempi di teatro “civile” a cui ci sia capitato di assistere negli ultimi anni. Provate anche voi. Seguite le tracce “sotterranee” in giro per l’Italia e vedremo se sarà ancora più possibile ridere delle tragedie così come facciamo noi impunemente. Fatevi puntare addosso la pistola che i ragazzi smanettano sulla scena e ci accorgeremo che odore ha la paura. Ascoltate il racconto terrorizzante del serial killer e vi accorgerete che da questo momento in poi il monologo di Spike Lee ne La 25a ora è roba da bambini (o quasi). […] Con divertimento. Ma c’è modo e modo di ridere. Come c’è modo e modo di educare e di allenare ad un pensiero “civile” che non può che partire da un “accuso me stesso” (e non sempre e solo gli altri), da uno sguardo feroce sui propri stessi automatismi. In questo tipo di lavoro, gli attori di Teatro Sotterraneo sono diventati sempre più sottili, raffinati. Provocando in chi guarda un piacere particolare, che è quello che nasce tutte le volte che l’intelligenza umoristica (ragione e sentimento) trova il suo punto di fusione e di incontro».
Katia Ippaso, Gli altri
«Teatro Sotterraneo prosegue con Homo Ridens il suo teatro delle domande, che lascia al pubblico le risposte, e si pone come feroce soggetto di stimolo al pensiero. Feroce, perché ci fa male. Perché se l’imperativo morale è sempre dichiaratamente assente nei suoi lavori, Teatro Sotterraneo sottende a una logica costante che è essa stessa emergenza morale e culturale del gruppo: risvegliare la contraddizione, far leva sul senso di straniamento non per spersonalizzare, ma per ri-umanizzare il pensiero, puntare gli occhi sull’assurdo che governa indisturbato. Emergenza che si ritrova nelle tematiche, ma soprattutto nel rigore del loro linguaggio espressivo, perla preziosa del gruppo […]. Freddi, asettici, distanti: sempre. Non ti chiamano a sé neanche quando si rivolgono (e lo fanno spesso) al pubblico, non offrono nulla (o quasi) con cui entrare in empatia: sei tu che devi aderire a loro. E in mezzo non c’è alcuna storiella consolatoria. È una sfida coraggiosissima e contemporaneamente è la vera forza di Teatro Sotterraneo. Si va a vedere Homo Ridenspensando di ridere; si esce da Homo Ridensdomandandosi con che coraggio si è potuto ridere, oppure certi di sapere perché non si è riusciti a ridere. La grandezza di questo lavoro è tutta qui: lavora sui fianchi; sceglie punti di vista laterali; affronta il tema con argomenti imprevisti, talvolta scioccanti e perciò rifiutabili; ribalta persino il significato stesso del concetto di risata, legando ad esso montagne di dolore. Per insinuare tunnel, autostrade, tutte sotterranee, di benefico malessere».
Marianna Sassano, www.nonsolocinema.com
«Colti e indocili, gli artisti di Teatro Sotterraneo mettono a punto un dispositivo scenico di sconcertante precisione intellettuale dove la risata si trasforma in un test che obbliga lo spettatorea ragionare sugli strumenti del potere. Alla fine, difficile non sentirsi a disagio. Obiettivo centrato».
Sara Chiappori, La Repubblica Milano
«Ecco uno spettacolo didattico che diverte, come voleva Brecht. Homo ridens […] è un gioiellino. […] Si ride di gusto, il pudore muore subito. Calibrato sul “pubblico dell’era scientifica”, lo spettacolo non sfrutta l’empatia o l’immedesimazione, ma gioca con la razionalità, servendosi delle matematiche regole del comico, senza peraltro nasconderle: si continua a ridere. […] “Non c’è niente di più comico delle disgrazie”, voleva Beckett: Teatro Sotterraneo dà prova di crudele, spietata intelligenza. Lo conferma anche il neologismo creato ad arte per testare la “capacità risoria”. “Risorio” non esiste sul dizionario; potrebbe essere il contrario di “irrisorio”, e significare qualcosa di “rilevante, importante”? Basta il dubbio a generare senso.
I giovani artisti si guardano bene dal dare giudizi, preferendo la pensosa leggerezza: dopo 45 minuti di show, traggono una conclusione senza erigere una tesi (o, comunque, ben dissimulandola). E quello che con calcolata umiltà avevano definito “un test”, alla fine si rivela una lezione».
Camilla Tagliabue, Il fatto quotidiano
«Come sempre geniali gli autori/attori di Teatro Sotterraneo, gioiosamente crudeli in Homo ridens, sul riso e la morte, la voglia di finire, gli orrori nel mondo e il naturale bisogno comunque di ridere, contraddizioni e follie della natura umana».
Valeria Ottolenghi, La Gazzetta di Parma
«L’affermazione scientifica, teorizzazione del computo numerico, applicata alle inclinazioni naturali tutte umane, elargisce una qualità incontrovertibile cui nessun dubbio può porre contrasto. Quando tutto ciò finisce in teatro, il gioco di sovrapposizione di vero e falso si articola secondo una costruzione d’artificio che da un lato sconfessa la materia, dall’altro l’approva indiscutibilmente. In questo gioco di malleabilità e concrezione della materia muove la sua creazione il Teatro Sotterraneo e attiva l’indagine testimoniale, misurabile, in un panorama teatrale che annuncia le sue sicurezze su basi tutt’altro che solide, ai fine di interrogarsi sulle mosse e le pose dell’Homo ridens, versione Castiglioncello.
Il sottotitolo è primo sintomo di questa tensione: la loro indagine ha modalità specifiche in ognuno dei luoghi dove si svolge il test, ravvisandone durante lo spettacolo i risultati e portandone il conto alla fine, come mostra di lavoro svolto. Quindi se ne deduce che la performance acquisti caratteri nuovi al cospetto di pubblici diversi e pertanto la scelta è quella di interrogare chi assiste utilizzando sé stessi come mezzo di valutazione: ne nasce la convinzione che il Sotterraneo stia operando un’analisi di stampo sociologico, andando oltre il teatro ma senza smettere di considerare il teatro come filtro della relazione con la materia d’indagine. Questo fa di loro una compagnia di sicura qualità e attesta una volta di più le lodi unanimi, li promuove di diritto a interpreti coscienti e puntigliosi dell’epoca contemporanea. A questo proposito urge una precisazione: il sistema che vuole la riconoscibilità pari alla ripetitività, non fa che alimentare il divario fra società e teatro, là dove la prima – per difetto di spettacolarizzazione – spinge a non considerare il secondo come una forma d’arte (e dunque lo spinge fuori dai Beni Culturali); la loro ricerca di maturità nello stile, nel linguaggio, di una linea pur riconoscibile, ha il valore di affermare nuovamente che il teatro ha questa dignità che gli viene dalla sua storia anche solo del secolo precedente, storia che s’installa genuinamente nell’evoluzione culturale e dunque umana, che ha però perduto stima di nobiltà e valore dialettico di concretezza nel panorama intellettuale.
La loro indagine è sulla ricettività, sull’ipocrisia delle seconde scelte che si affrettano a diventare prime, per dichiarare a sé stessi la propria correttezza di reazione, sul riso macabro incosciente di sé, inarrestabile impulsività che delle conseguenze non si cura. Per fare questo l’uso della performance è preposto alla spiegazione ed è qui che si fa teatrale lo studio: è prima formale, stilistico, poi si fa notizia e formula. Quindi il percorso è un doppio giro: dalla scienza in teatro e ritorno. Sul filo continuo della credibilità, la dimostrazione dello scollamento fra chi ride e la materia reale che lo genera è lampante nelle otto uccisioni dell’attore, di cui in media si ride quasi sempre, l’irreale dunque resta credibile per il riso, così come ne è chiaro esempio la reazione a catena che ha relazione con il ridente e non con il motivo di irrisione. Dunque si pone il Sotterraneo in un’analisi il cui test siamo noi, le nostre storture di reazione, la nostra fiducia nell’inverosimile. Di qui la percezione postuma della loro fredda doppia dichiarazione violenta: l’assassina dell’attore, che cerca di far fuori la figura cardine dello spazio scenico, poco prima aveva attentato alla vita dello spettacolo stesso, disvelandone l’artificio e quindi ponendo urgente il gioco metateatrale, usando allora il teatro non solo come luogo esplicativo della loro materia di studio, ma come il luogo più opportuno e coerente proprio della stessa analisi. Ma se lo spettacolo è l’analisi, di cosa ridiamo? Proprio di noi stessi, lì dentro riconosciuti, dello specchio ridicolo in cui vediamo deformati i lineamenti del viso, rendendoci ridicoli (ossia ciò che fa ridere) e ridenti della materia ridicolizzata. Ma dunque, nello specchio veri o presunti, ridicoli e ridenti, siamo sempre noi».
Simone Nebbia, www.teatroecritica.net
«Una risata ti cambia la vita, oppure ridi che ti passa, o ancora… meglio ridere che piangere. Si può ridere a crepapelle, ma anche morir dal ridere. Le risate eccessive e prolungate rischiano di farti perdere la vita. Non è uno scherzo. […] Al giorno d’oggi si ride poco e male. Basta guardarsi intorno, la risata, quella vera, sincera, sana, è diventata un bene di consumo a rischio di estinzione. Non è per caso che anche questo rattrista e fa vivere male? Ecco, allora, che arriva Homo ridens, lo studio di Teatro Sotterraneo, pensato come un esperimento a campione sul pubblico-cavia, sottoposto a test di reazione istantanea, dopo averlo sollecitato con tutti i meccanismi della risata, da quelli facilmente suscettibili di divertimento, fino ad arrivare a forme più perverse date da meccanismi dell’inconscio. L’aggressività, l’humour noir, perfino davanti a scene brutali e tragiche. Il riso come istinto di difesa dalla sofferenza, dal dolore, dal disagio. […] L’intento è quello di un lavoro analitico al fine di comprendere i codici che regolano uno dei meccanismi più complessi della natura umana. Ma le risate ascoltate durante la performance, sono solo da attribuirsi ai test proposti o c’è anche un elemento intrinseco, dato dalla stessa capacità attoriale, performativa, istintuale dei protagonisti in scena? […] I sempre efficaci giovani si prodigano in funamboliche evoluzioni, gag, si sparano e muoiono a ripetizione, come una coazione a ripetere. Il riso scaturito dall’azione comica ripetuta all’infinito, stereotipata. Tentano il suicidio, lo istigano, con il finto gas esilarante, e poi ti dicono che non è niente vero. E’ tutto finto. “Voi ridete, ma noi facevano apposta”, come dire: vi abbiamo fatto ridere e voi sapevate che era finto ma avete voluto credere che sia reale, così fa ridere. Meta-comunicazione della risata. Riproducono la comicità surreale da cartoni animati dove lo sfigato di turno muore sempre e rinasce subito dopo. Stimolo irrisorio suscitato (anche) dalla violenza. Violenza sull’attore, violenza su uno spettatore. Si ride anche per non fuggire, si ride per paura. Il lavoro dei Sotterraneo […] è un serio e lungimirante approccio ad una ricerca di senso, di scoperta, da dove, eventualmente, indirizzare l’azione puramente teatrale».
Roberto Rinaldi, www.rumorscena.it
«Teatro Sotterraneo, dopo il dittico sulla specie, con il geniale e brillante Homo Ridens continua l’indagine – ovviamente performativa – intorno all’essere umano e ai suoi comportamenti. Ad essere analizzato è qui il fenomeno del ridere: come dicono gli stessi attori in scena l’uomo è l’unico animale che ride e che secondo Nietzsche si è inventato il riso per la sua troppa sofferenza. Teatro Sotterraneo parte proprio da qui, da quel confine sottile che separa l’ilarità dalla tragedia, da quello stimolo che forse proprio per sopravvivenza porta a sorridere davanti a una foto di morte e di dolore. Mettendo sempre alla prova e sotto analisi il pubblico, i cinque componenti di Teatro Sotterraneo coinvolgono attivamente lo spettatore e lo sottopongono continuamente a risate intelligenti disorientandolo e facendolo interrogare sulla propria integrità morale, sul grado di cinismo di cui si è dotati o sull’eticità collettiva. Come si può ridere di fronte alla morte? Lo si può fare se la morte è una finzione: ed ecco che nella loro iperattività sul palco i quattro performer entrano ed escono continuamente da rappresentazione e realtà; ma la finzione rimanda pur sempre a qualcosa che esiste nel reale: per quale motivo qui si potrebbe essere scusati nel ridere di fronte all’orrore? Dove è lo scarto, che meccanismo scatta dentro l’uomo? Per sopravvivere e per continuare a vivere in questa società, il cinismo diventa uno scudo per proteggersi di fronte alle atrocità che ogni giorno ci circondano. Forse intorno a tutti gli studi sul ridere a spuntarla con la sua teoria poco scientifica ma necessariamente umana è stato proprio Nietzsche».
Carlotta Tringali, www.iltamburodikattrin.com
«Ride bene chi ride ultimo. Non è sempre vero. Anzi. Il riso abbonda sulla bocca degli stolti. Ne potremmo discutere, visto che, come ci sottolineano i Sotterraneo in questa loro indagine sociologico-antropologica, […] l’uomo è l’unico animale sul globo che sa ridere, forse proprio per combattere la drammaticità e la tragicità del complesso sistema in cui si è infilato rendendo tutto più difficile. […] Questo è l’arcano, il nodo da sciogliere per Daniele Villa e soci. Perché si ride. Per emulazione, per esorcizzare un momento, un accadimento, per allontanare la morte, il dolore, per sentirsi vivi e soprattutto vegeti. Si ride ai funerali, si ride quando qualcuno cade o si fa male vicino a noi, si ride per isteria quando fuori tutto impazza, per non farsi prendere e soggiogare dalla follia dilagante. […] Homo ridens dà subito l’impressione di voler mirare ad una sorta di cabaret scientifico da una parte, con dati, documenti e numeri, un test sul pubblico, dall’altra ha il retrogusto delle Comiche, di quelle che ti lasciano un po’ in sospeso, in balia della prossima ondata, o meglio il sapore che lascia, come lingua d’asfalto, potrebbe essere assimilabile ai Monty Python: profondità trattata con il naso rosso del clown. […] La ripetitività delle azioni, con la faccia senza reazioni e neutra dei quattro più uno, il tono netto e distaccato che li contraddistingue, schiaffeggiano il senso comune del meccanismo della risata, scandagliandola e dicendoci a chiare lettere “non c’è niente da ridere”».
Tommaso Chimenti, www.scanner.it
«Si ride con Homo ridens. In alcuni passaggi anche di gusto, se non fosse fuori luogo. Perché fuori luogo? Perché si ride di fronte a un pestaggio, di fronte a vari tentativi di suicidio, di fronte alla violenza, la fame, l’Olocausto. […] Ma se mi chiedete il perché, non so spiegarlo. So solo che sono stata una tra le tante cavie di una serie di esperimenti. Sono stata sottoposta a diversi stimoli, tutti riguardanti il riso e i suoi meccanismi, da parte di cinque formidabili scienziati-attori fiorentini. Qual è il risultato dell’esperimento? La riflessione. La mia è stata: sono talmente assuefatta dalle tragedie quotidiane della vita che mi viene da ridere anche davanti alla violenza. Ognuno dei presenti, suppongo, è arrivato a una conclusione personale. E quando uno spettacolo produce in chi lo guarda delle riflessioni, qualsiasi esse siano, vuol dire che è un grande spettacolo perché ha raggiunto lo scopo più importante che il teatro si prefigge: stimolare la mente delle persone al pensiero, alla fantasia, al risveglio della coscienza».
Michela Di Mario, www.teatro.persinsala.it
«Non ci sono personaggi e non esiste trama in questo spettacolo di 40 minuti che non rivendica alcuna paternità, e vive dei suoi mezzi espressivi. Nel calderone della prosa contemporanea – spesso una zuppa riscaldata offerta al pubblico – Homo Ridens è un piatto espresso servito freddo. Immediato, auto-ironico, eccessivo, il suo stile è una firma d’autore, non soggetta a riproduzioni. La provocazione continua è la benzina che mette in moto il marchingegno inventato da Daniele Villa (fine e visionario drammaturgo), guidato a sua volta da Sara Bonaventura e Claudio Cirri, più l’aggiunta delle new-entries Daniele Bonaiuti e Filippo Polasini. Le repliche del 15 e 16 settembre, andate in scena nella chiesa di Santa Verdiana a Firenze, hanno registrato il tutto esaurito, e un motivo ci sarà. Forse perché il Teatro Sotterraneo scatena riflessioni e discussioni, lubrifica i meccanismi mentali con un olio fatto di tempi comici, scoppi di battute, scene surreali, ma con un piede nel reale.
La risata come fenomeno sociale e filosofico è il filo conduttore di Homo Ridens. Il modo in cui il tema viene attuato è una rivelazione, un andamento insolito, una geometria che si auto-costruisce con apparente casualità. Dalle domande al pubblico, a interazioni con lo spettatore, a scene di finta violenza che, non si sa come, fanno ridere, il fine è svelare i meccanismi della risata. Si ride per conservazione della specie, reazione alla sofferenza, o cinismo?
Esercizi meta-teatrali e presenze paradossali- come l’uomo che impersona Gesù, con addosso la maglietta I am Jesus – sfiorano il lato demenziale e intelligente di un’operazione chirurgica sul teatro, la vita, e la psiche, pienamente riuscita. La narrazione segue una linea interrotta, poi ripresa in mano, poi fatta a pezzi. Questo gioco a muso duro, con un ghigno e una risata acida, è una delle più divertenti e piacevoli creazioni degli ultimi anni».
Tessa Granato, www.fermataspettacolo.it
«Non c’è niente da ridere ma, alla fine, si ride lo stesso, forse per l’euforia di esser riusciti a sopravvivere alla caduta del senso. Da una parte “l’uomo è l’unico animale a soffrire così tanto da essersi inventato la risata”, ma, dall’altra, sembra essersi anestetizzato a tal punto da non dar più peso alle quotidiane crudeltà cui deve far fronte. E’ strano il retrogusto uscendo dal breve ma intenso esperimento di massa dove il pubblico, da giudicante, pe runa sera si è fatto giudicare: ci si sente portati a una introspezione che fa prendere coscienza del radicato cinismo che ormai sembra esser diventato una questione di sopravvivenza. La storia insegna che la Chiesa condannava la risata al punto da rappresentare Gesù Cristo serioso, in contrapposizioneal peccaminoso ma ilare demonio. Oggi invece sembra che il potere si sia reso conto dell’effett cerebralmente soporifero della risata e cerchi di far ridere a tutti i costi».
Sagoma Tredici, www.sagoma.com
«Una bomba a orologeria che ogni tot angustia lo spettatore, vero protagonista della performance, immolato a cavia da laboratorio al fine di studiare i meccanismi del riso. […] Homo Ridens è un manuale del comico dove, lo ammetto, mi sono divertita, benché, una volta concluso lo spettacolo, mi sia chiesta cosa abbia, in realtà, visto. Forse sta in questo il “mestiere” di Teatro Sotterraneo, nella capacità di lasciar il pubblico con interrogazioni sulla performance, su sé stessi o sull’umanità in generale».
Francesca Cecconi, www.losguardodiarlecchino.it
LA REPUBBLICA DEI BAMBINI
L’intelligenza sulfurea di Teatro Sotterraneo
«Questa volta facciamo un gioco. […] Se io dico “teatro per l’infanzia”, cosa mmaginate? Una miriade di vocine impagliate e di gesti sconclusionati che pretendono di richiamare l’attenzione di bambini che gli autori degli spettacoli probabilmente considerano minorati mentali. La risposta è giusta così. Senza “quasi”. Con le risposte che si infilano nelle asole come acqua, ce ne andremmo volentieri a dormire. Ma poi accade un fatto strano: con un veloce, fulminante colpo d’ali, la compagnia toscana Teatro Sotterraneo passa al festival “Inequilibrio” di Castiglioncello, dove orchestra uno spettacolo per l’infanzia (La Repubblica dei bambini), e allora le cose non vanno più al posto assegnato e bisogna re-imparare tutto. […] Se potete, portate i bambini a vedere La Repubblica dei bambini e capirete definitivamente che sono degli esseri completi dotati di tutti i sentimenti, che non vanno trattati come idioti. Il gioco che i performer toscani conducono con loro è “didattico” nel senso più alto del termine. Via i racconti superflui, le pappardelle scolastiche, la sfilza di date e di narrazioni raccapriccianti che dovrebbero impaurirli e allontanarli dal male (raggiungendo l’effetto opposto, a causa di evidente orrore estetico). Qui si agisce e si mostra in un fulmineo pezzo di teatro, quanto sia facile la tentazione del male. Non si insegna niente, si mostra soltanto, si agisce. Con divertimento. Ma c’è modo e modo di ridere. Come c’è modo e modo di educare e di allenare ad un pensiero “civile” che non può che partire da un “accuso me stesso” (e non sempre e solo gli altri), da uno sguardo feroce sui propri stessi automatismi. In questo tipo di lavoro, gli attori di Teatro Sotterraneo sono diventati sempre più sottili, raffinati. Provocando in chi guarda un piacere particolare, che è quello che nasce tutte le volte che l’intelligenza umoristica (ragione e sentimento) trova il suo punto di fusione e di incontro».
Katia Ippaso, Gli altri
«Con la La repubblica dei bambini (vincitore del premio Eolo Awards Migliore Novità 2012) si inaugura la trentaduesima stagione artistica Young di Le Nuvole/Casa del Contemporaneo dedicata ai più piccoli. Si tratta di uno spettacolo teatrale dai confini molto ampi, che tendono a dilatarsi fino a lambire gli ambiti della politica (in senso lato), dell’educazione civica e del ‘laboratorio del pensiero’ dove ogni arditezza in vitro è non solo tollerata bensì incoraggiata.
Tutto ha inizio con un’idea da dover realizzare, quest’idea risponde al nome di ‘Nazione’, e il territorio in cui ci muoviamo sembra essere del tutto inesplorato, non esiste infatti un ordine precostituito da dover seguire e tutte le possibilità sono potenzialmente attuabili. Le domande sono moltissime e non esistono certezze, pertanto l’unico modo per poter procedere sembra essere il gioco delle domande e delle risposte attraverso il quale tutto viene messo in discussione al fine di avvicinarsi ad una verità. È, quindi, un approccio che si avvicina alla ricerca filosofica delle origini, quando i grandi filosofi ateniesi servendosi del dialogo e degli interrogativi corrosivi facevano cadere a pezzi ogni armatura di presunta sicurezza, inoculando il virus del dubbio.
Chiara Renzi e Daniele Bonaiuti irrompono sulla scena con un progetto da realizzare in un tempo perfettamente coincidente con la durata della rappresentazione; cinquantacinque minuti durante i quali dovranno essere gettate le basi di una nuova micronazione dei bambini. Concetti come: territorio, confini, popolazione e regole, vengono introdotti con intuitiva semplicità ed ironia in modo da coinvolgere il giovane pubblico in una azione politica primordiale tesa ad edificare uno Stato ideale.
L’esperimento coinvolge dal primo momento i piccoli spettatori che, liberi da preconcetti e sovrastrutture, prendono al volo l’utopia e rilanciano con entusiasmo proposte e soluzioni. Una Nazione bellissima inizia a prendere forma e, con cartelli della segnaletica stradale, viene stilata una dichiarazione d’indipendenza in cui diritti inviolabili e divieti universali non hanno bisogno di articoli, commi ed interpreti costituzionali, infatti dei semplici disegni rendono inequivocabile il fatto che: “Nessuno ha il diritto di inquinare e sporcare il territorio; nessuno ha il diritto di essere violento con gli altri; tutti hanno il diritto di mangiare e vestirsi; tutti hanno il diritto di giocare, di essere felici, di non avere paura e di poter usare l’immaginazione…”. Ma è inevitabile che l’utopia prima o poi debba scontrarsi con la realtà e l’illusione è destinata ad infrangersi sulle asperità della politica reale, l’impatto è inevitabile, d’altra parte lo stesso Platone, con la sua Repubblica, ebbe non poche difficoltà a superare incolume le insidie che trovò al bivio utopia/realtà. La nuova Nazione deve fare delle scelte importanti, deve stabilire la forma di governo più giusta, quella che escluda ladittatura ed assicuri la felicità del suo popolo.
Inaspettatamente Chiara e Daniele dismettono gli abiti dell’umile laboriosità delle idee per indossare quelli di una Realpolitik repubblicana dei nostri tempi fatta di vuoti comizi elettorali e di promesse irrealizzabili servite su rassicuranti sorrisi. Con ironia e realismo lo spettacolo offre un eloquente scorcio della politica moderna in cui i compromessi infrangono le promesse, gli ideali scompaiono e un’ombra oscura sembra paralizzare la neonata repubblica dei bambini. Ma saranno proprio questi ultimi a reagire abbattendo la quarta parete, infatti il piccolo pubblico che non vuole rinunciare al sogno che ha contribuito a far nascere, interviene attivamente innescando una sommossa rivoluzionaria. Mentre il tempo della nuova repubblica sta per finire ci accorgiamo che il numero dei problemi e delle domande accumulate e rimaste inevase è aumentato in misura esponenziale, i piccoli cittadini al termine dello spettacolo si renderanno conto che non ci sono formule magiche e risposte certe capaci di risolvere tutto come nelle storie a lieto fine, e forse scopriranno che la magnifica Repubblica dei bambini che avevano contribuito a fondare è solo una bella utopia. Ma d’altra parte era proprio questo l’obiettivo: divertire e giocare su cose da prendere sul serio, costruire dal piccolo ed edificare con cautela per il bene comune; e, dalla partecipazione emotiva mostrata dal pubblico durante tutta la rappresentazione, pare proprio che questa Repubblica abbia colto e lasciato il segno».
Grazia Laderchi, il Pickwick
«Lo ha creato Teatro Sotterraneo, un gruppo, anche questo, emerso dal premio Scenario qualche anno fa, con un’attitudine ironica a smontare il linguaggio, il comportamento, giocando tra la catastrofe di un quotidiano malato e la risata a labbra tirate.
Qui, in modo eccessivo, clownesco, si porta gli spettatori nella costruzione di una piccola repubblica, circoscritta dai muri del teatro, che durerà il tempo dello spettacolo. Si mettono in scena le dinamiche di uno stato, la necessità delle regole e l’istinto a violarle, la democrazia e la tentazione di abusare dei poteri, dei diritti, della libertà che dà. Si coinvolgono gli spettatori in comizi per assicurarsi l’elezione a presidente, promettendo sempre più dell’altro candidato, non risparmiando colpi bassi, in un’iperbole che non potrà non essere disattesa, con esiti catastrofici. Si trasporta gli astanti nel corpo della democrazia, della difficile arte di convivere, facendo fare esperienza di alcuni passaggi che di solito la scuola affida a enunciazioni concettuali. Si sperimenta la difficoltà di vivere insieme; si percorre, ridendo, giocando, sporcando, inciampando, provando l’abisso del tradimento, della soperchieria, la necessità di farsi sentire e di ascoltare. […] Intanto la materia ha vissuto nella temporanea assemblea, dividendo, costringendo a operare scelte, a indignarsi; procurando esperienza.
Il nuovo teatro per bambini è sempre più un luogo di esperienza, dei sentimenti più indicibili, di cose apparentemente lontane, che invece ci riguardano. Esperienza per gli attori e per gli spettatori».
Massimo Marino, www.doppiozero.com
«Inserendosi a pieno diritto nella tradizione del “dramma didattico”, che fece la fortuna di Brecht, La Repubblica dei bambini è un’operina squisitamente e coraggiosamente politica. […] È amaro, quasi un po’ cinico il sottotesto di questa pièce, certo molto attuale, sfumata, problematica. Mette in campo domande, più che esibire risposte».
Camilla Tagliabue, Il Fatto Quotidiano
«Inizia così una girandola colorata e di grande ritmo attorno ai temi della cittadinanza, della democrazia, del potere. Come se si trovassero in un gioco di ruolo, il pubblico di bambini e adulti è invitato a interagire come “popolo” del nuovo microstato, partecipando alle elezioni e sperimentando sulla propria pelle le degenerazioni a cui può giungere la democrazia. Il risultato è un lavoro esuberante e fresco, in grado di coinvolgere non solo i bambini, perché viste sotto la lente dell’“infinitamente piccolo” le grandi leggi che governano la convivenza tra gli uomini rivelano il loro carico di convenzione, e quindi la loro estrema fragilità, che va difesa – ma anche ripensata – costantemente. Lo spettacolo vive di una bella energia, grazie all’entusiasmo che i due attori scelti per questa produzione trasferiscono allo spettacolo. C’è divertimento e pensiero ne La repubblica dei bambini, e persino una quota di temi difficili come il terrorismo – un attentato sconvolgerà, anche se per poco, la vita della micronazione».
Gragiano Graziani, www.grazianograziani.wordpress.com
«Molte le occasioni per ridere, alzare la mano, rispondere coralmente, un coinvolgimento attivo e colmo di sorprese, una tensione all’ascolto sempre esuberante, con la voglia di capire e intervenire dialogando in forma dinamica all’interno di uno spettacolo colmo di pensiero, denso di spunti di riflessione, fitto di questioni che coinvolgono insieme grandi e piccoli. Una meraviglia. Raro incontrare uno spettacolo per ragazzi che riesca a suscitare un’adesione così continua,intensa, ilare mentre si affrontano e si depositano problematiche di così vasto e concreto spessore».
Valeria Ottolenghi, Il Gazzettino di Parma
«Semplicemente strepitosa La repubblica dei bambini […]. Uno dei più interessanti tra i giovani gruppi italiani – senza rinunciare al proprio linguaggio, anzi per l’occasione esaltandolo ancor più – riesce nell’impresa ostica di far capire ai piccoli l’abc della politica. Scoppiettante, gremito di idee e spesso travolgente, La repubblica dei bambiniavvince tutti in un gioco tanto semplice quanto profondo».
Nicola Viesti, Il Corriere del Mezzogiorno
«L’altro spettacolo nobile è stato La repubblica dei bambini […]. Lo stile di Teatro Sotterraneo che abbiamo cominciato ad amare da tempo, tutto intriso di ironia purificatrice e di interattività, dove l’icona del cellulare fa anche qui mostra di sé, induce i bambini a scegliere i confini, le regole, la forma di governo, chi li dovrà governare, le modalità di lotta da intraprendere contro chi se ne approfitta, accorgendosi loro malgrado che la democrazia, almeno quella che conosciamo, è imperfetta ma che dobbiamo metterci di impegno a sperimentare nuove occasioni di condivisione per vivere più serenamente nella la comunità in cui viviamo».
Mario Bianchi, www.eolo-ragazzi.it e youteatro
«Può nascere una nazione governata grazie al volere superiore di soli bambini? Domanda retorica, forse, ma anche se vi sono due adulti, un uomo e una donna, in scena, in realtà chi decide del loro futuro politico, sono i bambini. Seduti in platea, ma con un preciso potere di eleggere e rimuovere dall’incarico – il o la – presidente della nazione. In assoluta libertà di pensiero, scevro com’è da condizionamenti miranti ad aumentare il proprio potere individuale, o peggio ancora, a trarre benefici e guadagni, spesso in contrasto con l’etica e la morale. Come accade, invece, purtroppo sempre più di frequente, agli adulti, aggrappati alle loro cariche e prebende. Per fortuna che nella Repubblica dei bambini, made in Sotterraneo e Briciole, si ride e ci si diverte. Cosa c’ è di meglio se non insegnare a vivere (anche) con lo strumento del riso e dell’ironia. […] Nello spettacolo recitano con professionalità sicura Daniele Bonaiuti e Chiara Renzi. Si ride tanto e si percepisce il tragico che sta dietro alle divertenti gag scandite a ritmo vertiginoso, una più comica dell’altra. Ma la comicità non nasconde, spesso, la tragedia? Ce lo insegnano i grandi maestri del passato, mentre il presente storico è più tragico che comico. Meno male che in questa nuova produzione teatrale, c’è spazio per l’allegria e il divertimento, non senza però soffermarci su debite riflessioni. […] Non è più gioco-finzione, qui si parla di satira, c’è sarcasmo, una sottile critica al sistema malato».
Roberto Rinaldi, www.rumorscena.it
«Quando il teatro con la sua dimensione di realtà e finzione offre la possibilità di un contatto esperienziale, diventa un momento particolarmente significativo. Lo spettacolo La Repubblica dei bambini tesse i fili di una trama preziosa, conducendo i bambini a una consapevolezza di sé, del proprio punto di vista. I bambini sono via via coinvolti in una situazione che li “chiama dentro” sempre più nella costruzione dello stato in miniatura: dal racconto incalzante della situazione iniziale, alla provocazione sulla necessità di regole, si ritrovano protagonisti e chiamati a prendere decisioni importanti. Ma è un ruolo in cui entrano con facilità perché colgono il senso del loro esserci. Il loro reale coinvolgimento è fortemente motivato, perciò si lasciano condurre e diventano veri cittadini. Il bambino si ritrova così protagonista dello svolgersi delle vicende e si sente parte attiva di un tutto. Il mondo della scuola purtroppo rischia di travolgere i bambini con le sue richieste pressanti di obiettivi da acquisire e competenze da raggiungere, una scuola dove il bambino può perdersi di vista e smarrirsi. Il centro va riportato su di lui, sulla scoperta di sé come portatore di pensiero, di emozioni, di idee. E che qualcuno raccolga l’unicità del suo mondo e lo ascolti senza dare nulla per scontato. I bambini osservano gli adulti e a volte ci stupiscono con le loro puntualizzazioni. In questo spettacolo viene loro data la possibilità di vedere il mondo da dentro, ma anche dall’alto, dalla statura dell’adulto e di indossare panni insoliti. Ma che conferiscono il fascino della decisione… I bambini stanno al gioco perché il gioco per loro è cosa vera. E il teatro si inserisce perfettamente in questa dinamica».
Carla Mazzoni, insegnante classe III, Scuola primaria “C. Collodi”, S. Ilario d’Enza (Reggio Emilia)
L'ORIGINE DELLE SPECIE_DA CHARLES DARWIN
«È difficile ritenere in crisi un settore artistico così ricco di nuovi talenti, così vitale sul piano creativo. Per rendersene conto, basterebbe assistere a L’origine delle specie, dall’opera di Darwin, che Teatro Sotterraneo presenta al Fabbricone di Prato […]. Nella visione solo apparentemente giocosa – in realtà alquanto acre – di Teatro Sotterraneo la vita è un crudele ciclo che nasce, si sviluppa, si evolve e fatalmente è condannato a estinguersi. L’origine delle specie ribalta in qualche modo i presupposti dello spettacolo precedente, Dies irae _ 5 episodi intorno alla fine della specie, partendo dall’inizio del tragitto umano, laddove là ne inquadrava l’apocalittica conclusione: ma invertendo l’ordine dei fattori, nel perfetto teorema del gruppo fiorentino, il risultato a quanto pare non cambia, e il futuro che ci attende è ancora un paesaggio di rovine e desolazione. Se Dies irae si proponeva di fornire cinque ironici modelli di auto-distruzione, L’origine delle specie ripercorre la nostra storia collettiva dal brodo primordiale al definitivo spopolamento del pianeta, ricostruendola attraverso una serie di linguaggi diversi […]. Pochi gruppi sanno usare come loro i linguaggi del proprio tempo, ricavandone molteplici soluzioni espressive […]. Lo stile è come di consueto spoglio, quasi privo di intenti rappresentativi: ma qui, rispetto alle abitudini del gruppo, pare di cogliere il bisogno di una maggiore articolazione espressiva. […] Il tono, come al solito, è beffardo, scanzonato. Ma il sorriso nasconde una morbida ferocia […]. Proprio questa commistione di leggerezza e profondità di pensiero fanno di Teatro Sotterraneo una delle realtà più interessanti del teatro italiano di oggi. […] A colpire davvero è la sicurezza con cui il drammaturgo Daniele Villa e i tre attori tornano su un tema già affrontato, senza dare neppure per un attimo la sensazione di ripetersi, anzi rivelando un’insolita capacità di scavare, di approfondire, di andare avanti».
Renato Palazzi, Il sole 24 ore e www.delteatro.it
«”La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla”, dice Garcìa Márquez. A questo mutamento virtuoso e virtuale s’ispira Teatro Sotterraneo convertendo L’origine delle specie di Darwin in uno spettacolo di acutezze e nuovi format odierni a base di decalogo scientifico, videogioco su creazione e distruzione di un ecosistema, poetica delle selezioni naturali. Del trattato di 150 anni fa resta un mordace dialogo da laboratorio […]. Le teorie evoluzionistiche s’avvalgono di grafica, scenari biologici, teneri misteri animaleschi. Gli attori danno una sferzata ai miti facili darwiniani».
Rodolfo Di Giammarco, La Repubblica
Evoluzione o morte. Darwin e il Teatro Sotterraneo
«Adattarsi all’ambiente simbolico. È l’imperativo per non morire, anzi per non estinguersi, esposto in una delle scene chiave del nuovo spettacolo di Teatro Sotterraneo dal titolo L’origine delle specie _ da Charles Darwin – che con il precedente Dies Irae forma un “Dittico sulla specie” – di recente in scena al Fabbricane di Prato. A spiegarlo ad uno sconsolato ultimo Panda sulla faccia della terra (che, proprio per questa sua condizione, cerca la morte) è niente meno che Mickey Mouse, Topolino, che fa vedere come la sua figura di topo dal 1928 a oggi si sia modificata, andando ad assomigliare sempre di più a un bambino umano. «Evolviti!» è l’imperativo di Mickey Mouse, e con lui quello del mondo circostante a cui tutti sembriamo aderire: individui, gruppi sociali, partiti politici, occupati in questi tempi di confusione e atrofia della capacità di immaginare altri mondi possibili a replicare se stessi nella versione più socialmente accettabile. È questa la potente metafora di uno spettacolo che ruota ironicamente attorno alla figura di Darwin e alla sua proiezione nel presente. Tra scene asettiche di dottori in camice e proiezioni computerizzate dell’evoluzione del mondo dalle eruzioni primordiali alle città contemporanee (prese dai videogiochi di fondazione modello Sin City, dove chiunque può giocare ad essere Dio), Darwin viene apostrofato da filosofie, religioni e ideologie a seconda delle rispettive necessità. Hitler, Marx, Freud, Mendel, il Dalai Lama, e persino un pretestuoso Super Mario che dalla prospettiva dell’immaginario collettivo contesta i limiti della biologia reale – il tutto interpretato da due performer che indossano di volta in volta delle magliette con una scritta identificativa – tutti tirano la giacca di Darwin ringraziandolo o contestandolo, fino alla finale e riconciliativa foto che Wojtyla si fa fare con lui… Ma fatta la tara dell’ironia, cifra abituale degli spettacoli del Teatro Sotterraneo, ciò che ne esce è un panorama da umanità sull’orlo del collasso, dove il picco dell’evoluzione coincide con il picco dell’adattamento ma anche dello snaturamento della specie; un affresco che per certi versi ricorda una visione da romanzo di Houellebecq, ma fortemente depurata della riflessione che lo scrittore francese fa sulla decadenza del tempo presente. Il collasso di cui parla L’origine delle specie – realizzato da Sara Bonaventura, Iacopo Braca e Claudio Cirri in scena, Daniele Villa ai testi – è piuttosto connaturato alla teoria dei sistemi complessi, dove a un massimo di complessità si accompagna un minor margine di errore che però, quando si verifica, assume le proporzioni del disastro. È la parabola del treno in corsa che nessuno sa più fermare –come ne «La freccia gialla» di Viktor Pelevin, dove col passare del tempo neppure ci si ricorda di essere su un treno lanciato a tutta velocità verso la rovina – ma senza toni apocalittici. La prospettiva è accanto a noi, consustanziale al nostro presente, e forse si può attivare all’improvviso con un semplice comando, come l’opzione del videogioco che, con un singolo colpo di mouse, permette di distruggere l’intera città».
Graziano Graziani, Carta
«Da qualche anno si è affacciato alla scena italiana, tra gli altri, un giovane gruppo teatrale fiorentino che si distingue nell’applicare un metodo di creazione collettiva e nel presentarsi allo spettatore con una particolare sfrontatezza scenica. […] E che i loro lavori siano frutto di una visione non unitaria né lineare lo si evince facilmente dal contraddittorio interno che, con linguaggi semplici(ovvero complessi e filtrati) e con una sapiente manipolazione di ritmi e azioni, si produce a ogni scena. È questo forse uno degli aspetti più attraenti dei loro lavori, dove ognuno può ritrovarsi, in un angolino, a braccetto con i paradossi della propria dote genetica e di quella acquisita (ovvero fatta ad arte). Essere spettatori di Teatro Sotterraneo è come essere colti in castagna, e non dalla presa scivolosa di un cabarettista che ci imita nella verità finta del suo esaltato studio televisivo, bensì dalla finzione vera di un patto teatrale senza belletti. […] Il gruppo ottiene spostamenti di senso che associano alla logica dell’assurdo l’assurdità della ragionevolezza, che percorrono quel tunnel di “banalità ininterrotta” e “terrore inconcepibile” in cui non da ieri ci ha scorto Susan Sontag; e pone lo spettatore, attraverso un presunto coinvolgimento nell’azione drammaturgica, al suo posto passivo di spettatore del proprio stesso disastro. Tutto è dichiarato e niente è detto, tutto è detto ma in forma di pochissime parole, spesso brevi dialoghi colloquiali, quasi sempre cose di poca importanza, come noi, in un contesto, il teatro, speciale nel rendere unica l’importanza di ogni cosa. Alcuni detrattori gridano “alla televisione”, come un mercante derubato griderebbe “al ladro”, forse per l’effetto che fa il ritrovare quel ridere del quale il mondo della comunicazione si è appropriato e che quindi oggi riconosciamo come inquinamento. E invece è proprio nell’accogliere il ridicolo del luogo comune che questo gruppo affronta in qualche termine, e pur con esiti diseguali, la spudoratezza e l’imbarazzo come terreno creativo. Il pubblico teatrale più avveduto può ricondurre alcune dinamiche di minimalismo spiazzante a certi lavori di un altro collettivo teatrale fiorentino che li precede anagraficamente di qualche anno (Kinkaleri), ma ciò che differenzia questo nuovo ensamble è il tentativo di ricondurre alla forma propria del teatro alcune di quelle sperimentazioni che gli altri hanno invece spinto sempre più radicalmente verso la performance; e lo fa, il Sotterraneo, non senza accollarsi i rischi che la forma chiusa comporta quando si tolgono le redini alla banalità e al suo far male. Non è un caso se ricorre, nei lavori del gruppo, l’uso di un palese e irrevocabile conteggio del tempo, quasi a scandire con un metronomo l’incombente fallimento dell’arte e dei suoi artefici».
Cristina Ventrucci, Lo Straniero
«Teatro Sotterraneo si sta progressivamente confermando una delle realtà più solide […]. La scrittura di Daniele Villa risale dalla “fine della specie” ai suoi inizi, chiamando a testimoniare Charles Darwin, secondo quella cifra di informale immediatezza che è propria del gruppo. […] Quel che caratterizza il lavoro di Teatro Sotterraneo non è forse una scherzosa ironia, come qualcuno vorrebbe, troppo facile da agire, ma la dismisura. Cioè la distanza che mettono fra l’azione e la sua significazione. Li abbiamo conosciuti che correvano in tondo in questa sala (La Cosa 1), oggi ci dicono di un disagio più difficile da rimuovere delle paure sulla fine dell’umanità».
Gianni Manzella, Il Manifesto
«La parola “estinzione”, eletta a titolo della scena, ma anche lemma del dizionario darwiniano-sotterraneo che struttura lo spettacolo, riecheggia cupamente altre questioni, con le quali il teatro è costretto a confrontarsi aspramente: il ricatto più bieco della comunicazione e della pubblicità, le politiche del consenso e del successo, i rapporti semplificati fra scena e pubblico. […] Lo spettacolo gioca a essere sfacciatamente didattico, ma non didascalico, semplice, ma mai banale, consequenziale, ma pieno di sorprese. Un linguaggio scenico smaccatamente chiaro, volutamente ironico, ma serissimo […]. Così Teatro Sotterraneo, prodotto per la prima volta da uno Stabile, si mostra seriamente cosciente di una questione capitale: come si sta al mondo oggi, le grandi difficoltà per continuare a “esistere”, e nello specifico a “fare teatro”, tra contraddizioni atroci. […] Con L’origine delle specie Teatro Sotterraneo attraversa la storia della vita con uno sguardo “etico” sulle cose, perché disincantato rispetto a illusioni progressiste sul mondo e la natura umana, ma non cinico. Si prova cioè a “dire” e a costruire qualcosa, ad articolare un discorso, a ricercare del senso. Si guarda dentro la mutazione umana di oggi, sapendo di farne parte, e sapendo pure che l’apocalisse è in corso e inevitabile».
Rodolfo Sacchettini, Hystrio
«I tre attori, nei loro camici bianchi, sono scienziati del nostro tempo malandato. Analizzano la specie, scompongono il pensiero di Darwin, usando i canali tipici della nostra generazione (il videogame, la t-shirt, il video). Diventano scimmie evocative che scalciano e si dimenano. Scimmie da laboratorio, scimmie da teatro atavico. In un finale dove la terra viene versata per professarvi un ritorno, il sogno svanisce subito quando entrano ed escono in processione prima un astronauta, simbolo di progresso ma forse anche di incubo futuro, e poi l’incubo certo di un soldato da guerra atomica, triste presagio e passato non remoto. È una trovata continua questo L’origine della specie: ti aspetti interpretazione e ritrovi la vivisezione di un cactus. L’analisi del vegetale. Ti aspetti la messa in scena e ritrovi un videogame. È un teatro iconoclasta, che piace alla critica ma appassiona anche il pubblico. Gremito, infatti, il Teatro Fabbricone di Prato […]. Sfacciati e sicuri di sé, i quattro giovani moschettieri Sara Bonaventura, Iacopo Braca, Claudio Cirri e Daniele Villa (i primi tre a lottare sulla scena, l’ultimo in regia in veste di dramaturg) hanno vinto la loro sfida con Darwin […]. Il loro tocco leggero addolcisce i profondi messaggi che scaturiscono da uno spettacolo dove un realismo pessimista si confonde col gioco. Non è poco, basterà ad aumentare di un briciolo la speranza».
Simone Pacini, www.klpteatro.it
«L’origine delle specie è uno spettacolo estremamente creativo e ritmato, che sa attanagliare alla scena con pochi e semplici mezzi. Si parte dal Big Bang per parlare poi della nascita dell’uomo e persino di Adamo ed Eva. Il Sotterraneo recita sempre con estremo distacco: in scena vediamo tre ragazzi che giocano a interpretare ora una scimmia, ora Charles Darwin, ora altri innumerevoli personaggi. […] E così anche un’opera scientifica può essere rappresentata con ironia e leggerezza, pur toccando anche temi scottanti come l’eutanasia, e persono la distruzione totale del creato».
Gherardo Vitali Rosati, Il Corriere Fiorentino
«La Terra, l’unico corpo planetario del sistema solare adatto a sostenere la vita, vacilla. Lo dicono media, profezie e tesi catastrofiste. Lo lasciano intendere le relazioni della Commissione Europea e l’attenzione che viene posta al problema dell’ambiente. Ma non solo. Vi sono stragi, devastazioni, uomini che uccidono altri uomini. Vi sono correnti scientifiche, artistiche e filosofiche che hanno posto al centro delle loro riflessioni l’involuzione dell’uomo. In fondo lo stesso naturalista Charles Darwin parlava di una lotta continua per la sopravvivenza all’interno della stessa specie. In un percorso a ritroso, dalla fine all’origine, Teatro Sotterraneo si confronta con il trattato darwiniano, ponendo l’attenzione sulla finitezza dell’uomo e, di rimbalzo, sulla società contemporanea.
Il dittico creato dalla compagnia, a partire da Dies Irae _ 5 episodi intorno alla fine della specie e conclusosi con L’origine della specie, lancia l’ennesima sfida allo spettatore e alla sua libertà interpretativa, approfondendo ulteriormente la ricerca perseguita dal collettivo nella sfera della ricezione. L’opera di Darwin viene riletta, elaborata e ricontestualizzata dalla drammaturgia originale di Daniele Villa con uno slittamento temporale che catapulta lo stesso Darwin nella nostra epoca. Il lavoro, coprodotto dallo Stabile della Toscana, prende avvio da una simulazione, da una riproposizione dell’accaduto sulla quale si era già soffermata la compagnia con Dies irae e in cui la storiografia veniva esplicata nella sua fallacia e parzialità. Ciò che diede inizio all’Universo, il Big Bang, non viene rappresentato nell’illusoria prima esplosione, bensì l’accaduto è ricercato e ricreato in laboratorio da un gruppo di scienziati. Tramite l’ausilio di proiezioni e altre tecnologie, come quella di un programma informatico che adotta il meccanismo dei videogiochi, Sara Bonaventura, Iacopo Braca e Claudio Cirri procedono alla creazione della Terra. Dapprima viene introdotta la specie vegetale, poi animale, via via fino all’intelligente e curiosa apparizione dell’uomo in cui creazionismo ed evoluzionismo si incontrano e sembrano sopravvivere entrambe allo scontro. Adamo ed Eva attraversano l’evoluzione dell’uomo, dalla scimmia all’homo erectus, fino alla conoscenza e all’uso del linguaggio. I presupposti fondamentali della teoria evoluzionistica si susseguono. La mutazione e la selezione si sviluppano nella figura di un panda, un enorme peluche. L’ultimo Panda sulla Terra, vittima impotente della selezione, vuole porre fine alla sua vita. A dissuaderlo da questo suicidio, giunge Mickey Mouse mostrandogli come lui si sia adattato alla selezione naturale modificando il suo aspetto con il passare del tempo. In questa divertente ma acuta lettura dell’umanità, la figura di Darwin approda in scena con la sua barba bianca, in un’iconografia riconoscibile e popolare. Come figura mistica la sua presenza si limita all’apparizione, nessuna parola gli è concessa, solo un confronto con altre figure di epoche successive che hanno convissuto e si sono scontrate con le sue teorie come Marx, Hitler, Papa Wojtyla o Andy Warhol. Esposto tutto questo si può procedere alla distruzione della Terra, una fine che con coerenza drammaturgica e storica viene determinata dall’uomo, dalla sua presa di coscienza che la vita non può essere eterna. Gli scheletri umani vengono sostituiti da altre forme di vita e che queste siano aliene o meno, l’evoluzione continua.
Anche se sono stati sperimentati nuovi linguaggi […], la visione de L’origine della specie è un’immersione totale nella poetica di Teatro Sotterraneo. L’importante incontro con la “stabilità” teatrale sembra avere trattenuto parte dell’ironia caratteristica del gruppo ma la scena è stata comunque invasa dalla loro energia. Riproduzione, mutazione e selezione delle componenti artistiche di Teatro Sotterraneo».
Elena Conti, www.iltamburodikattrin.com
«L’origine delle specie, ultima fatica del collettivo Sotterraneo, seconda parte del ‘Dittico sulla Specie’, segna un momento di maturazione e di definitivo consolidamento della compagnia toscana. Il Teatro Sotterrano, che quest’anno ha vinto l’UBU e il Premio Hystrio, è una delle realtà più stimolanti e interessanti del panorama teatrale contemporaneo italiano. Il loro è un linguaggio immediato, efficace, che coniuga sapientemente profondità e ironia. In questo nuovo lavoro individuiamo uno dei loro tratti distintivi: l’esemplificazione scenica, l’allestimento è volutamente scarno, minimalista, la scena è dominata da un maxi-schermo e da un cronometro che scandisce lo scorrere del tempo (lo stesso che ritroviamo in Dies irae). Il loro è uno stile spoglio, privo di intenti rappresentativi, il loro obbiettivo non è rappresentare, quanto piuttosto evocare. Trovo interessante come in questo nuovo lavoro siano riusciti a evitare il rischio di ripetersi, riuscendo a rinnovarsi e a reinventarsi, senza snaturarsi: un’insolita e rara capacità di indagine, gli permette di scavare, approfondire, sviscerare le tematiche, per poi andare avanti, oltre. L’origine delle specie compie un percorso inverso rispetto a quello fatto in Dies irae: si procede dalla fine all’inizio. Lo spettacolo è una riflessione ironica e dissacrante sul concetto di specie, nelle sue molteplici declinazioni, animale, umana, vegetale, e sulla sopravvivenza: assistiamo al crudele e insindacabile ciclo dell’esistenza che nasce, si sviluppa, si evolve ed è destinato a estinguersi. Ripercorriamo la nostra storia collettiva, il nostro passato, dal brodo primordiale al definitivo spopolamento del pianeta, in chiave “sotterranea”: è il singolare rapporto tra il Teatro Sotterraneo e il padre dell’Evoluzionismo, Darwin. In questo secondo episodio del dittico possiamo notare la maggior articolazione espressiva messa in atto dal collettivo e l’avvalersi di una molteplicità di linguaggi diversi: dallo stile “videogame”, all’uso delle maschere, fino ad arrivare a una sorta di abbozzo di personaggi; l’intero lavoro è caratterizzato da un tono scanzonato, ma beffardo, “sbeffeggiante”, a cui ci hanno abituato i sotterranei. Il sorriso del Sotterraneo non è mai innocente e privo di implicazioni, nasconde sempre una ferocia e un crudele cinismo e disincanto. Sfacciati senza essere eccessivi, sicuri di sé senza essere presuntuosi, i Sotterranei hanno decisamente vinto la loro personale sfida con Darwin. Colpisce l’assoluta sicurezza del dramaturg, Daniele Villa e l’estrema padronanza della scena dei 3 attori, Iacopo Braca, Claudio Cirri e Sara Bonaventura, unico assente in questo ultimo lavoro il 5° sotterraneo, Matteo Ceccarelli: in scena si è avvertita la sua mancanza, sebbene questo non ha compromesso lo spettacolo che risulta essere organico ed efficace, funzionale ed equilibrato, di ampio respiro. Ciò che rende il lavoro del Sotterraneo unico e originale è la loro innata capacità di saper porre le domande giuste, piuttosto che dare risposte: il dubbio è sintomo d’intelligenza, più che la fede e la fiducia sconfinata».
Valentina Scossa, teatro.org
«L’ultimo panda sulla terra si estingue perché morire, lui, lo vuole. È un panda sciolto dalla tristezza, ancora più triste in quel corpo di peluche gigante che a farci ridere proprio non ci riesce e ci riempie invece di tenerezza, che si stende sul lettino della scienza e aspetta l’iniezione letale. Si può scegliere il momento dell’estinzione? C’è spazio per il libero arbitrio nei percorsi della natura? Può darsi. Dipende. Il ghepardo sbrana la gazzella, è ovvio; ma un topo può trasformasi in Mickey Mouse, perché si è “adattato all’ ambiente simbolico”. E allora i mille pensieri di Darwin sulla evoluzione della specie possono prendere percorsi imprevisti. […] In principio era il Verbo, per alcuni. Per i Sotterraneo di Darwin (Sara Bonaventura, Iacopo Braca e Claudio Cirri in scena, Daniele Villa alla scrittura), a mangiare la mela è una scimmia, che appunto con mille passaggi di scimmia riesce a diventare uomo e a costruire un linguaggio. Un linguaggio che serve anche a ricordare, ci segnalano dal palcoscenico, che “umano” può anche significare “essere buono”. In principio era il Verbo o era la scimmia. Il principio per l’uomo era il logos, il linguaggio, il Verbo. Va bene, il Verbo. E allora, a cosa è servito il linguaggio, origine dell’essere umano in quanto tale? A creare le distanze tra la nebulosa del sapere e le sue definizioni. A dare un contorno alle cose. A incasellare i fatti e i pensieri in un luogo “altro”, lontano dal me. A provare a dominarli. “Se lo conosci, lo eviti”. E infatti, le rappresentazioni umane di Teatro Sotterraneo in questo Origine delle Specie sono lucide, asettiche. In scena ci sono gli “scienziati”. Ci sono gli “esecutori” del sapere. Ci sono i boia. Ci sono i consapevolmente informati e pertanto non intaccati, pronti a tutto. Anche a estinguersi, se solo se ne rendessero conto. Perché le città sono un giochetto al computer che, dallo schermo sullo sfondo, crescono a poco a poco in un amalgama in cui i luoghi della natura e dell’uomo si sovrappongono. Ma la natura ha il timer: e la città può scomparire da un momento all’alto. Basta un’onda. Basta un vulcano. Nonostante rifuggano gli -ismi, i messaggi, i Sotterraneo firmano con L’Origine delle Specie uno spettacolo quasi quasi ecologista. Uno spettacolo in cui al pubblico è lasciata sì una buona dose di straniamento e di problematicità interrogativa – stile distintivo della compagnia fiorentina – ma che questa volta, rispetto alle altre produzioni spiega e mostra, e quindi decide. Senza bandiere ideologiche – anzi: è esilarante ad esempio la carrellata di personaggi storici che si beffano di Darwin: come il Dalai Lama, che “tanto si reincarna” […]. Ci parlano dell’origine per parlare della fine. Per dirci che tutto, nei processi della natura, ha un termine; e che quel termine che non possiamo controllare va però tenuto presente nel nostro qui e ora. Perché “l’ecosistema terrestre sopravviverebbe alla scomparsa di homo sapiens. Charles Darwin non ha mai escluso questa ipotesi”».
Marianna Sassano, nonsolocinema.com
DIES IRAE_5 EPISODI INTORNO ALLA FINE DELLA SPECIE
«Ed è un chirurgico e impressionante bagno di sangue, il primo episodio del Dies irae che Teatro Sotterraneo completerà in progress in altri festival».
Rodolfo di Giammarco, La Repubblica
Quella scanzonata apocalisse via sms
«Non capita spesso che lo spettacolo di maggior successo di un festival importante come “Vie” di Modena si opera di una compagnia di giovanissimi, ancora poco conosciuti a livello nazionale. Ma i lunghi applausi tributati al Teatro Sotterraneo non sono casuali: il gruppo, che con Babilinia Teatri è forse l’espressione più matura della nuova scena italiana, sa infatti combinare l’assoluta semplicità di mezzi con un pensiero teatrale complesso, che scompone e ricompone di continuo la struttura drammaturgica, sa unire l’ironia, la leggerezza alal ricerca di significati più meditati.
DIES IRAE 5 EPISODI INTORNO ALLA FINE DELLA SPECIE è un lavoro bellissimo, che tratta il tema dell’autodistruzione da divere angolazioni: nel primo episodio vediamo una mattanza raggelata, come staccata da se stessa, spruzzi di sangue, corpi abbattuti senza che nulla li colpisca. Nel secondo la parodia di una radio che invita gli ascoltatori a inviare degli sms in cui ci si chiede cosa sarebbe successo se Ponzio Pilato non se ne fosse lavato le mani o Hitler fosse stato ucciso in culla.
Nel terzo gli attori si fotografano nei minimi dettagli, come per lasciare una testimonianza ai futuri visitatori del pianeta. Nel quarto mettono all’asta la polvere di insigni monumenti. L’ultimo è folgorante: nella penombra, dei vegliardi col bastone spargono sale, poi rimangono a fissare – non si sa se ansiosi o sgomenti – un quadrante che scandisce l’avvicendarsi della fine.
Ma DIES IRAE, al di là della metafora apocalittica, può essere anche letto come una riflessione sull’incerto rapporto tra passato e futuro, tra attesa e memoria. Ogni oggetto viene dunque riposto in sacchetti di cellophane come un reperto giudiziario, ogni gesto viene inquadrato in puntigliose deposizioni da verbale di polizia, smontando il senso delle azioni precedenti, rivedendole come da un’enorme distanza emotiva. Un’altra chiave di lettura è invece quella del non esserci, dell’assenza, ovvero dello svuotamento del teatro: la violenza senza violenza della prima scena, l’appello di nomi scelti a caso dall’elenco telefonico, e puntualmente mai presenti in sala, nella seconda, l’imminente assenza dell’uomo dell’uomo steso nella terza, la perdita delle bellezze del mondo nella quarta, e infine la mancanza – o l’uccisione – del tempo, la più straziante. Anche questo stratificarsi di ipotesi interpretative rivela d’altronde una forte personalità creativa, a stento mascherata dai toni apparentemente scanzonati».
Renato Palazzi, Il Sole 24 ore
Una campionatura delle generazioni “lost in translation”
«Con Dies irae il collettivo Teatro Sotterraneo cerca di alungare il passo, rispetto alle prove precedenti, alla dimensione da trailer sovente assunta dal giovane teatro, tanto da far sospettare che sia questa una modalità di pensiero piuttosto che un format. Senza venire meno a una propria cifra espressiva di informale immediatezza e slabbratura drammaturgica. Non è tutto è ugualmente convincente in questi “5 episodi intorno alal fine della specie”, scanditi da un timer digitale che misura il consumarsi della durata performativa. L’inizio però è folgorante, con gli interpreti in tuta bianca intenti a mimare i molti sanguinosi modi di farsi male. Spari coltellate sgozzamenti in stile film splatter, con esclamazioni da fumetto e generosi spruzzi di liquido rosso che si deposita sul fondale candido come in un action painting – e infatti lo firmeranno alla fine come un quadro dipinto. La finzion è esasperata, è anzi l’oggetto stesso dell’azione, ma intanto quel crescendo di urla, di sirene d’allarme, qualche disagio lo mette proprio in rapporto all’indifferenze che lo accompagna. I passi successivi son oaltrettante stratificazioni che sovrappongono un fondale all’altro, di colori diversi, come se il presente non possa manifestarsi che sulle rovine sepolte di ciò che è appena passato, mentre come un’ossessiva colonna sonora scorrono le cover della dolente Halleluja che fu di Leonard Cohen prima di Jeff Buckley. E il presente è, purtroppo, quello mediatico così difficile da maneggiare senza perderci, quello delle trasmissioni radio con dj, dei sondaggi in diretta, delle aste televisive e dei messaggini al numero in sovrimpressione. Difficile dunque anche da seppellire. A futura memoria ci lasciano, sigillata in una busta di plastica, la macchinetta con cui si erano fotografati a vicenda corpi e gesti e infine anche emozioni e sentimenti».
Gianni Manzella, Il Manifesto
Il ruolo del testimone
«Adesso proverò a testimoniare fedelmente di quanto è successo nei cinque episodi che compongono Dies irae dal mio punto di vista. È quello che dovrebbe fare il critico, spettatore di professione. È quello che cerca di fare uno dei componenti di Teatro Sotterraneo alla fine di ciascuno dei primi tre episodi dello spettacolo. Del quarto episodio viene chiamato a testimoniare direttamente uno spettatore, del quinto l’onere della testimonianza torna al critico. Questo tormentone della testimonianza in diretta solleva non poche domande: cosa abbiamo visto? di quale e quanta attenzione siamo capaci? come possiamo testimoniare di quanto (ci) è successo? quale valore può avere la nostra testimonianza? Domande che a loro volta sollevano altre domande sugli strumenti di cui ci serviamo per interpretare il mondo e sull’assunzione di responsabilità con cui quotidianamente veniamo a patti. Domande che Teatro Sotterraneo pone con la leggerezza a cui ci ha abituati, coniugando complessità e accessibilità come di rado capita di vedere sulle nostre scene (hallelujah!). Costruito per accumulazioni e azzeramenti, questo saggetto sulla serialità – in cui alla fine di ogni episodio un nuovo pavimento copre le tracce rimaste dell’episodio precedente – è scandito dalle azioni di quattro attori vestiti con magliette che illustrano gli stadi di un’evoluzione della specie costantemente smentita da quello che succede. Già, ma che cosa succede in Dies irae? Succede che la scena ci spinge a interrogarci sulla perdita dell’esperienza, sulla mercificazione della violenza e del dolore, sul feticismo delle rovine, sulla miseria consolatoria della demagogia, sull’immaginario da polizia scientifica di cui siamo tutti prigionieri… Sto cercando di sottrarmi al mio compito di testimone, lo ammetto. È che temo di rovinare l’impatto con uno spettacolo che fin dal prologo vive del e nel rapporto col pubblico. Per mettermi l’animo in pace potrei dire che, passando dal sarcasmo al lirismo, Dies irae procede a imbuto per episodi sempre più brevi, che comincia con uno spargimento di sangue e finisce con uno spargimento di sale, che da uno studio radiofonico in cui si vagheggia di altri mondi possibili si passa a uno studio televisivo in cui le ceneri di questo mondo vengono messe all’asta per pochi euro. Che nell’episodio centrale la scena diventa specchio del nostro essere perennemente turisti, classificatori di azioni e di emozioni da cui ci teniamo sempre più a distanza, tanto da affidarne la testimonianza a macchine fotografiche usa e getta. Il resto dovrete scoprirlo da soli: ne vale la pena, dal mio punto di vista».
Andrea Nanni, Hystrio
«Sono bastati pochi spettacoli, un inizio in sordina seguito subito dopo da un exploit desacralizzante […] per decretare il successo di Teatro Sotterraneo, un successo tanto inconsueto quanto ingombrante, perfino imbarazzante. Le aspettative, si sa, possono far nascere uragani in un bicchier d’acqua. Eppure eccolo qui il gruppo, giovane gruppo toscano, quattro attori e un drammaturgo col piglio di chi non si prende mai sul serio, pronti a spiattellarci in faccia con cinica crudezza il nuovo Dies irae _ cinque episodi sulla fine della specie(titolo che tradisce un disinvolto nichilismo), spettacolo ancora una volta apparentemente “leggero”, d’altronde, come nei modi che sino ad oggi hanno accompagnato il climax dei lavori del Sotterraneo […]. Fatto a quadri, nella forma di clip in successione con tanto di stop motion, e che del clip ha il ritmo e la bastarda convenzione interlocutoria con lo spettatore, alla Brecht per intenderci, Dies iraeè un progetto teatrale duro come il marmo, asfissiante, maturo, anzi anticipatore. Eppur si ride. Teatro Sotterraneo è la giovane realtà della scena italiana che prima di altre della sua generazione ha avuto il coraggio di non indulgere ai propri autocompiacimenti, benché l’emozione estetica che lo spettatore assapora assistendo allo spettacolo assomigli a una sorta di celebrazione generazionale nella quale riconoscersi. Ma il gruppo sembra lasciarsi alle spalle quella certa aura giovanile tanto amata da certo giovanilismo senile, riuscendo a profanare con impietoso cinismo l’eclissi del senso di quella materia d’arte che col teatro inevitabilmente prorompe, trasmuta verso un altrove tutto da ricomporre nel puzzle spezzettato di suoni, corpi, attese e tangibili materie che sono lì per significare loro stesse e null’altro. […] E la forma epica nello spettacolo del Sotterraneo, in quello scandaglio del quotidiano o del reale – come usiamo dire – mistificato da divertenti e surreali “postfazioni” sceniche, altro non è che una nuova o ulteriore versione di quella tragedia post-drammatica che si cerca di raccontare in questi anni. Più che a uno spettacolo vero e proprio, Dies iraeassomiglia a una postfazione, un prodromo dell’intenzione del dire, di volta in volta sottratta alla efficacia e alla effettiva mostra di sé: […] assomiglia a una sovrapposizione di segni, un accumulo di matriali “naturali”, una specie di vertigine della lista – drebbe Umberto Eco – in attesa dell’estinzione. […] È uno spettacolo-catalogo, un museo virtuale».
Paolo Ruffini, Art’O
Countdown to extinction
«Su un fondo asettico si muovono quattro figure in tuta bianca, che ricordano le tenute anticontaminazione di tanti film catastrofici sfornati dal cinema degli ultimi anni. Mimano dei massacri, sgozzamenti, estirpazione di arti, sbudellamenti, ma il loro gesto produce un segno visibile: uno schizzo di sangue che dilania il bianco della scena. Il sangue è vernice, e lo è manifestamente: con un erogatore, una delle figure crea l’effetto dello spruzzo in sincrono con gli squartamenti. Inizia così «Dies irae – 5 episodi intorno alla fine della specie», l’ultima fatica di Teatro Sotterraneo, che ha debuttato a Modena per il festival Vie. Titolo altisonante per un lavoro che mescola minimalismo e tratti di forte ironia, come è tradizione per questa formazione fiorentina. Ma il contrasto sembra quantomai ricercato, perché il primo episodio introduce l’apocalisse parlandoci del rapporto ammiccante che l’arte ha intrecciato con la violenza (causa-effetto della sua crescente difficoltà nel “dire” il mondo, secondo la parabola tracciata da Scarpellini nel recente «L’Angelo rovesciato»). Il rallenty di alcune sequenze, i colpi da arte marziale alla “Matrix”, fanno sembrare il tutto una versione unplugged di un film di Tarantino; ma la violenza, per quanto stilizzata, arriva ed è reale, come le urla strazianti sul finale. Il cortocircuito tra realtà e rappresentazione, che ci mantiene freddi davanti al massacro quotidiano di cui sono fatti i tempi di “enduring freedom”, che non ci permette di distinguere il vero dal falso né di soffrire del dolore se non ha avuto una adeguata post-produzione, è già un po’ la fine della nostra specie (almeno come specie solidale). L’arte, per non essere da meno della realtà, esibisce la violenza e né fa un gesto estetico; peccato che in questo processo non sia immune da una seduzione che fa cadere nell’indistinto il confine tra critica e adesione. Se Stockhausen ha definito scandalosamente l’11 settembre come la più grande opera d’arte mai realizzata, è giusto allora che il Teatro Sotterraneo firmi gli schizzi prodotti sullo sfondo bianco come si trattasse di un quadro di Pollock.
Queste variazioni sul tema del nichilismo odierno, scandite come un ossimoro dalle tante versioni di una canzone che sa di invocazione (“Hallelujah” di Leonard Cohen), proseguono attraversando alcuni rovelli ricorrenti della creazione contemporanea, come il rapporto interattivo col pubblico, che tratteggia l’ombra piuttosto sinistra di una democrazia dove l’unica partecipazione possibile è quella del televoto e del gioco a premi, una democrazia svuotata del suo potenziale quanto lo sono a teatro i termini “avanguardia” e “rottura della quarta parete”. Uno spettro di libertà tanto ridotto da porti davanti la scivolosa alternativa proposta al pubblico di uccidere Hitler in fasce (quindi, fino a quel momento, un “innocente”) o di lasciarlo vivere. Nella consapevolezza, prospettata da un ascoltatore del gioco, che cancellando il nazismo dalla storia scomparirebbero capolavori dell’arte e della filosofia che a partire dalla Shoah sono stati scritti. Effimera gloria è quella dell’arte, e in generale di tutti gli sforzi che fa l’uomo nel tentativo di superare i limiti del tempo e sconfiggere la morte: nell’asta a ribasso del quarto episodio, dove si svendono le sette meraviglie del mondo moderno, si ricorda giustamente che di quelle del mondo antico restano solo le piramidi. Ma anche quelle attuali, dal Colosseo al Taj Mahal, non sono che (futuri) mucchi di polvere che il presentatore estrae da un cassetto e rovescia per terra. Su questo paesaggio in rovina, che ha visto l’arte abdicare al suo tentativo di dire e dicendo contrastare la morte, fino a trasformarsi in una sorta di maestro di cerimonie del nichilismo del contemporaneo, non resta che spargere il sale – come puntualmente avviene nell’ultimo episodio.
Con «Dies irae» il Teatro Sotterraneo, pur mantenendo la sua cifra caratteristica, fatta di quadri rapidissimi – quasi delle strips – di ironia fulminea e minimalismo surreale ed elegante, affronta per la prima volta un tema unico e in modo frontale, cercando una coesione drammaturgica mai sperimentata prima da questa formazione, anche a scapito della comicità immediata che caratterizzava i loro lavori precedenti. In questi “cinque episodi intorno alla fine della specie” si ride meno, cercando di dire di più: cosa? che il tempo a disposizione non è più molto. Il cronometro che sovrasta la scena, che compie un conto alla rovescia a scandire i sessanta minuti (netti) della durata dello spettacolo, ce lo ricordano. “Countdown to extinction”, urlavano i Megadeth già agli albori degli anni Novanta (ed era già un decennio che la musica insisteva sul tasto dell’autodistruzione). Ma la rabbia di quell’urlo è scomparsa; quello che resta è l’ambigua risata dell’arte, che si fa più godibile, leggera, friabile. E ci seppellirà».
Graziano Graziani, www.carta.org
«La fine del mondo si avvicina. E non certo per colpa della profezia Maya e del fatidico 2012. L’uomo ci ha messo, e continua a metterci costantemente, del suo. Ci stiamo pericolosamente avvicinando al baratro, senza pensare alle conseguenze, immaturi, credendoci immortali. L’abisso è vicino. Dies Irae _ 5 episodi intorno alla fine della specie (prima toscana il 19 gennaio 2010 al Teatro Studio di Scandicci, sold out) è “il giorno d’ira, quel giorno si dissolverà il mondo nelle fiamme”. Il requiem è in atto. Sono “cinque episodi sulla fine della specie”, come recita il sottotitolo, quelli che mettono in scena i Teatro Sotterraneo che, senza pietà, senza tenerezza, anzi con brutale presa di coscienza agiscono nel countdown di un orologio che scorre all’indietro. Siamo già agli sgoccioli, la bomba che, prima o poi, esploderà, deflagrerà potente in un’implosione eterna fagocitandoci nella nostra piccolezza. I Sotterraneo in scena, Sara Bonaventura, Iacopo Braca, Matteo Ceccarelli e Claudio Cirri, (in cabina di regia c’è il dramaturg Daniele Villa), hanno tute, stivali e caschi bianchi quasi fossero astronauti, agenti segreti armati di mitragliatori di ultima generazione che spara sangue mediatico in quel mare fintamente candido che ci siamo costruiti attorno, lasciando il brutto, lo sporco ed il cattivo in televisione o in mondo lontano, terzo o quarto che sia. Uomini che uccidono i propri simili imbrattando e immediatamente seppellendo sotto il tappeto la polvere e le malefatte splatter mentre nell’aria gira, in varie versioni, il canto angelico e rassicurante di un“Alleluia” che cerca adepti, di una religiosità scaramantica che vuole offuscare la ragione sopprimendola a suon di gospel, inni alla gioia e segni della croce. Si gioca con la platea con il quiz radiofonico “Cosa sarebbe accaduto se” (tenete i cellulari a portata di mano, potrebbero servirvi). E pensare che il prossimo spettacolo dei Sotterraneo sarà “L’origine della specie”, prodotti dal Metastasio. Come a cercare il prequel dell’eclissi, il prima della distruzione, il come eravamo per rammaricarsi per quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto. Assolutamente da vedere. E rivedere».
Tommaso Chimenti, www.scanner.it
«Tracce sotterranee. 21:00 / 60’00”. Tempo e contro-tempo.
La prima immagine è un countdown: sono le ventuno e un timer indica che lo spettacolo finirà tra sessanta minuti. Un’ora per indagare la fine della specie: la specie umana, ovviamente.
Asettiche tute bianche, onomatopee e macchie; sembra uno splatter da fumetto, provoca il riso, ma l’effetto straniante delle prime azioni si trasforma in brivido quando la ripetizione e l’urlo caricano la scena di realtà: come scuotendo una vecchia polaroid, dalla buffa macchia iniziale si delinea un volto, una maschera di panico e dolore. È seriale, è un processo creativo, è il tempo che scorre. Creazione e distruzione si rincorrono sulla scena, ogni immagine è distrutta dalla precedente, ogni azione dalla seguente, in un perpetuo tentativo di trovare e lasciare tracce. Si lasciano segni nel tempo, nello spazio, a volte evidenti, altre meno.
Il lavoro di Teatro Sotterraneo è un lavoro archeologico alla ricerca e definizione dei segni lasciati dalla specie: una ricostruzione dei fatti che lascia anch’essa prove inequivocabili. Cinque immagini che lavorano intorno allo scorrere del tempo, alla catalogazione dell’essere umano, in tutte le sue parti fisiche e non – sentimenti, desideri, paure -. Molti i temi trattati e le fonti d’ispirazione: la scrittura scenica di Daniele Villa è carica di riferimenti. Ogni episodio parla un linguaggio diverso dal precedente, dal fumetto alla radio, alla fotografia, al cinema. Ma tutti sono destinati alla stessa fine: sparire per restare solo una prova e venire sotterrati dall’episodio successivo, fino all’esaurimento. L’unica figura ricorrente e personaggio con una sua evoluzione è quella del testimone; alla fine di ogni episodio egli riferisce l’ accaduto, e lo fa con il pubblico e per il pubblico, assumendosi un senso di responsabilità che si rivela però insostenibile, fino a logorare la testimonianza in un unico silenzio.
Il linguaggio espressivo di questo giovane gruppo toscano è variegato e spazia dalla performance al talk show televisivo, coinvolgendo il pubblico attraverso le strategie più immediate, domande dirette o l’interazione con telefono cellulare. Linguaggi e mezzi espressivi semplici che si costruiscono in giochi e scatole cinesi; la serialità e la ripetizione, tipiche del work-in-progress, divengono parte integrante del lavoro finito assumendo un nuovo significato e portando il processo creativo direttamente in scena».
Camilla Toso, www.iltamburodikattrin.it
«La nostra voglia di seguire il percorso delle nuove generazioni teatrali ci ha spinto dopo “Post it” e “La cosa1” a seguire a Modena il nuovo lavoro del Teatro Sotterraneo “Dies Irae”. In scena in Dies Irae ancora Sara Bonaventura, Iacopo Braca, Matteo Ceccarelli, Claudio Cirri su una scrittura di Daniele Villa, qui alle prese nientemeno con cinque episodi intorno alla fine della specie .
Cinque episodi ed un prologo che come è nello stile dei quattro discoli del teatro italiano sono pervasi da una ironia costante che però sottende sempre alla visione di un mondo in perenne dissolvimento. “Dies Irae” è infatti una dissertazione sul tempo. Il tempo presente, quello che il pubblico sta vivendo, è coordinato da un orologio, quello che vive, è invece un presente che si nutre, come del resto il teatro, di apparenze, dove ogni cosa non è veramente pregnante, dove ogni cosa rimanda sempre a qualcosa d’altro ed il passato non è che un cumulo di macerie. Ogni momento non è reale, il sangue ed il dolore, le scelte importanti , la vita e le sue meraviglie non vengono vissute ma solo immesse in un grande talk-show, fotografate magari per non essere neppure viste. Forse questo tempo non avrà bisogno come quello passato di essere sotterrato perchè è già in polvere. Post-it La Cosa 1 e Dies Irae si muovono dunque in un percorso drammaturgico coerente e significante».
Mario Bianchi, www.eoloragazzi.it
«Probabilmente quando arriverà il giorno del giudizio ce lo aspetteremo comodamente seduti in poltrona, davanti la tv: se ci sarà il conto finale che ci imputerà la morte del mondo naturale, di sicuro sarà trasmesso in diretta in ogni angolo della galassia e ce la vorremo gustare senza pensare che forse, questa ricerca di una misura nelle responsabilità, riguarda anche noi. Tutto questo perché il nostro obiettivo è guardare, siamo noi che vogliamo ora giudicare i buoni e i cattivi, quel giorno dissolverà il mondo e il cielo oscurerà. Ma sarà per mano nostra. Questo scenario si articola sul fondale di questo notevole Dies Irae _ 5 episodi attorno alla fine della specie, nuovo lavoro di Teatro Sotterraneo.
Il valore più grande è la proposta, il tentativo di coinvolgere nel dibattito; questo stimolo alla riflessione è un tema caldo che propone una coscienza del loro gesto, della loro costruzione semantica, oggi che invece la creazione artistica ha così poco da offrire alla collettività e invece si chiude nella fiera autoreferenziale. Tutto questo avviene perché il loro obiettivo è il gesto quando è capace di significare: in questa direzione conducono uno spettacolo capace di snidare la polvere dagli angoli delle nostre convinzioni, stimolando la rinascita di vari gradi di coscienza. Per fare questo si servono del contatto diretto: i cinque episodi hanno un legame forte che attiene alla prevalenza dell’immagine sulla realtà, della rappresentazione che sostituisce l’originale, così vanno alla ricerca di questa impressione primigenia nella connessione fra loro e il pubblico. Fra uomini e uomini.
Prima materia è la morte: su una parete di sangue in cronaca diretta dipingono una guerra e il suo prodotto, poi ci mettono la firma come opera loro, non d’arte ma di morte; dopo il crimine in termini giornalistici viene raccontato mentre gli altri ricoprono la scena, finché il crimine di fronte a chi ascolta non esiste più. Poi il “cosa sarebbe accaduto se”, gioco che diverte storici esperti e cineasti (il Tarantino di Inglorius Bastards) e che pone di fronte inquieti interrogativi: chi avrebbe saputo uccidere Hitler in culla ed evitare tutto quel male? Ancora la musica che è sempre radiofonicamente “il prossimo pezzo”, ma sempre lo stesso (Hallelujah di Leonard Cohen), di diversi interpreti: la canzone non ha più senso di per sé, per il sentimento che provoca, ma per la categoria che rappresenta. I sentimenti e le parti del corpo sono ritratti in foto, segno della loro esclusiva mostra, in luogo del reale accadere che si riduce imitazione. Gli oggetti tecnologici usati per dire sono conservati come reperti del crimine nel classico sacchetto di plastica, come se dire non fosse immune da colpe ed esso stesso un crimine. Infine le sette vecchie meraviglie del mondo, ridotte in polvere nei sacchetti, come le nuove appena decretate, mi dice chiaramente che è perduto il senso della bellezza, che alla nostra percezione la meraviglia non sia che un cumulo di macerie, sparisce non solo la meraviglia ma quel che ha avuto significato nella storia, dichiarandone la fine. Ognuno dei temi affonda nella distrazione coatta che inforca il suo contrario, la comprensione, rendendola inefficace.
Tutto per dire di quest’opera efficace, che vederla è altra cosa, che è una progressiva perdita di senso, un viaggio al centro del mondo per vedere qual è la consistenza della sua evoluzione, e magari capire se c’è un elemento che lega a questa anche la nostra. Ultima immagine è su sfondo scuro, luci basse, da vecchi vagano con un bastone per sorreggersi, cospargono di sale quello che è stato, nella vita e in questo spettacolo, sulla ferita che brucia, sulla storia che non rimargina».
Simone Nebbia, www.teatroecritica.net
Teatro Sotterraneo: l’umanità all’asta
«Cosa sarebbe successo se Adolf Hitler fosse morto da bambino? Se gli Incas avessero conquistato la Spagna e il Portogallo? Se l’11 settembre fosse stato il 12? Il gioco del “what if” innesca un processo di sviluppo esponenziale del recupero della storia e dei modi per cambiarla. Uno stratagemma geniale da proporre al pubblico per indurlo all’interazione: far accendere i cellulari per partecipare al gioco radiofonico tra il palco e la platea, mentre i due deejay in scena alternano la lettura dei messaggi alle versioni dall’Alleluja di Leonard Cohen, filo conduttore di tutto lo spettacolo. Come nel requiem che accompagna i condannati, intorno all’Alleluja vediamo tutto quello che c’è, e non ci sarà più. Il tono è lieve e ironico, ma l’apparenza informale e rapida racconta con ferocia l’autodistruzione della specie umana. I 5 episodi spiazzanti e diversissimi scorrono inesorabili sotto il timer rosso che segna l’ora esatta e il countdown, a partire da 60 minuti.
Prologo. L’attore chiede al pubblico cosa dovrebbe fare. Lo fa. Lo fa? Primo episodio. Finalmente un po’ di sangue! Making of di tafferugli e violenze delittuose tra 4 personaggi in tuta bianca su fondo bianco. Si picchiano e accoltellano quasi senza toccarsi, se il gesto non è credibile lo ripetono, le loro bombolette spruzzano rosso sangue, il telo alla fine sembra un art work di Pollock. Secondo. Gioco del “what if”. Irresistibile la sottile trasgressione di mandare sms a teatro, su invito degli attori. Siamo noi a dover scegliere se il bambino Adolf deve morire. Per alzata di mano. Terzo. Pictures of you. Con frenesia da turisti d’assalto, armati di macchinette usa e getta con flash, i quattro fotografano e si fotografano in ogni parte, atteggiamento, cosa, luce, buio, ginocchio, vittoria, pianto, abbraccio, reazione cutanea. Tra gli episodi c’è sempre qualcuno che ricapitola i fatti precedentemente accaduti, con fare oggettivo e puntuale, mentre gli altri prelevano gli oggetti di scena con sacchetti trasparenti. Prove a carico della fine della specie. Quarto. L’asta delle meraviglie del mondo. Con banditore inglese e brillante traduttore italiano, la piramide di Cheope e la muraglia cinese, il tempio di Efeso e Machu Picchu, il Taj Mahal e le Twin Towers, tutte all’incanto con prezzo di partenza. Da vendere a chi offre di meno. Restano polvere e cenere, se nessuno alza la voce. Perso il conto degli episodi, mancano 5 minuti e 60 secondi, stai solo pensando che potevi salvare il Colosseo.
In ogni momento dello spettacolo, ridendo dello stesso sorriso degli attori, lo spettatore è pervaso dall’inquietudine, assalito dalle domande, stimolato a formularne altre. Il meccanismo intimidatorio è subdolo e cordiale come la pubblicità, e la bravura del collettivo fiorentino sta proprio nel riproporre dei format d’intrattenimento instillando la possibilità dello slittamento, della libera scelta, della responsabilità. Un passaggio necessario verso un teatro che usa tutti gli strumenti della comunicazione per ricostruire un immaginario comune in superficie e suggerire un varco oltre questa realtà bidimensionale. Frutto del lavoro di accumulo e sedimentazione dei 5 componenti del Teatro Sotterraneo, che usano una modalità di creazione collettiva e non si vergognano a chiamare il loro lavoro “un prodotto”, il Dies Irae si insinua nel mercato teatrale italiano come una scheggia pericolosissima iniettata di senso critico. Il passato e il futuro restano schiacciati nei 60 minuti, è il pubblico che decide la fine della specie».
Fabiana Campanella, www.yorick.it
Cold and broken
«La fine del mondo è tutta da dimostrare. Se ti ammazzo, fammi vedere la traiettoria del tuo sangue. Se ti interrogo sul passato, spiegami “cosa sarebbe successo se”. Se ti estingui, lascia testimonianze di te: fotografa arti, pelle, occhi, a ricordare ai posteri com’era fatto il genere umano. E se ti sgretoli in polvere, come le sette meraviglie dell’antichità, prova a almeno a venderti: magari qualcosa la ricavi.
Dies Irae – cinque episodi intorno alla fine della specie, visto al Tam di Padova: “it’s a cold and it’s a broken hallelujah”, come cantano le parole di Leonard Cohen per tutto lo spettacolo. Siamo ridicolmente nudi di fronte a noi stessi e allo sfacelo che stiamo provocando? No. Siamo consapevoli delle alternative possibili attraversate e sfiorate dalla storia, e incredibilmente lasciate cadere? Nemmeno. Siamo scandalizzati? Irritati? Preoccupati? Coinvolti? Niente.
Siamo noncuranti. E perciò, della fine del mondo si può anche ridere. Dies Irae di Teatro Sotterraneo è uno sguardo lucido, distaccato e vivisezionato sul progressivo e inconsapevole allontanamento dell’uomo da se stesso. Cinque episodi, appunto, indipendenti tra di loro semanticamente ma necessari in sequenza all’individuazione del senso ultimo dello spettacolo, per tentare di registrare nitidamente, come fosse un verbale di assemblea, le voci di un’umanità che si sta sprecando.
Nitidamente: perché per mettere in scena “la banalità del male” non occorre commentarla, basta raccontarla così come sta. E si scoprirà che è tristemente ridicola. Alleluja, dunque: un canto liberatorio “cold”, non coinvolto, e “broken”, spezzato. Rotto: senza possibilità né volontà di rendenzione.
Teatro Sotterraneo vince l’Ubu quest’anno. Premio che, nella motivazione, ne segnala la grande capacità di innovare un linguaggio, quello della scena, personalizzandolo in maniera netta, caricandolo di nuovi codici di lettura e interpretazione. Ed è vero: perché chi non ha visto mai uno spettacolo di Daniele Villa, Sara Bonaventura, Iacopo Braca, Matteo Ceccarelli e Claudio Cirri esce dalla sala quantomeno spiazzato.
Ma non è solo questione di linguaggio. È il punto di vista sulla realtà a fare di Teatro Sotterraneo una delle espressioni più intelligenti del nuovo teatro. Un punto di vista che non è moralizzatore ma profondamente etico; non è accusatore ma schierato; non sorride, ma provoca la risata; non sceglie il dramma ma è dolente. E infine: non insegue la pesantezza, ma la ritrova sul fondo della lievità con cui prova a descrivere un mondo freddo e spezzato».
Marianna Sassano, www.nonsolocinema.com
«Non bisogna stupirsi se quando si chiede ad un pubblico di scegliere cosa vedere, chieda quasi sempre di danzare. Il movimento da l’illusione dell’esistenza del tempo. Un orologio domina la scena. 21:44 – 60:00. I numeri hanno la presunzione di sancire la posizione dell’uomo. Cosa sarebbe successo se Hitler fosse stato assassinato nella culla? Da lontano una canzone sussurra una smielata preghiera, mentre, senza trasporto, viene consumata la tortura di una donna inerme le cui grida arrivano alla nostra pelle. Aspetta, è solo una simulazione, una messa in scena. Il sangue è fittizio e il luogo, asettico; ricorda quasi le orwelliane celle che precedevano la stanza 101. “Abbiamo dato un nome alle cose per poterle ricordare quando mancano”; con razionale fretta ottimizzatrice, si cerca di fotografare, nominandoli, tutti i possibili lati di un’umanità che sta per scomparire, dalla carnale essenzialità di un corpo, alla dolcezza effimera di un abbraccio. Lo zero è arrivato. Nel buio si esaurisce la vecchiaia di tutte le epoche; forse per dare l’idea che il tempo, già stanco, si nasconda dietro ad una rumorosa pioggia di polvere. Comunicazione di servizio: Per chi volesse acquistarle, le 7 meraviglie del mondo, sono in vendita ad un’asta al ribasso.
La proposta scenica che la compagnia “teatro sotterraneo” porta in luce, emoziona e fa riflettere. Dal punto di vista tecnico Dies Irae _ 5 episodi intorno alla fine della specie risulta essere uno spettacolo davvero meritevole. Luci e scene sono essenziali ma molto efficaci. Gli attori sono validi (preparati anche dal punto di vista del movimento) e la direzione, pur nella volontà d’esser originale, è attenta e curata. L’ironia è utilizzata in giusta misura, lo spettacolo diverte, ma tiene sempre in se una visibile vena di profondità. Viene molto apprezzato l’uso di un meta-teatro che si trasforma in interattività. Giunge spontaneo chiedersi cosa sarebbe successo se qualcuno dei “chiamati” dall’elenco telefonico avesse risposto all’appello! Interessante infine la scelta di utilizzare una sola canzone (Halleluya di Jeff Bacley), una sorta di leit motiv spirituale, come “soundtrack dei 5 episodi”. Il giudizio è positivo; ci auguriamo che questa giovane compagnia continui a produrre lavori degni di un teatro di ricerca che con respiro, guarda, sempre più, al di fuori dei polverosi confini nazionali».
Gianpaolo Marcucci, www.teatridicartapesta.blogspot.com
«La fine della specie umana: una serie di fotografie che veloce scorre dinanzi agli occhi di tutti, a ritroso, cancellando, lasciando cadere ogni cosa per terra, dimenticando. Reperti, tracce da sistemare dentro un sacchetto di plastica, come indizi, dati investigativi che un giorno qualcuno studierà. È questa la fine del mondo per i giovani Teatro Sotterraneo che, con il loro spettacolo Dies Irae – 5 episodi intorno alla fine della specie, presentato nei suoi primi tre episodi durante il festival Drodesera 09, danno prova di maturità affermandosi come una delle realtà tra le più interessanti della scena teatrale italiana contemporanea. C’è innanzitutto una scrittura scenica fortissima, quella del dramaturg Daniele Villa, la cui bravura risalta nella commistione e rielaborazione di immagini, oggetti e simboli che tornano ripetutamente sulla scena acquisendo ogni volta nuovo senso; ma, soprattutto, in un sapiente capacità di padroneggiare il linguaggio del comico, del grottesco, dell’ironico e del tragico. Perché quello dei Teatro Sotterraneo è un sorriso sempre spietato, cattivo, marcio, crudele. Una risata che scoppia in bocche fameliche ma disturbate irrimediabilmente dalla morte (come già avveniva in Post-it) dal vuoto (come accadeva in La Cosa1), quindi dalla cancellazione definitiva dell’uomo dal pianeta Terra; fantasia o realtà alla quale tutti siamo indifferenti. E allora ecco le guerre, le violenze, le stragi… Nel primo episodio di Dies Irae i performer Sara Bonaventura, Iacopo Braca, Matteo Ceccarelli e Claudio Cirri, entrano in scena vestiti di bianco, con una tuta che ricorda quelle utilizzate durante le investigazioni dalla polizia scientifica. Nelle mani portano dei secchi di vernice rossa mentre alle loro spalle e per terra vengono srotolati dei pannelli di carta bianca. Su questi pannelli l’azione ha inizio: i performer si attaccano, si colpiscono, simulano omicidi, fucilate, violenze di vario tipo, possibili morti. Il rosso della vernice schizza feroce e rapido sulla carta, forma linee, gocce, pozze, macchie, un Pollok di sangue. Lungi dal raffreddare l’azione, l’artificiosità della scena, che inizialmente lascia il pubblico indifferente come se sottoposto a tante immagini di telegiornali, diviene presto motivo per ridere, passa rapidamente attraverso le atmosfere dello splatter tarantiniano, del grottesco, dell’ironico, del trash di certo horror giapponese o americano, quindi, sulle note di Hallelujah di Leonard Cohen cantata da Jeff Buckley sprofonda nel tragico. Solo attraverso il montaggio musicale l’immagine crudele e spietata ri-trova il suo significato, in un processo a ritroso, per cui dall’assuefazione e dall’indifferenza il pubblico, uomo tra gli uomini, è riportato alla sua spietata essenza, alla sua terribile e tragica natura pronta ad auto-annientarsi. Ma ecco che i performer tolgono le loro tute, pongono gli oggetti utilizzati in scena in sacchetti di plastica, quindi li lasciano a terra uscendo di scena. Il secondo episodio di Dies Irae si apre come una trasmissione radio in cui due speaker chiedono al pubblico di inviare degli sms domandandosi cosa sarebbe successo se un evento fosse/non fosse accaduto. É un gioco in cui il pubblico è chiamato a partecipare mentre riascolta le varie cover della canzone utilizzata nel primo episodio; ossia un rimasuglio, un riverbero dell’immagine tragica che ancora ogni spettatore si porta dentro gli occhi. “Cosa sarebbe successo se Hitler fosse stato ucciso nella sua culla?” si chiedono i performer. Ma la storia, la vita, non si fa con i “se”, e ancora una volta, gli unici elementi che potranno sopravvivere in scena saranno delle buste di cellofan, in cui ogni oggetto utilizzato dall’uomo può mostrare la sua stupidità. La stessa che sarà fotografata e ripresa nell’ultimo episodio di questo studio presentato a Drodesera 09: I performer in scena si alterneranno sul palco fotografando i loro movimenti, i loro corpi e chiamando ogni azione con il proprio nome. Un processo di accumulo di idee, segni e significati, un fotografare per cancellare, come si diceva all’inizio, per tornare indietro, abbandonare, dimenticare, mentre il conto alla rovescia verso l’estinzione dell’uomo, segnalato da alcuni timer in scena, si ferma e al pubblico non rimane che attendere la conclusione di questa interessantissimo progetto, già perfettamente messo a fuoco in questa tappa verso il finale debutto, il 14 e 15 Ottobre a Vie Scena Contemporanea Festival».
Matteo Antonaci, www.teatroteatro.it
Conto alla rovescia in attesa della fine di tutto
«In coproduzione Fies Factory One avendo residenza artistica a alla Centrale di Fies, la Compagnia del Teatro Sotterraneo si era già distinta nella precedente edizione del Festiva Drodesera, con sua creazione collettiva: Dies irae_5 episodi intorno alla fine della specie, replicata anche quest’anno a cui si è aggiunta anche L’origine delle specie. Va detto subito che i loro spettacoli sono tra i più belli visti in questa edizione 2010 dal titolo “Vivere trent’anni”. Colpisce ancora una volta il rigore e la “pulizia” di una messa in scena che si avvale di elementi scenici essenziali all’apparenza, ma capaci di trasformarsi nel corso dell’azione drammaturgica, in codici di lettura dove si svela, costruisce e si destruttura tutto, come se il corso degli eventi non possa avere una sua consequenzialità coerente. In realtà accade un’inversione/ribaltamento (e questo è uno degli elementi di forza) dei piani di realtà, in cui emerge la straordinaria capacità di rileggere, spesso in chiave simbolica, di ogni accadimento naturale e umano. Daniele Villa che firma il testo drammaturgico, opta per una costruzione scenica in cui l’esordio è dirompente come nel primo quadro, dove il bianco asettico della scena e dei costumi, così verosimili alle tute indossate dagli investigatori scientifici della polizia o dei fin troppo pubblicizzati Ris (vedi le varie fiction televisive spinte fino all’assurdo), è inondato da fiotti di sangue – vernice (utilizzata come mezzo scenico in ripetizione seriale), spargimento ossessivo e grottesco causato da una serie maniacale di atti lesivi pseudo -mortali, talmente improbabili da divenire sequenze esileranti e fumettistiche. Parlano di morte come un’azione ritualistica e esorcizzante. Il riferimento a certi format televisivi propinati a livelli tali da condurci all’assuefazione da overdose. Una serialità di gesti trash, in realtà voluti per creare un’iniziale spaesamento tra il pubblico. In successione l’azione si trasforma in sottile ironia sdrammatizzante – ma è qui che emerge la finalità ultima dell’autore/interpreti ( una delle tante chiavi di lettura proposte), che è quella di infondere il dubbio, l’interrogativo, la caduta delle certezze assolute. La violenza a cui assistiamo quotidianamente a cui ci siamo abituati, qui si rivolge a noi e ci punta il dito. Non ci si può sottrarre da un esame di coscienza collettivo. La crudeltà, il minimalismo, un certo cinismo gratuito, ti fa sentire spogliato delle proprie fragili sicurezze. L’effetto complessivo è straniante e la comicità svanisce per far posto ad un sentimento di angoscia esistenziale. Si passa poi ad un improbabile quiz radiofonico quanto cinicamente brutale. Il coinvolgimento del pubblico assume una connotazione ancor più improbabile per toccare tematiche inversamente reali e tragiche. Vedi la follia di Hitler e l’interrogativo: “Cosa sarebbe successo se il dittatore fosse morto da bambino?”. Si materializza la possibilità di sparare o lasciare in vita il bambino nella carrozzella su cui campeggia sinistra il nome Hitler. Uno dei momenti più riusciti della sintesi drammaturgica di questo lavoro. Imperdibile la sequenza in cui vengono bandite all’asta le meraviglie del mondo, passate e presenti, ridotte in cenere per mancanza di estimatori decisi all’acquisto. Passano i minuti scanditi da un display dove i numeri in rosso stanno indicare l’avvicinarsi della fine. E la cenere versata sul palcoscenico sta dirti che in fin dei conti l’uomo è destinato a quella fine. Buio totale e i bravissimi attori – performers, Sara Bonaventura, Iacopo Braca, Matteo Cecarelli, Claudio Cirri, riappaiono travestiti da vecchi claudicanti intenti a versare sale. Finale simbolico dove il Teatro Sotterraneo sta a dirci che difficilmente le loro – nostre ferite, difficilmente potranno rimarginare. Come dire la Storia non si può dimenticare. Uno spettacolo tradotto esemplarmente dall’autore che consente – tramite i bravissimi protagonisti – un’appropriazione personale a tutti coloro vogliano sondare la propria anima e lasciarsi condurre verso un viaggio interiore immaginifico».
Roberto Rinaldi, www.teatro.org
«Quasi escludendo a priori discorsi in presa diretta sulla realtà quotidiana, quella loro di giovani e artisti o del nostro mondo per tutti avaro di certezze e prospettive, quattro giovanissimi attori, quelli di Teatro Sotterraneo, affrontano con un’intuizione che spiazza e senza ideologismi dichiarati o moralismi a buon mercato nientemeno che il tema dell’apocalisse prossima ventura. […] Cinque episodi da esaurire in sessanta minuti scanditi nel conto alla rovescia di un orologio che domina la scena, in cui il tema viene affrontato con la leggerezza e l’ironia scanzonata, che non sono pressappochismo o superficialità, anzi, di uno spettacolo di varietà, con “numri” differenti l’uno dall’altro per genere espressivo e linguaggio scenico. […] Metafora apocalittica, questo Dies irae, ma anche stimolo a ripensare il rapporto con il tempo e con la memoria (che dicono quei sacchetti di plastica in cui vengono rinchiusi alcuni oggetti in ogni quadro, se non il bisogno di fissare una qualche traccia del nostro passaggio?), a rileggere la storia (c’è, a esempio e non a caso, un continuo richiamo a Hitler) forse per evitarne gli errori, ma soprattutto espressione assai ben riuscita di un desiderio di comunicare nell’immediatezza e nell’autenticità, fuori da schemi precostituiti o accademici. Una serata che è boccata d’aria fresca, che conforta e apre alla speranza. E di questi tempi non è davvero poco».
Mario Brandolin, Il Messaggero Veneto
«L’autodistruzione della specie, la fine del mondo, il ritorno al nulla. Per l’apocalisse (annunciata?) non servono proclami o appelli. Basta l’ironia, staccata dai fatti e paradossalmente comica, e il disastro incombente si mostra in tutta la sua gelida prospettiva. Da “Dies irae” grottesco, come titolano i lucidissimi giovani artisti […]. In 5 episodi gli attori non sviluppano un racconto progressivo né personaggi credibili, bensì mostrano i tasselli scollati di una realtà mediata, sostituita dalla sua riproduzione o da punti di vista inevitabilmente parziali. […] Il tono è leggero ma la sostanza è agghiacciante nel mostrare ciò che siamo diventati per la nostra rovina: uomini che, al posto del vivere reale, sono surrogati da finzioni, immagini e manipolazioni, e avviati a lasciare traccia di sé in pochi reperti per la futura archeologia di qualche alieno curioso».
Angela Felice, Il Gazzettino
«Con le prime tre tappe – presentate nel variegatissimo programma del festival Drodesera – del suo nuovo spettacolo, Dies irae, cinque episodi intorno alla fine della specie il Teatro Sotterraneo ha dimostrato, al di là di ogni altra considerazione, di essere uno dei giovani gruppi più dotati di personalità, e di un’innata capacità di rivolgersi a un pubblico che gli è vicino per anagrafe e sensibilità culturale. A colpire soprattutto, nelle costruzioni drammaturgiche di Daniele Villa e dei suoi compagni di lavoro, è la propensione, davvero insolita, a far coesistere una naturale vena ironica con la tendenza ad affrontare temi certamente non leggeri. Se in Post-it (recensione) l’argomento centrale, più o meno direttamente trattato, era la morte, e ne La cosa 1 (recensione) era l’imprendibilità della vita e l’illusione di riempirne il vuoto con un incessante movimento, questo progetto ancora in divenire è dedicato, come il titolo suggerisce, all’autodistruzione umana nelle sue innumerevoli varianti. L’impostazione è quella solita, lieve, svagata, improntata a un linguaggio scenico spoglio e apparentemente informale: in realtà, dietro il gioco dei loro atteggiamenti fintamente casuali, i quattro bravissimi attori dicono e fanno delle cose ferocissime, col sorriso sulle labbra e con una sostanziale perfidia di fondo.
Il primo “studio”, ad esempio, li mostra con addosso delle linde tute bianche dotate di cappuccio e visiera di plastica. L’abbigliamento asettico contrasta col carattere sanguinoso dell’azione: a turno, ciascuno mima situazioni di violenza e di morte, lanciando buffe grida di dolore, mentre gli altri spruzzano schizzi di liquido rosso sulla parete. La scissione tra l’azione e le sue conseguenze fisiologiche potrebbe attenuarne gli effetti: invece, paradossalmente, ne accentua la gelida efferatezza. L’aspetto più inquietante, in questo caso, è la cura con cui ogni capo, alla fine, viene chiuso in un sacchetto di cellophan, di quelli che si usano per i reperti giudiziari.
Nel secondo studio gli spettatori sono invitati a inviare degli sms in cui ci si interroga su quale piega avrebbe preso la storia se certi fatti si fossero o non si fossero verificati: se Hitler fosse stato ucciso in fasce, per dire, e altre ipotesi del genere. Il tono è scanzonato, quasi cabarettistico, ma la scena in cui si chiede alla platea di scegliere se sia il caso di sparare o no a un Adolf neonato è sottilmente crudele. Anche qui il registratore coi messaggi viene poi chiuso e sigillato, a futura memoria.
Il terzo episodio sembra il più distaccato, il più oggettivo, invece probabilmente è il più sinistro. Qui gli attori non fanno che fotografarsi a vicenda: fotografano gesti, sensazioni, parti anatomiche. Fotografano il buio e la luce. Con una nitidezza agghiacciante fissano, insomma, l’inafferrabile totalità della nostra esistenza, preparano ciò che resterà di noi per metterlo a disposizione di ignoti scienziati alieni che un giorno, forse, indagheranno su ciò che è accaduto alla Terra. E nell’ostentata spigliatezza con cui fanno tutto questo c’è un ambiguo sottofondo visionario, che rivela una raggiunta maturità espressiva».
Renato Palazzi, www.delteatro.it
«Dies irae o della ferocia dell’essere umano. Dies irae n° 1, andato in scena nell’ambito della rassegna Le vie dei festival, è il primo momento di un progetto diviso in 5 episodi, 5 spettacoli; a sé stanti, o, viceversa, fruibili come un politicco che si interroga sulla fine della specie. Della nostra specie, beninteso.
I 5 episodi sono affrontati con lo spirito che caratterizza ogni produzione di Teatro Sotterraneo il gruppo fiorentino che lavora insieme dal 2004, 4 giovani che provengono da ambiti culturali completamente diversi. Un approccio lieve, svagato, al quale corrisponde un linguaggio scenico spoglio e apparentemente informale che permette loro di costruire, in realtà, un discorso lucido e profondo sull’uomo (e la donna) e gli ambienti in cui interagisce, denunciando, tramite l’apparente leggiadria della messinscena, la perfidia e la ferocia che lo (ci) caratterizza.
L’episodio n° 1 vede quattro personaggi bardati con tute da lavoro ad alta protezione, dotate di cappuccio e con tanto di visiera di plastica, di un bianco immacolato, compresi guanti e stivali di gomma, a metà tra l’apocalittico e il post-atomico, con le quali, in uno spazio tappezzato da enormi fogli da disegno, sul pavimento e sulla parete di quinta, armeggiano con della tempera rossa diluita che spruzzano da dei contenitori macchiando pareti e pavimento e sporcando loro stessi. Mimano situazioni di violenza e di morte, per lasciare verosimili schizzi di vernice che riproducano schizzi di sangue. Dinanzi l’impassibilità del loro agire e all’alacrità con cui mimano azioni violente, che potrebbe essere quella di addetti agli effetti speciali di un film dell’orrore, così come di fronte all’evidente artificio scenico del sangue il pubblico (numerosissimo, che ha fatto registrare il tutto esaurito) ride dei gesti violenti (mimati e sostenuti onomatopeicamente dai quattro attori) e delle loro conseguenze (gli schizzi di sangue), ride di quello che sembra un approccio ludico e infantile alla violenza dove si mimano guerre e ci si sporca, concretamente. Ma mano però che l’effetto straniante si disperde nell’accumulo di una violenza che, senza perdere il suo aspetto astratto, si rivela sempre più nella sua concretezza (sventramenti, sgozzamenti, fino ad arrivare a vere e proprie torture e a amputazioni di arti il tutto mimato e ripetuto per riprodurre adeguati e corrispondenti schizzi di sangue-vernice), la leggerezza della rappresentazione perde ogni sua leggiadria e si esplicita in tutta la sua pesantezza simbolica: i quattro attori che si lordano e mimano uccisioni rappresentato il genere umano, una specie che uccide, mutila e sfrutta altri esseri umani. In sala non si sente più una risata. Lo spettacolo d’altronde non permette resistenze ilari: dopo un inizio nel quale gli unici suoni sono quelli onomatopeici fatti dagli attori con le proprie bocche, uno dei quattro attori si sfila la tuta lordata di sangue (rimessa a posto in asettici contenitori come quelli dei reperti di una squadra investigativa) e si mette a coordinare i gesti dei tre attori rimanenti, ora intenti a mimare sevizie e torture, indicando alla regia di alzare il volume di una musica di commento ogni volta che le urla della seviziata (impressionanti e vere) si fanno più forti. A questo disturbo sonoro contribuisce anche un allarme lasciato suonare al momento opportuno mentre la musica raggiunge un volume assordante fino al climax nel quale la performance finisce, e la scena rimane vuota lordata di sangue e in silenzio: un monumento all’indifferenza di noi spettatori, peggio, uno specchio che rimanda al pubblico l’immagine di sé, intento a divertirsi di fronte alla violenza, a teatro come nella vita reale. E da teatro si esce con molta meno voglia di ridere…».
Alessandro Paesano, www.teatro.org
LA COSA 1
Renato Palazzi, delteatro.it
Non è un paese per giovani.
«Quando invece il problema è la messa in discussione della stessa rappresentazione, questa avviene solitamente attraverso l’utilizzo di un procedimento: una feroce ironia. Ogni oggetto, ogni gesto, ogni azione perde di senso o, almeno, il senso slitta continuamente. Non pochi gruppi iniziano dichiarando di non avere nulla da dire, iniziano confrontandosi con un’idea di fine declinata poi su sentimenti e identità e, soprattutto, sul teatro stesso. Il linguaggio della dissoluzione, coniato da Kinkaleri negli ultimi anni, viene così recuperato almeno come orizzonte, come aria respirata, anche se cambiato sostanzialmente di segno. Quello che importa è il procedimento di montaggio e smontaggio della scena che viene portato avanti ad esempio da Teatro Sotterraneo (Firenze) e Cosmesi (Bologna). Sono percorsi questi che intraprendono una strada estremamente difficile perché fin da subito si posizionano su un limite: una disperazione ai limiti del tic e della nevrosi, un’ironia che può cedere al cinismo, un gioco che quando perde di carica utopica si fa scherzo. In questo caso la rappresentazione è negata ma è l’oggetto con cui fare i conti, e il coraggio risiede proprio nello sporcarsi le mani con le cose del mondo, nel provare a ritrovare un’intelligente comunicatività con il pubblico, anche utilizzando un immaginario quotidiano certo da criticare, ma non da rimuovere. In La Cosa 1 di Teatro Sotterraneo si parla proprio della condizione dei giovani e di una crescita assurda. Si tratta di uno spettacolo tutto in movimento, perché i quattro ragazzi sulla scena, come alle prese con una gara senza traguardo e senza meta, corrono come matti nella perenne ambiguità che si tratti di una fuga o di un arrivo, di un gesto volontario o eterodiretto».
Rodolfo Sacchettini, Lo Straniero
Il gioco della corsa.
«Nel tentativo di non considerare lo spettatore un occhio passivo da persuadere a tutti i costi, abbandonando le logiche didascaliche di una comunicazione immediata, Teatro Sotterraneo si sporca le mani con immagini e riferimenti rubati ai mass media. La Cosa 1, il cui titolo si presenta già come un indovinello, è l’esplosione di questi materiali, l’accumulo ostinato di slogan e scene di possibili telefilm e telenovele. Dichiarazioni d’amore sulla panchina, un party privato in campeggio sulle note di Cacao Meravigliao, una partita a nascondino e le apparizioni di un enorme tricheco di peluche. Il discorso che lo spettacolo sottende è un percorso di crescita, la maturazione che porta alla consapevolezza del terreno nel quale si cammina, e si corre. La corsa è infatti la cornice dello spettacolo, o piuttosto la vera performance. In divise da corridori firmate Nike, scarpe comprese, gli attori inaugurano lo spettacolo cantando a cappella un pezzo dei Carmina Burana, e poi cominciano a correre. Si lanciano in tutti gli spazi della Stazione Leopolda di Firenze, dove La Cosa 1 ha debuttato, per raggiungere un traguardo invisibile e mai definitivo. La corsa non si interrompe, e le scene sono sempre disturbate da uno o più attori che si lanciano a gran velocità accanto agli altri. Nei pochi momenti in cui gli atleti sostano ai lati della scena asciugandosi il sudore, si avverte lo scarto, forse ancora da precisare, quello di una realtà esterna che emerge in tutta la sua forza e pesantezza. Quegli attori faticano davvero. Teatro Sotterraneo ci indica con astuta leggerezza la regola del gioco alla quale sottostiamo, l’urgenza di fare e strafare, arrivare per poi scappare via e non potersi godere che una breve sosta. Lo spettacolo si conclude con un coro da stadio posticcio, che alle grida di “Sotterraneo! Sotterraneo!” ci chiama direttamente in causa, ribaltando il senso dei nostri applausi».
Serena Terranova, Hystrio
«Teatro Sotterraneo è un collettivo senza leader e gerarchie, non c’è un regista e tutti collaborano alle varie fasi di creazione, è un gruppo che si è imposto per una visione personale ed originale del momento artistico. Il ritmo incalzante e la tagliente ironia caratterizzano i loro spettacoli, successione di brevi scene cariche di rimandi al quotidiano, di elementi di una cultura pop che invade le nostre vite, di nevrosi che la caratterizza. La presentazione di ogni elemento subisce un continuo slittamento di significato nella successione delle azioni sceniche, che sotto l’ironia nascondono forte drammaticità e cinismo. Nell’ultimo spettacolo, La Cosa 1, si è trascinati da una corsa continua e senza sosta dei performer in scena, che attraversa un frenetico montaggio di momenti di vita quotidiana caratterizzanti l’adolescenza, in cui tutti si riconoscono. Le tentennanti dichiarazioni d’amore, i party privati, i qui, il nascondino, le musiche televisive, e l’apparizione di un enorme peluche: tutto appare o scompare nella corsa verso la fase successiva, si accavalla nel ricordo che in un attimo svanisce lasciando un po’ d’amarezza, e si affaccia per un secondo una domanda “Se potessi tornare indietro faresti le stesse cose?” Ma non c’è tempo per rispondere, si deve continuare a correre».
Ilaria Mancia, Mucchio – Il mucchio selvaggio
«Dino Sommadossi e Barbara Boninsegna hanno chiarito subito le forme e le poetiche che hanno pervaso gli spettacoli visti per dieci giorni nella Centrale di Fies nella scelta dei gruppi che formeranno la Factory, ossia una vera famiglia teatrale che avrà Fies come casa: Sonia Brunelli, Dewey Dell, Francesca Grilli, Pathosformel, Teatro Sotterraneo. E iniziamo la nostra analisi del Festival proprio da quest’ultimo gruppo di cui avevamo apprezzato a suo tempo Post-it come frutto già maturo di un percorso preciso. E La Cosa 1 con l’elaborazione drammaturgica di Daniele Villa ed in scena Iacopo Braca, Sara Bonaventura, Matteo Ceccarelli, Claudio Cirri, ci pare confermarlo, qui lo spazio scenico è attraversato da corpi che corrono letteralmente a perdi fiato, persone che non riescono più a comunicare tra loro, le parole sono banali, smozzicate, sconosciute o tutt’al più sono coperte dal rumore dei passi che rimbombano sulla scena. Sono persone comuni i nostri protagonisti ma non possono esserlo, come atleti acclamati dalla folla hanno bisogno solo di apparire vincenti, i sentimenti sono nascosti, non c’è tempo per quelli, l’importante è correre per arrivare primi, ma è una corsa che sfocia nel nulla. La corsa è interrotta, come è già stile del Sotterraneo, da brevi siparietti, venati costantemente da ironia dove ci sta pure una grande foca di peluche, si ride parecchio per non piangere, per altro senza sottolineature di senso».
Mario Bianchi, eolo-ragazzi.it
«Convincono in pieno anche Made in Italy e La Cosa 1 del Teatro Sotterraneo. Entrambi i gruppi ricordano quanto la sperimentazione teatrale non debba essere sempre seria e astrusa, ma quanto possa passare anche attraverso la comicità […]. Teatro Sotterraneo, invece, costruisce uno spettacolo sfidando il limite della stanchezza fisica. Per tutta la durata di La Cosa 1, il gruppo fiorentino, con addosso delle tutine da jogging, corre incessantemente, fermandosi solo per dare vita a deliranti sketch (un party privato in una mini-tenda, una dichiarazione di amore e odio in giapponese, l’irruzione di un enorme pupazzo di peluche)».
Mauro Petruzziello, xl.repubblica.it
Il mondo è pazzo? Non ci resta che ridere! La filosofia del Sotterraneo di Firenze. «Impazzisci, e poi stupisci!», sghignazzava il Joker dalle pagine di Batman: The Killing Joke , uno dei capolavori della letteratura a fumetti nato dal genio del vate Alan Moore. La nemesi per antonomasia del Dark Knight la sapeva lunga su ciò che ci separa dalla “normalità” e dalla follia: un maledetto giorno sbagliato. Per chi sa vedere, quel giorno si ripete ogni mattina. E per chi è insanamente sano di mente non si può far altro che riderne per comprendere.
Il Teatro Sotterraneo – made in Firenze – lo fa, e anche molto bene. In un teatro che spesso si dimentica di intrattenere, e anche divertendo(si), il giovane collettivo di ricerca teatrale nato nel 2004 riesce nell’impresa dell’autoironia. […] Non esistono intellettualismi a comprimerli in risacche di anidride carbonica, ma l’ossigeno dell’autoironia, il non prendersi mai troppo sul serio, in una satira che non perde di vista il dono prezioso dell’intelligenza. Quattro performer e un dramaturg, insieme in una ricerca comune, che dopo le annotazioni contenute in Post-it sull’umano vivere, ci regalano ora cartoline dall’Inferno della dimensione domestica e del mondo che ci attende fuori l’uscio di casa. Due produzioni parallele, ma complementari: Eko, in attesa di trasformarsi in Suite a Prato (nella rassegna Contemporanea ’08 dal 28 maggio al 2 giugno), e La Cosa 1 che, dopo essere stata a Roma a Uovo Critico, sarà in un primo studio al Festival Inequilibrio esploso a Castiglioncello (19 aprile), e in prima nazionale al Festival Fabbrica Europa (Firenze, 20-21 maggio). […] La Cosa 1 pone l’uomo di fronte alle sue corse disperate all’inseguimento di non si sa più cosa. Sulla scena in un continuo e disperatamente comico movimento, gli attori vivono di iperattività, di serialità, del fare in continuazione qualcosa, raggiungendo il limite della resistenza. L’uomo, separatosi dalle labili sicurezze della dimensione casalinga, cade vittima della società che ha costruito. Ma per fortuna, guardando l’abisso, ci è concessa una sana risata».
Giacomo D’Alelio, Queer
«Quattro atleti, fermi sulla scena. Hanno addosso scarpe da corsa e tessuti hi tech da androidi sportivi per la traspirazione, la sudorazione, il movimento libero. Sono pronti ad affrontare la vita. Tra fasi di riscaldamento e di ripresa, di scatto e di resistenza, La Cosa 1, proposto dal Teatro Sotterraneo al teatro Tam Maddalene di Padova, è un vortice di velocità. Tutto esplode dopo un’emozionate esecuzione dal vivo dell’O fortuna, dai Carmina Burana. Un’invocazione, si prepara il terreno al pubblico: sta per precipitare la quiete, inizia la giostra. Sembra un vero e proprio allenamento fisico questo spettacolo intenso e impattante, in cui Iacopo Braca, Sara Bonaventura, Matteo Ceccarelli e Claudio Cirri, soprattutto, corrono. Usando lo spazio nella sua interezza, in un random di frenesia che non trova pace se non nei pochi momenti di dialogo, tra di loro, o con il pubblico. Momenti in cui si scopre il significato di un titolo tanto enigmatico: La Cosa 1 è l’amore. Amore che sfugge, in cui in realtà si riesce a dire poco e nulla: Sara-ti-amo-ma-con-questo-avrei-finito-non-ho-nulla-da-aggiungere; amore che vive di fugaci contatti, una carezza sulla mano e poi via, di corsa, di nuovo scattare correre sudare. Amori che non si capiscono, i due amanti possono anche parlare due lingue diverse, non occorre il dialogo. Amori superficiali, a cui non si lascia il tempo di sbocciare. Amori da festa in discoteca, e sulla scena appare improvvisamente una casetta con la scritta “party privato”. Ma è una casetta da campeggio: pure quella, provvisoria. E così come gli amori, anche le altre relazioni umane: per conoscersi si compila un questionario, bastano dieci domande preconfezionate. Per avere un contatto, basta un cinque scambiato durante la corsa. Per costruire un rapporto d’odio, basta chiedere al pubblico quante sberle dare, da uno a dieci. Nove? E nove ne piovono. Per un rapporto d’affetto, l’equivalente sono i baci. E quando compare sulla scena un enorme pupazzone blu, ironico e inquietante, nessuno si stupisce: il suo straniamento, la sua goffaggine, la sua inappropriatezza sono dentro al fiume in piena che scorre, esattamente come le vite di mille uomini. Nessuno ha nulla da dirsi, in questo scenario da pallina da flipper, perché nessuno riesce a farlo. Nemmeno l’acuto di Pavarotti riesce a concludere il suo vincerò, che rimane sospeso a mezz’aria su una e prolungata: è un’attesa infinita, non c’è una concretizzazione finale. La Cosa 1 contiene l’amore, e contiene la fretta. E contiene anche l’accelerazione: come un trailer frenetico al fast forward, in cui scorre tutta la vita compattata e asciugata, dove la corsa fa da risposta al monito del Nessun Dorma. E se il tema dello spettacolo non risulta particolarmente innovativo, assolutamente innovative e riuscite sono la messa in scena, la regia, la drammaturgia. Una drammaturgia, curata da Daniele Villa, basata sul non detto, che studia in modo particolare cosa non far dire, e cosa invece far agire. La Cosa 1 non è didascalico o verboso, e forse non è nemmeno una denuncia. È una fotografia, un’istantanea del presente: come quelle che gli attori – performer scattano al pubblico, mentre corrono. La Cosa 1 è pure straniante e divertente, leggero e tagliente. Uno spettacolo interessante, chiaramente distinto dal panorama contemporaneo teatrale, che continua con una potenza notevole il percorso che Teatro Sotterraneo, vincitore del bando ETI Nuove creatività nel 2008, ha iniziato con Post-it e Suite».
Marianna Sassano, nonsolocinema.it
L’anteprima del nuovo spettacolo di Teatro Sotterraneo al Castello Pasquini. «Càpita andando in giro per teatri di imbattersi in coincidenze, di osservare delle linee che si intersecano all’insaputa di chi le ha tracciate. Sarà l’aria del tempo, lo Zeitgeist che si diverte perché, obbiettivamente, il coincidere contiene spesso un elemento di comicità, di bizzarria. Nulla in apparenza accomuna due maestri della ricerca italiana quali Rem e Cap e un gruppo giovane come il Teatro Sotterraneo, quattro performer e un dramaturg che a stento raggiungono tutti insieme i cent’anni di età. Remondi e Caporossi qualche settimana fa hanno proposto nel quadro di un laboratorio teatrale un allestimento tratto da un testo di Beckett poco noto e ancor meno citato, Assez (Basta). I quattro attori hanno presentato l’altra sera al Castello Pasquini di Castiglioncello per il festival Inequilibrio esploso/Armunia Costa degli Etruschi uno studio su un loro progetto intitolato La Cosa 1. In comune i due spettacoli hanno che sono praticamente senza parole. Di conseguenza, il secondo aspetto che li avvicina è la loro natura prettamente femminile, intendendo per maschile un teatro drammaturgicamente strutturato, affermativo, argomentativo, fondato sul verbo in quanto strumento principe di esposizione del ragionamento logico-razionale e del rapporto causa-conseguenza. I due allestimenti invece lavorano su concatenazioni concettuali analogiche funzionanti su principi di somiglianza, riconoscimento, identità. Altrettanto organizzata se non addirittura maggiormente rigorosa rispetto alla drammaturgia scritta è la rappresentazione dei processi intuitivi. Sono stati scritti in questi ultimi trent’anni vari fiumi d’inchiostro sulla differenza fra scrittura scenica e scrittura drammaturgica e poi qualche cascata di parole sul ritorno negli anni Novanta della drammaturgia a teatro. Fatto sta che, a livelli diversi – più comico e leggero il Teatro Sotterraneo, filosofico nel caso di Rem e Cap – la questione della ricerca formale di una scena che superi il linguaggio continua a porsi. È interessante allora vedere che la compagnia giovane e i due Maestri stanno sulla stessa strada. E in fondo proprio di strada si tratta: in Basta sette coppie beckettiane – giacca, pantaloni e cappello scuri da uomo – camminano da destra a sinistra, senza sosta, una dopo l’altra, su un tappeto di sabbia lungo una ventina di metri; nella Cosa 1 i quattro performer raccontano storie di incontri correndo a perdifiato sulla scena e sbattendo l’uno contro l’altro. Non si ha idea di quante cose si possono fare in corsa, persino la corte alle ragazze, persino una critica alla società attuale, una presa in giro della nostra way of life. Correre e camminare come metafore. I due spettacoli rifiutano lo stesso principio di riduzione della scena a una rappresentazione in scala della vita, operazione per platee necessitose di immagini facili, naturalistiche, subito comprensibili. Rigettato è il teatro come forma di voyeurismo, il teatro borghese adatto allo spettatore che si contenta di riproduzioni del mondo materiale, della realtà così com’è, non trascesa, non elevata su un piano metaforico. Abitudine mentale cristallizzata dalla televisione, dai reality, dalle fiction e utile alla trasformazione dello spettatore in un guardone, ergo in cittadino manipolabile attraverso lo strumento del desiderio. L’orrore per questa esperienza grossolana del mondo che allontana dalle dimensioni metaforiche e spirituali, il dispiacere per i progressi dell’ortodossia e del conformismo, il fastidio per la granitica omogeneità del comune sentire, avvicinano il Teatro Sotterraneo alla alta filosofia teatralizzata di Remondi e Caporossi. E producono un’insofferenza giustificata verso il naturalismo. Poi però, càpita di rivedere di notte, per insonnia, su una vecchia videocassetta, Apocalypse now e di rammentare che le cose, in fatto d’arte, sono sempre più complesse di un istante prima».
Marcantonio Lucidi, ladifferenza.org
«Firenze – Tra uno schiaffo ed una carezza. Una manata fresca che arriva sotterranea. Un qualcosa di talmente vero e quotidiano, lo scarto dal drammatico che sboccia nel consueto, che pare di fumetto, di cartoon. Ed infatti i Fantastici 4, (ci vuole un fisico bestiale) dopo aver nominato la piece “La Cosa 1” (che da immobile nelle strisce qui diventa per contrappasso una corsa infinita tra quattro cantoni e nascondino), hanno tute attillate da runner. Jumper nelle banlieue, ciclisti di fondo per il record dell’ora, a scardinare i ritmi, nelle loro mute da sub, respirando tra le branchie dell’intelligente testo di stretching emotivo, di assonanze, anche autocelebrative, di occhiolini ad un certo caustico e raffinato salto mentale. Come la poesia, che dice dicendo altro, che arriva non parlando dell’oggetto, ma del contesto. Giungendo più forte e più pungente. Ma non sono supereroi: hanno fiatone ed ansie. Hanno bisogno, con il pubblico lì davanti, di portarselo un altro in tasca, in cassetta, più malleabile e convinto. Hanno storie di drammi familiari alle spalle ma nessuno se ne cura, anzi se ne ride (non potremmo fare altrimenti). Intavolano gag, deliziose e deliranti, con quel sapore di banalità nelle quali ci ritroviamo ma alle quali non sappiamo dare contributi e risposte. Le lasciamo scorrere, come olio sulla pelle. I Sotterraneo ce le piazzano davanti, ti aprono le pupille con uno stuzzicadenti e ti fanno vedere: la panchina (niente amanti di Peynet, grazie) dove cominciano gli amori incerti adolescenziali e sulla quale nessuno si può permettere, ma tutti la vorrebbero, la colonna sonora di “Ghost”, un party finto divertimentificio, escluso ma non esclusivo, di una festa tragica e triste di plastica. Un amore con la A maiuscola, travestito da goffa foca inseguitrice stile Pac Man, medley nazional popolare dell’ugola sanremese. Geniali».
Tommaso Chimenti, scanner.it e Il Corriere di Firenze
«È il festival delle promesse mantenute. Dove accade che i piccoli, come recita il manifesto di quest’anno, abbandonata l’arroganza dell’adolescenza, siano in grado di consegnare al pubblico piccole opere incisive, ricerche estreme sul movimento e indagini sulla quotidianità del sentire […]. La danza, come linguaggio e allenamento quotidiano che sanno plasmare i corpi e farli gioire, balbettare, soffrire, è l’anello mancante di un altro lavoro molto interessante presentato a Dro in forma ormai matura: La Cosa 1, creazione collettiva di Teatro Sotterraneo in coproduzione con Fies Factory One, è uno spettacolo filosoficamente importante, perché utilizza, senza citarli esplicitamente, tutti gli elementi costitutivi del tanztheater nella sua espressione più alta, quella elaborata a suo tempo nei grandi affreschi di Pina Bausch: entrate, uscite, incontri, improvvisazioni, corse, ripetizioni, prese, abbandoni, rivelazioni autoironiche e autobiografiche, grandi silenzi e sospensioni. Tutto tranne lo specifico della danza […]. Magistrale l’inizio, con i Carmina Burana destrutturati, in forma di mottetto. E il sotto finale, con un countdown che ci regala il beneficio del dubbio e un paio di tempi supplementari».
Paolo Crespi, Il Gazzettino
«Dro – non tutte le ciambelle riescono col buco, ricorda scherzosamente il motto di Fies Factory One. Ma queste anomale “ciambelle” teatrali, contese sulla piazza dei festival estivi, hanno già ripagato le aspettative. […] Altre esperienze estetiche e creative hanno trovato spazio negli impasti ironici di Teatro Sotterraneo, in scena lunedì sera con il ready-made rettificato di «La Cosa 1». Un film cult in bilico fra horror e fantascienza girato nel 1982 da John Carpenter. Un documentario di Nanni Moretti sul dibattito aperto dalla «svolta della Bolognina». Un supereroe della Marvel per la milizia dei Fantastici Quattro. Sono solo alcuni dei possibili referenti centrifugati in un titolo che definisce l’indefinibile e lo assoggetta all’imperio del sequel. Tutta l’attività della compagnia fiorentina, del resto, ricicla i miti e i prodotti della società mediatica in quadri graffianti che incrociano l’atletismo del teatro di movimento. Qui l’oggetto è di fatto la vita, ridotto al suo minimo comune denominatore attraverso un irresistibile montaggio di fatti biografici e collettivi. Creazione di una formazione orizzontale, senza leader e gerarchie, «La Cosa 1» raccoglie sotto l’invocazione alla Fortuna, rubata alla galleria di destini dei Carmina Burana, un nuovo autoritratto soggettivo e «epocale» che si rimangia fiumi d’inchiostro sulla «crisi dei giovani» con la sua capacità rinfrescante e politicamente scorretta di portarli in scena».
Katia Malatesta, L’Adige
«La conferma si chiama “Teatro Sotterraneo”. Già molto applauditi l’hanno scorso con “Post-it”, hanno ribadito lunedì la sostanza e la freschezza di un teatro fatto soprattutto di ironia e senso dell’assurdo, che il gruppo di quattro giovani attori-autori toscani riesce ad esprimere coraggiosamente, mescolando luogo comune e paradosso. “La Cosa 1” è uno spettacolo giocato al ritmo frenetico di una quotidianità di vita che resta centrale nella ricerca del gruppo. Che sceglie l’apprezzabile via del contatto diretto col pubblico per ironizzare sull’incapacità, tutta contemporanea, di una super-comunicazione non comunicante. Di una precarietà progressiva che scompone l’individuo in una molteplicità di non-stare semplicemente impossibilitati a fermarsi. Anche, e soprattutto, di fronte all’amore».
Tommaso Pasquini, Il Trentino
«Una staffetta corsa in Centrale, senza pause di ristoro, da gustare tutta d’un fiato. Saltando di palo in frasca sulla scena, con un altro fresco amarcord dell’assurdo e molta arte di arrangiarsi, i Teatro Sotterraneo, anche quest’anno sono riusciti a distinguersi tra le proposte del festival internazionale di Drodesera Fies con La cosa 1, in scena lo scorso 28 luglio 2008».
Miriam Monteleone, teatroteatro.it
«Tra le rappresentazioni in dialogo fra loro, su tutte spicca la trascinante performance di “Teatro Sotterraneo”, che a 4 anni dagli esordi porta in scena un nuovo, delirante spettacolo: “La Cosa 1”, debutto di questa estate con ottimi riscontri dalla platea. […] Fiori all’occhiello del teatro giovanile di ricerca, i “Sotterraneo” si incontrano professionalmente nel 2004, debuttando nel settembre con la messa in scena dell’inquietante “11/10 in apnea”, che guadagna la partecipazione al Premio Scenario 2005. Poi corre – e veloce – questo gruppo, nella vita professionale come sulla scena della loro “cosa”. LO SPETTACOLO – “La Cosa 1”, originale creazione nata dal consueto studio corale, altro non è che un’efficace metafora sottesa di questo frenetico nostro contemporaneo. È l’isterica e angosciata corsa dei tempi in cui viviamo, dove non conta più tanto l’obiettivo quanto lo stare in ballo. Quattro attori in tuta sportiva che corrono incessantemente lungo tutto lo spazio e il tempo della messa in scena, che rappresentano noi e loro stessi insieme, accomunati da una ricerca affannata in cui la meta sfuma, arretra, cede il passo a una corsa che si nutre di se stessa. La “cosa” è l’esplosione del luogo comune portato all’eccesso ma non reso mera parodia di sé. Perché la rappresentazione – a tratti esilarante – è più sottile. Di spazio per ridere nello spettacolo ce n’è in abbondanza, ma l’accorto insieme risulterà tutto fuorché didascalico. Abbandonando regole e forme della comunicazione tradizionale, lo spettacolo tiene in considerazione il pubblico senza urlargli in faccia “Verità Assolute”, con dialoghi ridotti al minimo e costantemente frammentati. Uomini e donne che si muovono per muoversi, metafora del contemporaneo quotidiano che vuole i suoi protagonisti calati in uno spasmodico iperattivismo, che nel correre dimenticano pure perché stanno correndo, ma che nutrono il moto perpetuo purché niente lasci loro il tempo di sostare. Fra sketch sempre in bilico fra luogo comune e paradosso – dalla dichiarazione d’amore fumettistica fino alla comparsa di un enorme tricheco di pezza, stordito da test psicoattitudinali che ricalcano il quotidiano lavorativo di un’intera generazione – la “cosa” è lo stretto confine che separa la forzatura ilare dal baratro della realtà, che colpisce con l’urto di una risata necessaria, ma nasconde una verità di cui tutti siamo protagonisti, più o meno volontari. Uno spettacolo ben orchestrato che lascia lo spettatore divertito ma consapevole giusto un istante troppo tardi: quando il sipario è chiuso e resta lo spazio della riflessione. L’epilogo paradigmatico del dubbio che s’insinua nell’osservare la faticosa corsa dei nostri, e nel temere che a questo, in fondo, sia ridotta la nostra (sola) esistenza».
Cecilia Dalla Negra, fondazioneitaliani.it
«Il collettivo di ricerca teatrale Teatro Sotterraneo, composto da Iacopo Braca, Sara Bonaventura, Matteo Ceccarelli e Claudio Cirri, porta in scena all’interno del festival Short Theatre, al Teatro India, lo spettacolo La Cosa 1, instancabile e forsennato lavoro basato sul movimento, sul fisico (più che sul corpo) e sul fiato. Quattro “performer” si muovono sul grande palco della sala B-bis; corrono, sempre. La loro corsa continua e apparentemente senza significato, giacché ogni progressione è fermata poi dall’ostacolo oggettivo delle mura, si configura come “sforzo estremo”, slancio, il … raggiungere, fino allo sfinimento (reale, non recitato!). Il fiatone a volte li vince e li arresta, qualcuno si accascia, uno si appoggia alle ginocchia per riprendere fiato, un altro cade a terra sfinito; ma ecco la furia di uno dei compagni che lo prende per mano, lo scuote dalle spalle e lo sprona a ricominciare la corsa, furiosa. Furor. Una celata propensione “donchisciottesca” anima il quartetto inarrestabile che non conosce vincoli, è cieco e non si domanda, ma corre semplicemente. Sine ratio. Una performance che potrebbe essere avvicinata alle istanze della Body Art, ad uno primo sguardo. Niente di più lontano. Non è la ricerca del corpo sul corpo che emerge, né il corpo è proposto come l’istanza significante dello spettacolo; è piuttosto “l’atletismo” a padroneggiare la scena, come dimostrano i costumi indossati dagli attori: tute da ginnastica, maglie elastiche di quelle che aderiscono al corpo e permettono la massima mobilità, scarpe antiscivolo e ginocchiere. Viene negata qualunque esaltazione del corpo, nascosti i rilievi dei muscoli, è così che tramonta l’estetica della fisicità in favore della celebrazione del prodotto di quella fisicità: l’azione, il movimento, lo sforzo. Streben. “Ha inizio il movimento, qualsiasi movimento – citando i Sotterraneo – tutto purché qualcuno faccia qualcosa, una messa alla prova continua di muscoli e nervi – dunque non la loro esibizione – un corpo precario che dà tutto anche quando non né ha più (…) una presentazione d’iperattività che va dalla culla all’apocalisse”. Si potrebbe intendere La cosa 1 come una visione della vita, non singolare ma universale, come il tentativo di definire il passaggio dell’uomo sulla Terra. La stasi è la morte, ecco dove torna Don Chisciotte, il movimento è vita. Diventa superfluo anche dichiarare un “perché”, ciò che conta è il moto insaziabile fino al limite delle possibilità umane. Hybris. Tutta questa energia cinetica prodotta per la scena è contaminata da vari e deliziosi momenti di puro teatro, nei quali il gruppo toscano ci parla, tra autobiografia e invenzione, della vita (stavolta particolare) di ognuno dei componenti: fra Carmina Burana cantati “a cappella”, una festa improvvisata all’interno di una piccola tenda, un pupazzo-tricheco che goffamente si aggira per la scena, trovano spazio momenti più rilassati in cui i tre uomini corteggiano l’unica donna, sfidandosi con grande intelligenza drammaturgia (merito di Daniele Villa) a suon di letterine piene di errori, esternazioni appassionate in giapponese e gaffe varie. Tutti passaggi densi di significati e di rimandi, pure riflessioni sullo scorrere della vita, innocenti domande e serene risposte sull’amore. Sono momenti di calma in cui al pensiero è permesso di entrare in scena, giocare con le parole e col pubblico, innescare un ragionamento nella testa dello spettatore, frastornato da tutto il movimento tangenziale (indicativo il passaggio in cui Matteo domanda ad una signora del pubblico “un numero da uno a dieci” – “sei” risponde la spettatrice, ignara del fatto che quel numero corrisponderà ai sonori schiaffoni che Iacopo rivolgerà al compagno). Chiude lo spettacolo il buffo tricheco blu, goffo, inabile, muto, asettico. Un’icona che si oppone fortemente al turbo che ha dominato la scena finora, e alla quale un po’ tutti assomigliamo».
Filippo Ferraresi, close-up.it
«Corrono senza tregua i quattro giovani attori del Teatro Sotterraneo, con le loro tute da ginnastica e i muscoli bene in vista. Lo Spettacolo «La Cosa 1» […] vuole essere una «presentazione d’iperattività», un movimento continuo «alla ricerca di condizioni limite». Di tanto in tanto gli attori si fermano, senza fiato, e iniziano a cantare o a parlare. Raccontano storie surreali, tragiche, ma sempre con leggerezza e ironia. Come quella di un bambino ritrovato in un cassonetto e abbandonato pochi metri più avanti. Vediamo poi un coloratissimo tricheco, che irrompe in scena e viene subito intervistato da un distaccato giovane. E assistiamo a un intrecciarsi di storie d’amore intorno a una panchina, dove i tre ragazzi pronunciano, uno dopo l’altro, la loro dichiarazione d’amore alla stessa impassibile ragazza (Sara Bonaventura). Il lavoro risulta dunque interessante, e particolarmente originale la drammaturgia curata da Daniele Villa». Gherardo Vitali Rosati da “Il corriere della sera – Corriere fiorentino”, 24 maggio 2008
«Sono già sul boccascena, sono in quattro e indossano tute da ginnastica high-tech. Sono una via di mezzo fra sportivi e supereroi. Il pubblico entra in sala e prende posto. ‘Loro’ vanno via uscendo dalla scena ma lasciando i microfoni accesi. Inizia così “La Cosa 1”, spettacolo della compagnia fiorentina Teatro Sotterraneo, co-prodotto da Fies Factory One, l’interessante esperimento produttivo e di residenza promosso dal festival Drodesera Centrale Fies di Dro. Si capisce da subito che non assisteremo alla messa in scena di uno spettacolo eccessivamente concettuale o cerebrale: con le armi dell’ironia, dell’interazione col pubblico, dell’autocelebrazione, proponendo scene semplici ma ben architettate, Teatro Sotterraneo, dopo un’introduzione sulle note dei Carmina Burana cantati “a cappella”, ci fa ridere delle situazioni umane, ma anche dei nostri dubbi (“mi dica un numero da 1 a 10” chiede un attore allo spettatore, senza mai spiegarne il motivo). Il loro è un teatro fisico: la scena è spoglia tranne che per pochi oggetti; tutto si concentra sull’azione e sul fare. È un teatro che prende le distanze dalle compagnie di ricerca formatesi negli anni Novanta per affiancarsi ad altre interessanti e nuove realtà come Babilonia Teatro e gli Omini. È il teatro del Duemila, costretto a vivere con pochi fondi e quindi ad inventarsi linguaggi semplici e diretti. I Sotterraneo riescono a centrare l’obiettivo. Si ride, si ride molto e si riflette. Ci si immedesima e ci si emoziona. Ma c’è di più, a conferma della loro espressione di un teatro fisico d’impatto e senza fronzoli, questi quattro individui corrono e sudano per tutto lo spettacolo, e correndo si stancano davvero, e sudando avviene una catarsi che fa rendere più forti i loro messaggi. Questa corsa continua, ossessiva, arriva diretta allo spettatore. I Sotterraneo ne fanno una bandiera, quella della frenesia della vita contemporanea, incapace di soffermarsi, riflettere e fare una pausa. Incapace di comunicare e di amare, come si nota nella scenetta della dichiarazione sulla panchina del giardino. La corsa è la parabola della vita ma anche e sopratutto del teatro, della storia di una giovane compagnia che ha idee innovative, è radicale nel proporsi e si autoproclama come un collettivo teatrale senza capi e senza gerarchie, secondo la logica del “fare tutto insieme”, della condivisione: sullo stile delle cooperative anni Settanta che, dai Novanta, stanno sulle poltrone che contano di questo nostro teatro. Questi cinque giovani non ancora trentenni (c’è anche un dramaturg che non entra in scena) da quattro anni girano l’Italia in lungo e in largo, corrono e sudano la loro voglia di teatro, le loro doti e capacità drammaturgiche e performative. Tutto in fretta, senza sosta, da Volterra a Dro, da Roma a Milano, rinnovandosi sempre, mettendosi in gioco, costretti forse a mettere da parte, talvolta, le rispettive storie personali. Il risultato è davanti ai nostri occhi: una compagnia che sta crescendo velocemente così come l’abbiamo vista correre in scena, incanalando uno dopo l’altro spettacoli e gettandosi alle spalle i sacrifici di una realtà teatrale precaria, quella del giovane teatro di ricerca. Ma tutto questo correre porterà a qualcosa? La risposta di Teatro Sotterraneo s’intuisce grazie a un buffo tricheco che entra in scena per il finale. Trasmette una voce registrata, simile ai giochi fatti col pubblico poco prima. La domanda è: “Se tornaste indietro, lo rifareste? Sì? No?”. La risposta viene inghiottita dal buio; e mentre le menti si dividono prese dal dubbio, gli attori – esausti – tornano a prendersi la loro meritata dose di applausi. Il pubblico del Teatro Guanella di Milano mostra di aver gradito. I Fantastici Quattro (o Gli Incredibili?) possono finalmente andare sotto la doccia».
Simone Pacini, klpteatro.it
«Teatro Sotterraneo nasce del 2004 a opera di quattro attori (Iacopo Braca, Sara Bonaventura, Matteo Ceccarelli e Claudio Cirri) e un drammaturgo (Daniele Villa). Hanno presentato il loro folgorante La cosa 1 il 25 giugno all’interno della Fabbrica delle Idee di Racconigi, nel parco dell’ex Ospedale psichiatrico. Vestiti di attillate tute hi-tech e dotati di opportune scarpe antiscivolo, dopo un “O Fortuna” dai Carmina Burana cantato a cappella, i quattro performer-atleti hanno corso a perdifiato per tutto il tempo della rappresentazione sulla scena completamente spoglia (a parte la momentanea apparizione di una panchina e di una tenda da campeggio). In un vero e proprio “trailer di una vita”, hanno mostrato i paradossi del nostro (assurdo e freneticamente inconcludente) esistere quotidiano. Relazioni, sentimenti e affetti centrifugati in mezzo a lettere d’amore piene di errori, frammenti amorosi in (autentico) giapponese, improbabili party privati al suono di Cacao meravigliao, questionari deliranti, divertenti interazioni con il pubblico e apparizioni di un gigantesco e spiazzante tricheco blu. Un teatro tutto fisico che, tra paradossi e stereotipi, racconta il nostro presente senza moralismi e (purtroppo) senza vie di fuga».
Paolo Bogo, slowfood.it
«Immobilità: una cosa sciocca. Più che sciocca, improbabile. Unica possibilità? Correre. Senza sapere dove si va, senza fermarsi un attimo a pensare. Semplicemente fare. La Cosa 1: una corsa, un fare, un procedere. Puro svuotamento di azioni e nessun sentimento, riflesso nel palco vuoto, senza alcuna scenografia. Il giovane gruppo Teatro Sotterraneo porta in scena un’energia folle, una frenetica esistenza fatta di un fare malato, disperato, esasperato: un fare che spesso non porta ad alcuna conclusione. Solo alla considerazione che devi correre. E per farlo devi essere ben attrezzato. Lo richiede la stessa sopravvivenza.
Il corpo dei quattro performer Iacopo Braca, Sara Bonaventura, Matteo Ceccarelli e Claudio Cirri vive una sofferenza, si ferma per pochi secondi: piccoli quadri, sketch di brevi episodi della propria vita, veri o inventati; situazioni. Il montaggio è serrato: Matteo sciorina al pubblico le violenze subite da tutti i suoi parenti, un mega pupazzo azzurro è sommerso di domande personali a cui non tenta neanche di rispondere, in una tenda da campeggio viene data una festa, su una panchina si susseguono dichiarazioni d’amore. Non si ha un vero discorso da fare: è una drammaturgia di azioni, non ci sono personaggi fittizzi, i performer si chiamano con i loro stessi nomi. Sono. E ancora situazioni: si regala una canzone romantica a cui si affidano i propri sentimenti. Forse anche essi vuoti. L’alternativa è scrivere una lettera. Inconcludente. O parlare in lingua giapponese. Incomprensibile. Non c’è tempo per soffermarsi troppo su quello che succede. Alle cose non si arriva preparati. Accadono. Passano.
Teatro Sotterraneo, fresco del Premio Ubu Speciale 2009, usa un linguaggio divertente, coinvolge il pubblico chiedendo dei numeri casuali che avranno poi delle conseguenze, una volta tradotti dai performer in azioni – schiaffi, baci, conti alla rovescia –: è il fare alla sua ennesima potenza. Daniele Villa, dramaturg di questo geniale collettivo teatrale, spinge il testo all’estremo, con situazioni al limite del paradossale; ma lo fa con un’intelligenza sottile che fa sorridere e che nasconde tutta la verità – e assurdità – del nostro vivere quotidiano.
Dopo essersi fermati per un’ora a teatro si esce e si ricomincia a correre, cercando di recuperare un tempo che però non è andato in questo caso perduto. Magari dopo aver visto questa corsa folle ci si soffermerà di più a vivere e a trattenere delle situazioni, riempiendole di significato, per non lasciarle correre via senza farne rimanere traccia. Dopo tutto: “si vive una volta sola”».
Carlotta Tringali, iltamburodikattrin.com
L’Odio come necessità del mondo.
«Lo spazio per la performance/evento è grande. Forse troppo. Le cinque figure vi si trovano immerse, diluite, come scogli che intaccano un’ipotetica prospettiva-marea. Ma lo stato iniziale è destinato a durare pochi, lunghi, attimi: i corpi subiscono un’inflazione cinetica, lo spazio si squarcia e si ricompone lungo le diagonali e le sinuose geometrie tracciate dai quattro performer-vettori, in movimento perenne. L’Amore e l’Odio, Philia e Neikos, giocano a dadi con questo universo-bambino in tumultuosa crescita, narrandoci di sfortune quotidiane e dissociativi quiz comportamentali, di passeggiate che terminano su una panchina distesa su un manto verde e di pupazzi senza il pollice opponibile.
Rigoroso e al contempo “provvisorio”, il lavoro Teatro Sotterraneo ruota attorno a un teatro fisico che va ben oltre la semplice dimensione performativa, per divenire evento cosciente – o meglio, serie di eventi – proponendosi come una quotidianità distillata chirurgicamente dal flusso omologante della socialità contemporanea. L’incessante azione scenica, che solo a una visione superficiale sembra connotarsi unicamente come un continuo dinamismo, si sviluppa lungo sprazzi narrativi minimali, essenziali, topoi grazie ai quali l’azione progredisce, riconnettendo ogni frammento in un orizzonte più vasto di significato.
I frammenti giunti fino a noi dell’opera di Empedocle, mago, filosofo e taumaturgo greco vissuto molti secoli prima di Cristo, pre-socratico e forse orfico, ci narrano della concezione del mondo di questo grande pensatore che leggenda vuole sia morto cadendo nell’Etna: quattro principi eterni stanno alla base del nostro cosmo; questi principi essenziali, immutabili, vengono combinati tra di loro quantitativamente dalle due forze cosmiche Amore e Odio; l’aggregazione che ne risulta viene chiamata “sfero”, punto perfetto e infinito che è, in breve, il mondo dentro il quale viviamo. Infine, al sopraggiungere dell’Odio, il mondo-sfero nuovamente si disgrega negli elementi primi, e di nuovo interviene l’Amore a ricomporre il tutto, e la Ruota del Mondo continua a girare, e le ere del mondo continuano a susseguirsi.
Il lavorio turbinoso in scena di Iacopo Braca, Sara Bonaventura, Matteo Ceccarelli e Claudio Cirri – tutti molto convincenti e intensi – porta a una mescolanza di corpi e sguardi, velocità e qualità che squarciano lo spazio e il tempo di ere sociali, o private, che vanno “dalla culla all’apocalisse”. Topoi come la festa, il corteggiamento, il quiz sono mondi-sfero ideali in cui l’Amore o l’Odio (l’assurdità catalogatrice del quiz, le urla su una panchina eletta a luogo d’amore) determinano il senso di quel correre a perdifiato. Questa Historia Universalis non conosce soste. Appena uno dei quattro stramazza a terra o perde il ritmo viene invitato con urla e spintoni a continuare. Si ricompattano e ricominciano a correre. Ne va della loro unicità, che non viene mai meno nelle ere che si susseguono davanti ai nostro occhi: la ragazza è Sara (Bonaventura), il ragazzo che scrive la lettera è Iacopo (Braca). La necessità dei quattro di creare dei mondi, di esistere, è ineludibile. Il titolo, perentorio, ne dà un esempio perfetto: si odono echi dalla pop culture (Howard Hawks? Be Grimm dei Fantastici Quattro? John Carpenter?) per uno spettacolo che è insanabile malattia, vitalità virale per un’esistenza unica e irripetibile, in cui ogni storia è infinitamente unica e sacra.
E ciò che sta alla base degli spettacoli dei Teatro Sotterraneo sembra confermare ciò: per ogni lavoro vengono accumulati i materiali più disparati, estensioni policrome e ingombranti di ognuno dei cinque componenti del collettivo – Palahniuk, Indymedia, il Satyricon, Scarceranda, Memento, Abraham Yehoshua, Skorpio e i comics della Marvel… Di tutto ciò un nome risuona durante La Cosa 1: Takeshi. Ed è la straripante comicità fisica (vedi Brother o Sonatine) e le surreali gag del grande autore-attore-regista giapponese che sembrano riverberarsi nell’estrema vitalità del fare teatro dei Teatro Sotterraneo, e – come non citarlo? – nell’assurdo pupazzo gigante che insegue uno di loro inciampando, e che, in assenza di pollice opponibile, non riesce a prendere, far suo, nulla – tranne, emblematicamente, il finale».
Luigi Coluccio, www.123people.it
Una rincorsa continua per sentirsi vivi
«Un atletismo circense come inno in perenne evoluzione trasformativa. Metamorfosi comunicative mediate da una poetica che si rifà al teatro dell’arte, semplice, essenziale, provocatorio. Un manifesto dedicato alle accezioni più svariate che compongono l’universo chiamato Vita. L’energia positiva è alla base di questo lavoro, portato in tournèe dal gruppo di Teatro Sotterraneo, dimostrato da un impegno fisico e mentale, che non si risparmia nell’economia dello spettacolo. Un’agitazione controllata da un equilibrio registico capace di armonizzare movimenti fulminei, proiettati dentro e fuori la scena. Un palcoscenico volutamente spoglio progressivamente riempito dai corpi scattanti dei quattro agilissimi e funambolici performer: Sara Bonaventura, Iacopo Braca, Matteo Ceccarelli, Claudio Cirri. E adesso? Se lo chiedono gli ignari spettatori convenuti a teatro, per onorare un rito sociale collettivo. Un adesso che deriva dall’attesa di assistere ignari a un evento indecifrabile nelle sue prime manifestazioni sceniche e coreografiche. Loro, i protagonisti, sono già sulla scena da principio ribaltando la convenzione che da inizio alla recitazione. Uno per volta escono in quinta per lasciare posto a un boato fragoroso. Un clamore di folla, un’esplosione sonora, un applauso vocale, come per annunciare l’entrata della star, di un idolo canterino. Tornati sulla ribalta, quattro voci per intonare i Carmina Burana in versione personalissima e divertente. La cifra stilistica, evidente sottotraccia drammaturgica, è dettata dall’ironia, sagace, giocata sul ribaltamento continuo dei piani espressivi, linguistici e meta-comunicativi. Una rincorsa continua come fuga dal presente. Corsa come metafora di esistenze sottoposte a sollecitazioni frenetiche. La vita è un incessante correre dietro a utopistiche chimere. Se ti fermi, non esisti, sembrano dire i quattro infaticabili. Correre come gesto di affermazione. Necessità improcrastinabile al fine di rivendicare l’esistenza stessa dell’essere in vita. Tanto da far dire agli attori: “Non fermarsi mai, ogni passo in più è una sfida all’immortalità”. Non c’è mai soluzione di continuità nello scorrere fluido, a volte compulsivo, nella reiterazione di una gestualità fisica. Tra loro si corteggiano, si amano, si scherniscono, esultano e giocano. Azioni in corsa, mai statiche, mai riflessive, o autocoscenziali. Non c’è tempo per soffermarsi, pena la caduta della tensione emotiva. Non ci si guarda all’indietro. Non si possono avere tentennamenti o rimorsi. Se ti fermi sei perduto. In scena si realizza l’immaginario collettivo di una realtà frammentata, scomposta, sezionata. Un collage di simboli e presenze fantasmagoriche. Un enorme pupazzo di peluche irrompe in scena. E’ un tricheco sottoposto a un questionario inconcludente. Una maschera grottesca per giocare sull’imprevedibilità di senso che s’insinua a getto continuo. Gag in collaborazione con il pubblico, tra lo stupore di chi viene baciato 19 volte dopo aver risposto alla domanda. “Dica un numero da 0 a 19”, l’ilarità suscitata dai 7 schiaffi dati da un attore all’altro, grazie al suggerimento numerico arrivato sempre da uno degli spettatori. Il numero 59 diventa il pretesto per dire: “Ci conosciamo da 59 anni”. La parola “amore” declinata in tutte le sue accezioni musicali, diventa un sequel stereotipato. Dal 90 allo 0, conteggiato all’indietro come una moviola verbale. Avanti e indietro. Non c’è autocompiacimento, tanto meno facili espedienti per suscitare ilarità e approvazione. Non c’è la ricerca di un’emozione da trasmettere, bensì l’evitamento, a fronte di una cinestesia emotiva e sensoriale, patologia diffusa tra le nuove generazioni. Spettacolo denso di simbologie esistenziali, tradotte mediante una scrittura assemblata e rilanciata sulla scena. Con intelligenza e tanto sudore».
Roberto Rinaldi, www.teatro.org
SUITE
Satira in cronaca (nera).
«Sarà l’effetto della televisione, o l’eco di certi film di serie B, fatto sta che più di uno spettatore, alla voce “cronaca nera”, immagina un’apocalisse fatta di sangue, coltelli e cadaveri sgozzati. Prende spunto da questi stereotipi l’ultima fatica di Teatro Sotterraneo, compagnia rivelazione del Premio Scenario 2005 con 11/10 in apnea. Sull’esempio di Scary Movie, i quattro attori – o sarebbe più corretto dire performer – ribaltano con astuzia i topoi del genere horror per condurre una satira delle modalità di rappresentazione della cronaca nera in Italia. Lo scenario è noto: un interno domestico – qui ricavato dal salone del Palazzo Pretorio a Cittadella –, apparentemente neutro ed evocato, come in un rebus, da pochi elementi: uno scaffale bianco, un tavolo, una sedia, degli elettrodomestici. Le azioni sono ugualmente note: i quattro performer, vestiti impeccabilmente di bianco e di nero, si inseguono, complottano, ricevono imprecisate e improbabili indicazioni per annientare l’avversario attingendo a piene mani dai cliché del genere (gli occhi rossi, l’illuminazione dal basso, il bicchiere gigante, avvelenato, di hitchcockiana memoria). Nonostante le premesse […], il meccanismo funziona, la sincronia degli interpreti è perfetta, certe trovate – la musica dei Goblin che si interrompe, sfumando nella colonna sonora di Ennio Morricone – azzeccate e il ritmo bel calibrato. Lo spettatore segue con attenzione la pièce e sorride divertito agli ammiccamenti degli attori».
Roberto Rizzente, Hystrio
«Il mini studio che abbiamo visto nell’estate 2008 al Centro Pecci per Contemporanea Festival era imperniato e incentrato sull’idea di casa. Anche il titolo stesso Suite, richiamava alla mente un’abitazione lussuosa e perfetta dove tutto aveva una precisa collocazione e dove, soprattutto, qualsiasi cosa, oggetti, mobilia, soprammobili, funzionava. Con un clic, un gesto, l’oggetto si sarebbe messo al servizio dell’uomo. È la normalità che conosciamo. Ma basta un black out per mandarci in fibrillazione. La prima parte ritornava su quella ricerca: elettrodomestici che non solo non svolgono il loro compito ma che si azionano a loro piacimento proprio quando l’uomo se ne allontana. Si muovono di vita propria. Senza chiedere il permesso. Come Christine la macchina infernale. Come Kit di Supercar. Come Caterina, la cameriera robot di Alberto Sordi. Prese diaboliche, spine elettriche indemoniate, ciabatte impazzite. Che l’Enel non scritturerebbe mai i Sotterraneo per un proprio spot pubblicitario. Tutto è pervaso dal thriller e la mente va più a La Casa, il film horror di Sam Raimi, più che alle quattro mura con un tetto sopra. Potremmo parlare di una parodia alla Scary Movie delle più celebri pellicole dell’orrore. Vedi Freddy Krueger. Tema principale: Profondo Rosso, che ritorna a flash o grazie alla nenia in sottofondo. Vedi citazioni da film, musicali e sceniche: classici intramontabili, must doverosi come Il paziente inglese, gli sguardi taglienti (letteralmente, con i coltelli) alla Sergio Leone, 007. Si travalica nello splatter, irriverente e dissacrante. Tutti contro tutti. Tutti cercano di uccidersi a vicenda. E non di suicidarsi come nel loro primo “11/10 in apnea”. Il teatro dei Sotterraneo è vero. Un teatro dove se si mangia, si mangia davvero, se si beve, si beve davvero. Se ci si sputa, se ci si picchia. I Sotterraneo sul palco fanno i tecnici, i fonici, gli elettricisti. E tutto è mostrato: oggetti di scena e artifici, come protagonisti, una volta usati, entrati ed usciti dalla drammaturgia, rimangono sotto un armadietto nell’occhio conico dello spettatore. Non servono soltanto, ma sono. E alla fine prendono gli applausi».
Tommaso Chimenti, www.scanner.it
L’Alveare di Contemporanea si conferma una vetrina di qualità per giovani performer. «Anche quest’anno Contemporanea Colline Festival ospita a Prato nella sezione Alveare alcuni giovani artisti […] presentando brevi performance create appositamente per l’occasione e legate a vario titolo al rapporto dell’artista con la contemporaneità. La mini rassegna vede debuttare i lavori di due distinti gruppi di performer: Alveare I e II. Un patchwork di creatività contemporanea ben assortito in quattro performance […]. Ma i veri protagonisti di questa prima quartina sono i fiorentini Sotterraneo, ancora una volta sorprendenti artefici di una messinscena dell’assurdo, che attinge al banale e al quotidiano tirando fuori un’invenzione ad hoc fresca e divertente. Il luogo scelto per la performance è una suite abitata da fantomatici elettrodomestici, dove 4 personaggi un po’ retrò in un work in progress scenico e scenografico vivono e convivono tra feste di compleanno, sketch canori a cappella, momenti da sit-com e avvelenamenti. E nel rintracciare la verve che sempre si addice all’ingegnosa formazione toscana, il merito va ancora una volta all’originale approccio al reale. La realtà è la migliore fonte anche quando si parla di assurdo. Soprattutto».
Miriam Monteleone, www.teatroteatro.it
«Non c’è regista, si fa tanto laboratorio, e un dramaturg offre la partitura verbale, una serie di “ponti di parole”, che permettono, quando necessario, di saldare i vari momenti di uno stile di rappresentazione eminentemente visivo tutto fondato sull’azione fisica, sul gesto, la postura, il segno. Interessante: costringe lo spettatore a diminuire lo stato di veglia, anzi di allarme razionale, per affidarsi alla coscienza intuitiva. Tutto ciò ricorda gli anni Settanta, specialmente nella proposta di una differenziazione tra scrittura scenica e scrittura drammaturgica, epperò v’è anche l’impressione che il gruppo deve qualcosa alla grafica per internet, dove le pagine sono luoghi in cui varie cose accadono in contemporanea e sovente svincolate dal consueto rapporto logico causa-conseguenza a favore di una relazione analogica. In questo senso, nella tendenza all’analogia, si potrebbe definire quanto si vede in scena un teatro di natura femminile, ossia meno statuario, affermativo, argomentativo di quello tradizionale, drammaturgicamente strutturato, che diremmo maschile. Epperò altrettanto organizzato se non addirittura più rigoroso perchè quanto mai delicata e fuggevole è la rappresentazione dei processi intuitivi e delle concatenazioni concettuali analogiche fondate su principi di somiglianza, riconoscimento, identità».
Marcantonio Lucidi, LEFT
Il mondo è pazzo? Non ci resta che ridere! La filosofia del Sotterraneo di Firenze. «Impazzisci, e poi stupisci!», sghignazzava il Joker dalle pagine di Batman: The Killing Joke , uno dei capolavori della letteratura a fumetti nato dal genio del vate Alan Moore. La nemesi per antonomasia del Dark Knight la sapeva lunga su ciò che ci separa dalla “normalità” e dalla follia: un maledetto giorno sbagliato. Per chi sa vedere, quel giorno si ripete ogni mattina. E per chi è insanamente sano di mente non si può far altro che riderne per comprendere.
Il Teatro Sotterraneo – made in Firenze – lo fa, e anche molto bene. […] Dopo le annotazioni contenute in Post-it sull’umano vivere, ci regalano ora cartoline dall’Inferno della dimensione domestica e del mondo che ci attende fuori l’uscio di casa. Due produzioni parallele, ma complementari: Eko, in attesa di trasformarsi in Suite a Prato (nella rassegna Contemporanea ’08 dal 28 maggio al 2 giugno), e La Cosa 1 che, dopo essere stata a Roma a Uovo Critico, sarà in un primo studio al Festival Inequilibrio esploso a Castiglioncello (19 aprile), e in prima nazionale al Festival Fabbrica Europa (Firenze, 20-21 maggio). L’Eko/Suite musica e fissa in una scatola scenica bianca le quattro mura domestiche, entro cui si muovono i protagonisti, esseri umani ed elettrodomestici. In fulminei riferimenti cinematografici, scatti di danza e blocchi di corpi inanimati, si osserva la paralisi dell’uomo dettata dal feticismo verso gli oggetti, nell’oblio dell’altro».
Giacomo D’Alelio, Queer
POST-IT
Post-it. Studio anatomico di una sciagura.
«Un’esplosione attutita, un precipitare in scena di brandelli di carne con immediata raccapricciante pulizia, e grotteschi inviti mediatici alla calma. E poi un’elaborazione della morte con listino di film luttuosi, e manuale di liturgie funebri, di camuffamenti per una perdita. Il collettivo di ricerca Teatro Sotterraneo, con Post-it mette in gioco i linguaggi, le sequenze sgradevoli e i pietismi per una scomparsa violenta. E lo fa velocizzando un montaggio fitto di quadri – spezzoni metafisici come incubi o stereotipati come cronache trash – in un cubo di metri 5×5 foderato di guaine trapassabili di continuo da Sara Bonaventura, Iacopo Braca Matteo ceccarelli e Claudio Cirri. Fuori e dentro, i corpi hanno sospensioni coordinate di teste, di arti, di busti, come figure del pittore belga Michael Borremans. Lo studio anatomico di una sciagura, e la caustica drammaturgia di Daniele Villa esprimono una profonda e anti-enfatica attenzione per il mistero, spesso svenduto, della morte. Ed encomiabile è il lavoro dei quattro che attingono a diagonali ed elastiche onoranze per lo choc estremo, fino a che la camera ardente scompare con una canzone cupa di Antony».
Rodolfo di Giammarco, La Repubblica
Post-it, frullato di quotidiano al cubo – Castiglioncello.
«Teatro di taglio, che sbuca dalle fessure di un sipario, che saltella festoso e si specchia nei suoi doppi: la sorpresa di Inequilibrio 07, decima edizione del Festival di Castiglioncello, è Teatro Sotterraneo, giovanissima compagnia fiorentina con Post-it. Post-it, sguardo bizzarro dietro e davanti le quinte, incursione eccentrica sul senso della fine. Intanto, la formazione: non gerarchica, in orizzontale – quattro performer più uno, il dramaturg – da collettivo di ricerca anni Settanta ripitturato di fresco. Procedono (per ora) tutti insieme, in ordine sparso d’apparizione. Incrociando traiettorie, in questa delizia d’ingranaggio che è Post-it, nel fare e disfare visioni all’interno di un cubo nero di cinque metri per cinque. Sono di poche parole, abbreviate possibilmente e veloci come negli sms, surreali come un cartoon, e come i personaggi dei fumetti, indistruttibili anche quando esplodono e le frattaglie si spargono sul palcoscenico. Niente dramma, siamo contemporanei: una spazzatina per ripulire, una spruzzatina di teoria, tecnica e menzogna delle comunicazioni di massa e la scena nel cubo torna nera come prima. Sono smaliziati questi “Sotterranei”, che si muovono come fumetti ma si portano dietro tutto il disincanto degli adulti. Il bla-bla delle dichiarazioni, le formule vuote da linguaggio pubblicitario. Tutto viene frullato e siglato in un post-it ideale, un cumulo di dettagli che riassumono una vita e la sua conclusione, un funerale a turno, il senso della fine chiesto per telefono al primo che capita. Cosa resterà di noi? Una foto scattata sul vuoto. Tremate spettatori, una risata lugubre vi sotterraneerà».
Rossella Battisti, L’Unità
«Benché i segnali si cogliessero da tempo, colpisce la rapidità con cui una nuova generazione del teatro si sta oggi prepotentemente affacciando all’orizzonte: a dividerla da quella precedente, i Muta Imago, i Città di Ebla, non ci sono probabilmente che tre o quattro anni di differenza (intendendo ovviamente l’anagrafe dei gruppi, non l’età dei loro componenti) eppure le distanze sono enormi. Che si tratti di una generazione, e non di una serie di formazioni in ordine sparso, lo dimostrano le affinità di uno stile fortemente riconoscibile, spoglio, spiazzante, il comune ricorso all’ironia, la palese fedeltà agli stessi modelli, primo tra i quali Rodrigo García. In Post-it, lo spettacolo che il Teatro Sotterraneo ha realizzato nell’ambito di Fies Factory, il progetto di sostegno ad alcune giovani formazioni promosso dal festival Drodesera, l’influenza dell’artista argentino, più ancora che nei pezzi di carne gettati alla ribalta, o nella sferzante elencazione di film con un epilogo tragico, si avverte nella drastica rinuncia a qualunque traccia di convenzione drammatica: nel loro lavoro, come in quello di Babilonia Teatri (ma con un’impassibilità persino maggiore) non c’è posto per una vicenda da rappresentare, per dei personaggi identificabili, per un impegno in qualunque modo interpretativo. A riempire la scena vuota, una scatola neutra di stoffa nera con dei tagli laterali dai quali passano i corpi e gli oggetti, ci sono solo quattro attori che costruiscono una tenue composizione di azioni volutamente, enigmaticamente elementari: percorrono geometricamente lo spazio, scompaiono e ricompaiono attraverso i suoi pertugi, talora sembrano quasi disarticolare la figura umana, immettono piccole suppellettili, un aspirapolvere, dei salvadanai. Per certi aspetti, non c’è neppure un filo conduttore: tocca allo spettatore, collegando impressioni sparse, rendersi conto a poco a poco che a fare da motivo portante è il tema della morte. Dalla richiesta iniziale di un improbabile minuto di silenzio in onore di un amico scomparso, all’ingegnosa trovata di chiamare al cellulare un invisibile interlocutore perché fornisca “in vivavoce” una sua definizione della fine, all’irresistibile commemorazione suggerita dal cadavere stesso a un oratore che non ne capisce bene le parole, l’argomento aleggia infatti stralunato e beffardo. Il tutto potrebbe chiudersi con l’intenso rito funebre in cui uno dei quattro viene sepolto con le sue cose sotto un telo di cellophan. Ma agli autori pareva forse troppo emotivo: così, con esemplare coerenza, gli aggiungono un’altra conclusione, molto più gelida e dimessa. Proprio questa scelta testimonia a mio avviso la personalità e il rigore del gruppo, che partendo da un apparente minimalismo, da un’essenzialità quasi giocosa, riesce a togliere e poi a togliere ancora qualcosa. È il succo del teatro che si fa ora: azzerare la forma, scavalcare ogni sorta di elaborazione estetica finché la nuda sostanza della vita trovi la strada per imporsi da sola».
Renato Palazzi, delteatro.it
Variazioni sulla fine – Post-it.
«Il giovane gruppo fiorentino Teatro Sotterraneo, che ha scelto di agire come collettivo orizzontalmente strutturato, ci propone un’originale e stratificata riflessione sul concetto di “fine”. Un cubo nero, sulle cui pareti si aprono insospettati tagli e fessure, è costantemente percorso e attraversato, perforato da braccia e gambe, mani e piedi. Da abili performer, ché la definizione di attori sarebbe riduttiva, i quattro si muovono con perfetti ritmo e sincronia, componendo una sorta di danza che combina la comicità di molti film dell’era del muto e la precisione di certi contemporanei studi sui micro-movimenti degli arti. Ma lo spettacolo non è solo questo: se l’incipit pone l’accento sul corpo, le scene successive ricreano situazioni surreali, la cui divertita leggerezza cela un dichiarato intento di satira sociale. L’obiettivo è quello di svelare ipocrisie, formule, mode che nascondono ed edulcorano la nostra realtà: il linguaggio televisivo, e quello dei comunicati ufficiali, il gergo dei giovani e quello “di circostanza”. Assistiamo, così, ai vani tentativi di smorzare le inevitabili tragiche conseguenze dello scoppio di una bomba a mano, ma anche al discorso funebre suggerito dallo stesso defunto all’imbranato elogiatore; a un monologo sulla conclusione, inopportunamente rivelata, di film e fiabe, e a una telefonata in diretta dal palcoscenico. Il filo che tiene unito tutto ciò è la volontà di svelare il fine e la fine di quanto ci circonda, con la convinzione che tutto sia destinato ad avere un termine. Oggetti di ogni genere sono diligentemente impacchettati, spacchettati e utilizzati e infine buttati: la bottiglie di vino e la matita, la maglietta e il bicchiere, anche l’uomo stesso, avvolto nel cellophane, deve inesorabilmente abbandonare la scena. Uno spettacolo brioso e ironico, fresco e intelligente, capace di mantenersi in fragile equilibrio fra gag solo divertente e satira arguta».
Laura Bevione, Hystrio
«Di grande gioia per l’intelligenza e l’ironia dello spettatore è anchePost-it del giovane gruppo Teatro Sotterraneo, già segnalatosi al Premio Scenario, che anche qui porta la sua notevole freschezza interpretativa, piena di lucida consapevolezza teatrale. […] La narrazione in senso classico non esiste, lo spazio scenico asettico, rivestito da tagli e aperture, è attraversato continuamente dai quattro attori e anche quello che si immagina fuori è allo stesso modo importante. Il tema costante è il sentimento del/della fine riproposto in mille modi in un gioco al consumo che vive di opposti di pieni e di vuoti, di svelamenti e di occultamenti. L’ironia pervade ogni cosa ed ogni cosa non vuole spiegare niente ma lo spettatore inspiegabilmente è coinvolto in un gioco di rimandi assai stimolante di divertita e divertente teatralità».
Mario Bianchi, eolo-ragazzi.it
Teatro Sotterraneo. Un vero collettivo, senza gerarchie. Nasce a Firenze e contamina diverse tecniche comunicative. Nessuna narrazione classica. Molte risate. «Li abbiamo visti all’ultima edizione di Short Formats a Milano e ci siamo divertiti. Molto. Teatro Sotterraneo è un collettivo di Firenze formatosi nel 2004, composta da quattro performer e un drammaturgo. Nel corso degli ultimi anni, si è distinto nei diversi epicentri del teatro di ricerca per l’originalità delle produzioni e per un percorso di ricerca di statuto autonomo con un metodo di assenza di regia, a evidenziare la mancanza di gerarchie nella contaminazione di arte scenica, performing arts, arte visiva, videoarte, drammaturgia, design, videogiochi, musica, pop culture. Post-it, lo spettacolo che stanno portando in giro per l’Italia, colpisce per semplicità d’impianto e forza comunicativa: un cubo inguainato in teli neri con tagli e aperture attraverso cui la compagnia opera un cut-up visivo e verbale, in una continua implosione da “comica finale”, con una riflessione in profondità sul concetto di intrattenimento. Il risultato è un’ora esilarante in cui trovate senza sosta, basate sul taglio con funzione scenica e ispirate al rivelamento della forma tramite occultamento, mutuato dalla pratica artistica di Christo e Jeanne-Claude, colpiscono lo spettatore producendo ilarità, ma anche una continua riflessione sullo stato della rappresentazione totalmente disgiunta da una narrazione. Il collettivo fa parte, insieme ad altri giovani gruppi, di Fies Factory One, progetto di promozione di nuove realtà del tetrodi ricerca nate intorno al nucleo del Festival di Dro. Correte a vederli e divertitevi».
Carlo Orsini, Rolling Stone
Il mondo confuso nell’era degli sms.
«Post-it, ovvero comunicazione in tempo di Internet e sms, veloce sintetica aleatoria, da consumare e gettare, memoria di una realtà colta per frammenti, immagini che non esauriscono ma si esauriscono. Post-it è anche e significativamente il titolo di uno spettacolo presentato l’altra sera al Palamostre di Udine, nell’ambito della stagione di Teatro Contatto, da una giovanissima formazione, Teatro Sotterraneo. Attenta al contemporaneo, la compagnia fiorentina sviluppa un linguaggio spettacolare che ne insegue i miti e i riti con un coacervo di immagini conchiuse in sé, come tanti tasselli di un puzzle che non si comporrà mai definitivamente o piccoli numeri di un varietà del nostro tempo, di cui sfugge il senso ultimo, ammesso che un senso lo si sia voluto dare. […] Meritano attenzione, quelli di Teatro Sotterraneo: il loro approccio col teatro è sicuramente poco convenzionale, opera per sottrazioni e scomposizioni, non è didascalico e sembra rifuggire le suggestioni emotive in un accumulo […] di gesti parole movimenti situazioni governati da un’apparente casualità. Sicché la quotidianità e il presente si strutturano in una sorta di insignificante cerimonia della normalità che ne smaschera l’assurdo e il grottesco. Una cerimonia che si consuma veloce e sintetica secondo la logica e la poetica, ammesso che una qualche poetica ci sia, dei Post-it e del mondo imprendibile, un po’ folle malato e confuso, che ne sta dietro».
Mario Brandolin, Il Messaggero Veneto
L’arte che viene dal «Sotterraneo».
«Dal 21 a ieri è andato in scena al Teatro delle Passioni di Modena Post-it, spettacolo del Teatro Sotterraneo. Dopo aver letto lanci del tipo «Teatro Sotterraneo è un collettivo di ricerca teatrale in cui cinque elementi coabitano una pratica orizzontale» oppure «Post-it è un recesso dove verificare ogni possibile Fine», ci si potrebbe attendere il solito spettacolo da festival di teatro contemporaneo, l’eterna “ricerca” di cose già trovate in cui i soliti cliché che erano vecchi trent’anni fa vengono rimontati stancamente per la gioia e la rassicurazione di un certo pubblico. E invece no: è solo cattiva pubblicità. La formula è sempre quella: un’ora scarsa di durata in cui si sovrappongono pannelli di varietà teatrale senza un senso evidente. Alla fine arriva pure l’immancabile installazione visiva “festivaliera”, fatta comunque con gusto, offerta alla contemplazione del pubblico questa volta sulle note di Antony and the Johnsons (band di culto per ogni giovane “creativo” che si rispetti). Ma non c’è neanche un po’ di sgozzamenti (salvo alcune frattaglie sparse, a dire il vero), niente anoressici o ciccioni nudi, niente down, niente video-arte, niente urla e nemmeno un po’ di parafilie o malattie mentali. Come si fa a fare teatro contemporaneo senza tutto questo? Forse non è “contemporaneo” (è “postumo”?), ma quello dei “Sotterranei”, quattro attori giovani (per davvero) e un “dramaturg”, è teatro di qualità, notevole per la sua ricerca di un artigianato serio, asciutto e preciso, invece che di barocchismi adolescenziali. Con un retrogusto da MTV che riesce in un qualche modo a non essere stucchevole, le loro improvvisazioni cristallizzate sul tema della morte e della fine riescono a far ridere con la sola cura dei tempi teatrali, sia nelle sezioni “di parola” che in quelle “visive”. E non si tratta di leggerezza post-ideologica. Qui ci si sganascia sul serio, anche perché traspare l’esistenza di un pensiero sottostante. Il tema della fine viene affrontato dal punto di vista antropologico, narratologico, esistenziale, ma la finalità è sempre fare teatro. Per essere uno spettacolo sulla morte, Post-it è uno dei rari segni di vita del comatoso teatro italiano. Speriamo che i “Sotterranei” proseguano la ricerca avviata di comunicatività e semplicità, senza farsi intrappolare dalle schematizzazioni della critica e dalle aspettative degli organizzatori».
Paolo Montanari, L’informazione
Post-it, la surreale comunicazione di oggi.
«Inizio e fine non hanno una linea netta di demarcazione, non si escludono a vicenda anzi l’uno ha bisogno dell’altra per esistere, potrebbe una fine esistere senza il suo inizio? […] “Post-it” – al Palamostre di Udine per la Stagione Contatto del CSS – ultima produzione di Teatro Sotterraneo, un collettivo, come ama definirsi, di ricerca teatrale made in Firenze, è un intreccio di situazioni portate al limite della realtà che tracima nella simulazione, di conclusioni che presuppongono un principio il cui percorso però viene paradossalmente spezzato, interrotto da uno scarto, un errore di programmazione del sistema, un vuoto logico che si traduce in un’errata esecuzione. […] Attraverso i tagli dei teli che compongono la scatola nera (misure metri 5×5), compaiono e scompaiono nel totale silenzio, parti di corpi umani in un gioco di scomposizione spaziale che crea un bell’impatto visivo dato dalla perfetta sincronia di immagini e tempi. Microstorie (short) accolte dentro un contenitore neutro capace di rimandare l’emozione, l’ironia, la leggerezza quasi surreale che questo gruppo di quattro attori più un dramaturg, sa costruire di circa un’ora che racconta, pur senza molte parole, il mondo contemporaneo della comunicazione persuasiva e ipocrita dei media, e quello più quotidiano e privato delle convenzioni da rispettare. Una scelta coraggiosa e intelligente, libera d’essere guardata e interpretata senza schemi o codici, che scorre in superficie, senza porre radici profonde, e si propaga come un rizoma nutrendosi solo di aria e di luce».
Rosi Fasiolo, Il Gazzettino di Udine
Post-it, i frammenti della fine. «UDINE – Fine, morte, punto estremo delle cose. Inizia da qui, dall’epilogo di situazioni e persone, la performance teatrale Post-It del collettivo Teatro sotterraneo andato in scena al Palamostre di Udine sabato 26 gennaio, inserito nel programma del Css. Una “fine” volutamente frammentata che, come un post-it attaccato e staccato subito dopo, dà vita a situazioni che terminano quasi immediatamente in modo sconnesso. Composizione e destrutturazione dell’esistenza umana anche attraverso gli oggetti che la compongono. Forte, infatti, la simbologia delle cose che, seguendo le linee rosse dello spettacolo, diventano protagoniste, punto di riferimento e sprigionano il senso della loro esistenza tra le mani degli attori che le rompono, le scartano, le usano, le vivono e poi le rimuovono. Il collettivo orizzontale di matrice fiorentina nato nel 2002, formato da Sara Bonaventura, Iacopo Braca, Matteo Ceccarelli, Claudio Cirri e Daniele Villa, non ha la velleità di trasmettere messaggi forti ma usa la contenutistica della messa in scena come momento di riflessione individuale dove, ciascuno può fermare il pensiero dove preferisce, dove sente e percepisce che lo spettacolo è anche parte di sé. Un cubo di teli neri con delle fessure sulla realtà circostante è l’essenziale scenografia di Post-It. Persone che entrano ed escono continuamente dallo stage sviluppano frammenti di teatro, una sequenza di corti, legati da una logica sottile. Una metafora avvolta nel cellophane, fra funerali, trame di film, schiavitù tecnologiche, frattaglie e interiora che riproducono il sangue quotidianamente raccontato in modo asettico dai media. Una contemporaneità che fa sorridere per la contrapposizione tra la tragicità dei contenuti e l’inconsistenza di un linguaggio volutamente forbito. Un ritratto a tinte forti fatto di ironia trascendentale e cinismo del “circostante”, dove le venature di grottesco sottolineano concetti da catturare. Non vogliamo trasmettere messaggi – raccontano i ragazzi all’unisono dopo lo spettacolo seduti, gambe incrociate, sul palco che li ha visti protagonisti per un’ora –, questa performance è nata da un’esigenza collettiva. Volevamo analizzare i vari tipi di ‘fine’, proponendo e spezzando, dando vita a un’azione non concretizzata. Non seguiamo schemi e lavoriamo molto sull’immagine. Il sorriso del pubblico è una conseguenza della nostra interpretazione ma non è ricercato. Non vogliamo essere imbrigliati in schemi particolari per questo cerchiamo di dare vita ogni volta a qualcosa di nuovo. Dopo il confronto diretto gli spettatori si portano a casa una domanda: Cos’è la fine?».
Paola Del Degan, connessomagazine.it
«Una bellissima serata teatrale, incontri attesi, poetiche segnate dall’intelligenza, dalla raffinatezza espressiva, colti e ironici, del tutto differenti tra loro ma lasciando entrambi il piacere del lavoro svolto con passione teatrale e rigore: eccellente avvio per la rassegna”Aprilepiù” al Teatro al Parco promosso da Briciole/Solares con “Post-it” di Teatro Sotterraneo e “à elle vide” di Teodora Castellucci, progetti/creazioni sostenuti entrambi da Fies Factory One, da sempre il festival di Dro attento al mutare delle scelte estetiche, capace di promuovere in varie forme le nuove produzioni di qualità. Di “Post-it” si ricordava il felice incontro a Prato nell’ambito di Contemporanea, il pubblico vicino, ma gli interpreti capaci di conservare un magnifico accordo tra loro, lo spazio scandito in forma limpida, una sorta di divertita coreografia attraversata insieme da elementi di consapevolezza storica, tra citazioni colte ed esercizi di rassegnazione al tempo presente. Visto ora come spettacolo compiuto, “Post-it” – […] un magnifico affiatamento nelle azioni più astratte ma anche nel gioco di sguardi, dei passaggi dalle sfumature più ambigue, dense, sfuggenti – svela una particolare poetica dove il distacco della teatralità più ilare, una sorta d’astrazione, con l’impossibilità a credere, a cedere al dolore, alla verità degli attentati, della morte, è insieme consapevolezza del nostro vivere quotidiano, pezzi di carne in scena a seguito di un’esplosione, chiacchiere con un amico al cellulare, raccolta dei ricordi per l’amico deceduto. Ma chi è morto? L’esperienza a turno del pianto diviene sorpresa d’emozione per il pubblico quando uno dei giovani interpreti verrà fatto scivolare dietro la tenda nera, lui e le sue cose, tutto coperto da un vasto telo trasparente. La casualità dell’esistenza, degli incontri, le entrate e le uscite attraverso i grandi tagli dei teli scuri che delimitano lo spazio, movimenti nel tempo, costringe ad accettare semplicemente quanto accade? Vano anche il tentativo di fermare il ricordo con lo scatto fotografico…».
Valeria Ottolenghi, Il Gazzettino di Parma
Post-it regala un’ora esilarante e dissacratoria.
«Quello a cui ha assistito il pubblico di mercoledì sera a Primavera dei Teatri 2mila7 è stato un bell’esempio di teatro di movimento sorretto da una trascinante freschezza ed originalità. I giovanissimi attori del collettivo fiorentino Teatro Sotterraneo con Post-it hanno regalato al festival un’ora di puro divertimento fatta di trovate sceniche a getto continuo, gag esilaranti e dissacratorie […]. Salgono le luci a illuminare la scena, un enorme scatola nera, vuota, e su di essa, Sara Bonaventura, Iacopo Braca, Matteo Ceccarelli e Claudio Cirri, corpi impazziti in un movimento che supera ogni barriera fisica e non. Irriverente e grottesco dotato di uno stile tutto suo Post-it è una continua e raffinata partita fra attori e pubblico, fra realtà e finzione, in un crescendo di ritmo e complicità fino alla Fine. La scatola nera si riempie di corpi che appaiono e si smaterializzano, sottraendosi alla realtà conosciuta, e di oggetti, tanti, tantissimi, i più disparati, che, confusamente sono essi stessi la scena; si riempie e si svuota del quotidiano e le sue modernità, con le trame dei film svelati e i telefonini onnipresenti, in un amalgama di visionario e surreale impatto scenico. Post-it è tutto e niente, è una corsa, un passaggio da e verso chissà dove. Verso una Fine? Ma la Fine di tutto che cosa è se non la Morte, che irrompe più volte sulla scena […]. Si ride e di gusto con le continue trovate dei ragazzi del collettivo, affiatati e bravissimi […]. Entrate ed uscite, provocazione e caos, molta azione e poche parole, costruzione e destrutturazione, in una sola parola la Fine, che arriva sottovuoto, avvolta in un asettico, enorme, cellophan. Che dire di più se non un invito a vedere lo spettacolo, che merita davvero, e a seguire l’idea di teatro divertente e folgorante che Teatro Sotterraneo cesella in scena con chiarezza e lucidità espressiva».
Domenico Donato, Il quotidiano della Calabria
Primavera dei teatri 2007: un panorama e sette primi piani.
«Proviamo a scattare 7 foto ricordo, le più nitide e luminose, rimaste impresse a chi ha avuto la possibilità di seguire interamente il festival. […] Foto n.3: Post-it, quattro giovani in un cubo. Una delle sorprese più piacevoli del festival, i quattro giovani interpreti di Post-it, creazione collettiva di Teatro Sotterraneo. Un cubo nero di metri 5 x 5 attraversato, tagliato, percorso incessantemente da questi quattro corpi con ammirevole precisione e pulizia del gesto teatrale. Uno spettacolo difficile, se non impossibile, da spiegare: parola pressoché assente, quasi una performance di un’ora giocata sul labile percorso della filiera di produzione, imballaggio e smaltimento dell’individuo. Un funerale lucido, consapevole, pieno di ironia sulla nostra quotidianità spesso assurda, fredda, e comunque unidirezionale».
Gaetano Tramontana, quicalabria.it
«Post-it del Teatro Sotterraneo, al Teatro Rialtosantambrogio di Roma. Post-it: annotazione provvisoria. Appunto da buttar via. Errore da cancellare. Cancellatura sotto la quale cercare l’errore. Il senso dell’errore. Il senso di un favoloso impossibile: la fine. Dopo la metafisica della luce di tanto teatro “della memoria” , di “narrazione” e “d’impegno sociale”, un Post-it ideale della precarietà e della provvisorietà non può che essere accolto con favore. La discesa nei sotterranei è sempre meglio dell’ascesa verso le aurore edificanti. Dove ci troviamo? In uno spazio quadrato, nero. Un non-luogo a procedere. Dove tutto si muove e nulla accade. Dove non c’è né inizio né fine. Muri di buio da aggredire e da attraversare, per far luce sulla fine (un funerale, ma non solo), sotto una trascurabile e trascurata luce bianca, fissa, che illumina le forme. Un atollo come pista di lancio e come approdo di un processo di formalizzazione che si muove sulle tracce del tema prescelto. […] Tra un’uscita che somiglia ad un’entrata e un’entrata a che somiglia ad un’uscita i quattro “performer” si danno un gran da fare, privilegiando la ricerca del movimento al movimento della ricerca. Il movimento, inteso come spostamento del corpo nello spazio scenico, che porta con sé l’incerto, ma non l’ignoto e il mistero, e ancor meno la poesia. Il movimento somiglia ad una stasi e genera una situazione labirintica. Dico subito che lo spettacolo ha il merito di suggerire una distinzione tra significato e senso. La produzione di significato sta in un determinato movimento o in una determinata azione fisica: per esempio lo sfondamento di una parete nera. Mentre la produzione di senso scaturisce da una sequenza preordinata di movimenti o di azioni fisiche poste: entrata/uscita, nascita/morte, apertura/sepoltura. Il senso fiorisce dalla combinazione dell’errore della nascita con l’orrore della morte: viene generato dal passaggio da una condizione all’altra, dalla cancellatura (biffures) e dalla biforcazione (bifurs). Apprezzabile anche il lavoro sul frammento drammaturgico e sulla scrittura scenica come arte combinatoria di materiali linguistici prodotti e selezionati attraverso il lavoro collettivo, non facile, che non tiene conto però della chimica dei codici espressivi di diversa natura. Degna di attenzione è apparsa inoltre la leggerezza e l’ironia che attraversa tutto lo spettacolo nonostante i funerali che vengono messi in campo».
Alfio Petrini, amnesiavivace.it
Vangando la terra del teatro.
«A Primavera dei Teatri […] c’era spazio anche per una sana e legittima leggerezza […] con le giocose geometrie surreali dei quattro giovani performer del gruppo fiorentino Teatro Sotterraneo».
Sara Chiappori, Diario
«Il Re è morto, viva il Re. Tutto muore proprio perché è vivo. Il messaggio è di speranza, verde e positivo, fresco come i four fabulos (+ uno). Ogni cosa si spezza, si sciupa, si sporca, si rompe, finisce, si sgonfia. E’ la vita che è morte o è la morte che non esiste senza vita. Anzi la morte è paradossalmente il punto, l’ultimo, l’estremo, della vita. La parola fine del romanzo che comunque occupa, ha un posto ben definito nell’ultima pagina. L’ultima creazione, perché di questo si tratta, non performance né piece né spettacolo né show ma idea e progetto messo in essere, dei Sotterraneo, Post-it, veleggia sullo sdrucciolevole impianto concettuale della fine spruzzato di leggera, velata e soffice ironia. Il terreno è pericoloso, per contenuto e per scelta stilistica, ma il collettivo fiorentino riesce con equilibrio da surfisti a destreggiarsi con cura, a rimanere, ritmati e felicemente scanditi, appesi al filo del gioco strutturato in caselle cesellate di trame ed orditi ben confezionati ed al contempo semplici e diretti. Il filtro è talmente ricamato da pizzi espressivi che finisce per risultare trasparente, carta velina, un “pizzino” che ci instrada senza strizzate d’occhio. C’è la materia e c’è il sogno, spot da metafisica dechirichiana ed un continuo gioco sotteso instaurato tra pubblico e attori sulla lama scivolosa in bilico tra verità ed inganno svelato, tra le falsità vere e le realtà montate ad arte. La scena è una sezione di cubo, quella del logo, vivisezionata da imeni e sottili aperture, tagli alla Fontana. E’ il divenire e la trasformazione, in uno scorrimento rapido di vuoti e pieni, di dentro e fuori, di entrate ed uscite in coreografie sincronizzate, di pezzi e spezzoni, di teste e corpi, di scissioni e dimenticanze. Una messinscena saldamente politica, e frustante, quando, esilarante e grottesco, scuola Kinkaleri e frammenti di Sagna, un corpo dietro le quinte viene dilaniato da una bomba a mano – segno dei tempi – tic tac della modernità. Frattaglie ed interiora, Iraq, Afghanistan o Palestina, volano sul pavimento mentre con cadenza tutta burocratico militaresca e rassicurante, impasto guerreggiante e televisivo, politicamente corretto, convincente ed equidistante, si camuffa la morte, che di per sé è semplice e pulita, con mille nuvole alchemiche dialettiche e menzognere. Si continua a ridere di gusto con la gag del morto che imbecca il discorso di commiato ad un parente piangente come suggeritore nella buca teatrale nella finzione della rappresentazione rituale. Tutto è rifiuto, tutto è destinato a finire. Quindi a continuare».
Tommaso Chimenti, scanner.it
Post-it: appunti per uno spettacolo. «Un’ora succulenta di “visual theater” contemporaneo da gustare tutto d’uno fiato: un morso di humor sul momento, un messaggio lanciato e strappato subito dopo, che non si incolla né mette radici: il pubblico sorride e gradisce. Post-it, metafora incellophanata di un quotidiano straniante e occultante, figlio della fugacità postmoderna, è il progetto che Teatro Sotterraneo (quintetto di ricerca teatrale) ha presentato nei giorni scorsi alla Limonaia di Sesto Fiorentino […]. Sommo protagonista è lo spazio, nero e delimitato da teli penetrabili dove i corpi in movimento […] sono mezzo, verbo e volume dell’espressività scenica. Il box-palco è un’incubatrice sperimentale abitata da personaggi, che un po’ recitano se stessi e un po’ si fanno voci di un coro unanime, sottraendosi e mai svelandosi fino in fondo (mezzi busti, una gamba, un pezzo di braccio, discorsi interrotti) senza conoscere un compimento. Gli oggetti, numerosi in scena, partecipano al quadro scenico-materico – sembra di essere nell’Arbeitstish di Daniel Spoerri […]. Si impacchetta per poi togliere carta e imballaggi, in una non curante rimozione placida che si fa assurdo comico. Si sdrammatizza su tutto mentre sono in corso sul palco dei lavori di manutenzione: funerali, interiora che sanguinano sul pavimento, un processo alle trame del cinema, alla pubblicità e alla telefonia. Tutto sembra non toccare i giovani big Sotterranei, di nome ma non di fatto, che anche stavolta se la cavano alla grande senza sforzi per emergere: la realtà, al solito, è fonte d’ispirazione, nella sua eterna crociata al consumo, spreco e disuso, spremuta fino all’eccesso, imbalsamata e poi riportata all’uso. Il risultato è un fermo-immagine di sketch spontanei dove la parola è solo un vezzo. Anche sul finale sottovuoto si lascia correre: del cellophane e del suo cadavere si fa tutto un monte. Apologia dell’assenza o dello straniamento provocato da essa? Entrambi».
Miriam Monteleone, eartmagazine.com
«Non è facile parlare di uno spettacolo come Post-it riuscendo a sfuggire al tranello di svelarne i trucchi e quindi di rovinare la sorpresa. Lo si potrebbe definire un lavoro sul compimento mancato, sulle convenzioni ribaltate entro una cornice di teli neri, attraverso i quali è comunque possibile fare breccia. […]Lo spettatore è costantemente chiamato in causa nel ripensare alla quotidiana eventualità di voler fare tutto e non combinare niente. Si ride degli attori, ma ancor più di se stessi. Talvolta, nella vita, si vorrebbe sperimentare un evento nel suo momento migliore, prima che il divertimento scemi nella noia. Post-it si ferma ancora prima che l’esperienza possa avere luogo, alla fase preparatoria, proprio quella che genera più aspettative e che sovente procura maggiore gioia rispetto al suo stesso compimento. Gli eventi rappresentati sono in realtà azioni che di per sé non hanno niente di straordinario, ma la loro eccezionalità consiste nell’intempestiva impossibilità di realizzarli, non importa perché. È come se dovessimo ricordarci di portarla a termine, quella cosa incompleta, e lo facciamo con un post-it, il bigliettino perennemente attaccato sul frigo o lasciato in giro per rammentare a qualcun altro un compito che forse non verrà mai eseguito. Deridendo le abitudini, le frasi di circostanza, l’ovvietà delle reazioni a un’azione, Teatro Sotterraneo scombussola i confini del teatro quotidiano. Non si sa come va a finire quando invece, solitamente, l’esito è palese o, al contrario, si sa troppo quando si preferirebbe di no. È un susseguirsi di gag volutamente prive di narrazione consequenziale, lampi di genio comico che si vorrebbe non si esaurissero mai. Eppure per definizione anche lo spettacolo prima o poi deve arrivare a una conclusione, ma probabilmente ne scriveremo il titolo su un foglietto, per non scordare di consigliarlo agli amici».
Giulia Galvan, Vicenza Più
«Post-it, un lavoro audace e di appuntito humor noir sul tema della morte […], imprigionato in uno cubo foderato di nero ma rivestito di stoffa penetrabile che consentiva l’ingresso e l’uscita dalla scena come da una dimensione d’oltre, è un lavoro che parte proprio dall’idea della morte che tutto avvolge. Rifacendosi esplicitamente alle installazioni di Christo e di sua moglie, Jean-Claude, gli artisti che impacchettavano il reale, dalle case ai grattacieli, che lo avvolgevano nel domopack, come fosse in vendita in uno scaffale di supermercato, in Post-it il giovane collettivo artistico toscano […] lavora sul visibile e sull’invisibile, sull’essere e il non, con un’ironia e un acume che di rado si incontra. È più che spiegabile il successo di critica e pubblico che questo spettacolo ha riscosso, fatto di simboli chiari, ma che alludono poi in forma trasversale anche al sotterraneo della coscienza. Citazioni puntiformi da cinema e teatro, silenziose e pungenti […]. Questo gruppo, ad ogni buon conto, dietro l’apparenza fresca, nasconde una volontà di studio e addensamento dell’idea di rara potenza, con un linguaggio in evoluzione che va incoraggiato in forma piena».
Renzo Francabandera, aprileonline.info
«Un volume cubico nero ad uso contenitore da cui far uscire uomini-corpi dotati di molle. Entrano ed escono da tagli sulla tela nera, come in uscita e in entrata da situazioni futili. Tagli da cui emergere con un braccio sulla quinta di sinistra e la gamba su quella di destra. Spezzoni di corpi. Perennemente in movimento. Ritmi sincronizzati per gesti dispettosi. Un minipix da cucina che frulla il pacchetto regalo portato in dono. Una bomba a mano lanciata dentro il taglio della stoffa, da cui escono frattaglie di carne sanguinolente ad effetto horror. “Buonasera” dice un’imperterrita voce umana: “… situazione delicata… la prognosi è riservata… la permanenza del problema motorio, ..natura lesiva del trauma, … percentuale del settantasette per cento di guarigione”. Sono post.it di frammenti verbali, schegge di un discorso che inizia e finisce come un cerchio che ruota su se stesso. Parole e gesti compulsati da sequele d’azioni d’uso quotidiano, stereotipate. Talmente tanto da apparire senza senso. Eppure così vere e banali nella loro serialità. Post.it è in realtà un funerale alle banalità che si sprecano ogni giorno. Prima entra un uomo che piange, poi il morto che si distende per terra. “Regia funebre, elegia funebre- un epiteto di subitanea agape…” Un linguaggio che si ingarbuglia, raffiche di parole che si sbriciolano. Versi gutturali quasi animali. Sembrano scene di disperazione, ma il morto si alza e lascia il posto ad un altro. Sono i quattro performer Sara Bonaventura, Iacopo Braca, Matteo Ceccarelli, Claudio Cirri, a sostenere a ritmi vertiginosi, incalzanti, dotati di una tempistica precisa al millimetro. Personaggi un po’ beckettiani. Sanno fare di tutto, costruire e distruggere. Impachettano oggetti per poi scartarli e distruggerli. Prima le monete nel salvadanaio e poi un colpo di martello manda in frantumi. Sono post.it che volano e si sparpagliano. Non è così la nostra società frenetica? Le comunicazioni che durano il tempo di un attimo? Non siamo noi tutti dei post.it che si usano e gettano via ? E quando uno dei quattro protagonisti finisce sotto un telo di plastica trasparente con le gocce di un psicofarmaco in mano, ti sembra che la nostra vita non è altro che una bolla d’aria che svanisce presto. Sparisce tutto dietro il fondale nero e per finire si fotografano in gruppo con l’autoscatto. Senza di loro però. La scrittura drammaturgica sottolinea alla perfezione le contraddizioni di una società consumistica, a rischio di disordine mentale, caotica e superficiale. Il lavoro risulta efficace per innovazione del linguaggio e originalità nel cogliere le situazioni paradossali del nostro tempo e trasformarle in un sapiente e calibrato gioco di specchi riflettenti».
Roberto Rinaldi, teatro.org
UNO - IL CORPO DEL CONDANNATO
«I Sotterraneo migliorano come il vino in cantina. Dall’iniziale 5 per una a 11/10 in apnea passando per 100° C: cose di Andersen fino al Tilt di Intercity Toronto, il gruppo fiorentino, (classe ’81-’82) meglio chiamarli “collettivo”, formato da giovani attori usciti da scuole come il Laboratorio Nove, è divenuto a ragione una delle realtà più vive e creative della nuova drammaturgia. Difficili e complessi, ma anche evocativi e spiazzanti. Ti tengono incollati alla poltrona di velluto rosso. Intelligenti e fini, arguti. Sempre sorprendenti con trovate felici sintomo di ricchezza interiore e simbolo di una esigenza-emergenza ad uscire all’aperto. Adesso hanno fatto outing di consapevolezza artistica e non si possono più nascondere. Mezz’ora di energia ed emozioni. In una tenda rotonda s’agita il microcosmo del prigioniero. Dentro c’è tutto e manca tutto. Una tenda da doccia opaca, (l’Hitchcook di Psycho?) che fa vedere il fuori ma lo distorce, sgravandone i contorni, quasi un igloo o una canadese, tenda tibetana o indiana. Fumoso cerchio ovattato. Sotto si svolge la vita come messa sotto osservazione, liturgia rituale sotto al vetrino del microscopio. In una gabbia allo zoo. Ed in questo Uno proposto allo Zoom Festival 2006 (solo Iacopo Braca in scena, bravissimo, stavolta non “schiacciato” dai colleghi istrionici Claudio Cirri e Matteo Ceccarelli) viene fuori tutta la poetica e le dinamiche dei Sotterraneo: un teatro vero e stilisticamente asciutto, “sporco” di lucide emozioni che arrivano come lame affilate in corto circuiti, sudato e denso, ansante e duro, graffiante e muscolare, fisico fino all’essenza della fisicità che non sta nel gesto ma nella sua sublimazione, nell’immobilismo. La condanna arriva in egual misura sul corpo e sulla mente. Braca parla con gli “amici” impiccati: un toast, le sigarette, un pennarello, un cucciolo di peluche, la dolcezza che viene estromessa, spostata di lato, messa alla porta. Perché dentro c’è violenza. E’ violenza continua. Tutti presi all’amo nella grande vasca di pesci rossi al Luna Park. La spugna, come gli occhiali da sole da duro policeman, finisce in bocca ed il condannato vorrebbe parlare ma nessuno lo capisce, ha urla rattrappite che muoiono in gola, se ne sta con il cappuccio sugli occhi come il gobbo di Nostre Dame perché non c’è niente da vedere. Tutto è falso o meglio falsato, irreale, virtuale nei movimenti da Frankenstein, da dead man walking. Il tendone da circo lo cinge e lo protegge come una medusa dai lunghi tentacoli. Il morto che respira spara con l’annaffiatoio fino al ripercorrere all’indietro in una fast motion tutta la piece, tutta la vita. Che si ripete, che si ripete, che si ripete. Per ricordarsi di dover vivere. O soltanto sopravvivere».
Tommaso Chimenti, www.scanner.it
11/10 IN APNEA
Motivazioni della giuria del Premio Scenario 2005
«Di altra cifra – segnato da un sottile disagio esistenziale – il brillante lavoro della fiorentina Compagnia Teatro Sotterraneo: anche qui un interno, forse un bunker, o una comune di un qualche centro sociale, o ancora una stanza di una casa di studenti molto disagiata. Quattro giovanissimi, alle prese con follie verbali e tentativi di suicidio, depressioni e ansie di fuga, bisogni fisici e desideri frustrati. 11/10 in apnea è un gioco d’equilibrio, tenuto da un ritmo vorticoso e da una scrittura felice, da una interpretazione disinvolta di tutti i giovani attori e da alcune trovate davvero originali. Quasi un “Paravidino nevrotico”, verrebbe da dire di questo lavoro, molto contemporaneo e molto incisivo curato con garbo da Sara Bonaventura, Iacopo Braca, Matteo Ceccarelli, Claudio Cirri e Daniele Villa».
Andrea Porcheddu, www.delteatro.it
«Di tutt’altro stile 11/10 in apnea, della Compagnia Teatro Sotterraneo di Firenze, un lavoro brillante, fra i più originali visti in questa edizione del Premio Scenario, che indica nella sua perfetta sintonia la metodologia di lavoro collettivo dei sei giovanissimi componenti del gruppo, segno di una generazione che sente forte il bisogno di una comunicazione, della possibilità di esperienze e azioni comuni. Ambientato in un interno, forse una comune, il lavoro della compagnia fiorentina, solcato da un profondo disagio esistenziale, mostra quattro ragazzi alle prese con monomanie individuali, schegge di follia collettiva, tentativi di suicidio di gruppo che assumono l’apparenza di un balletto allucinato e poetico, ansie di fuga e desideri frustrati. I primi trenta minuti dello spettacolo sono segnati da un ritmo vorticoso, perfetto, e da una scrittura drammaturgica felice e originale».
Altre scene 05 – lampi di teatro e danza, www.ateatro.it
«Un uso diverso e fresco della parola lo fanno i fiorentini del Teatro Sotterraneo in 11/10 in apnea, che scavalcano il livello del significato per divertirsi a giocare con il ritmo. Questi giovanissimi creano, attraverso un dialogo serratissimo e una partitura fisica impeccabile, una situazione alla Beckett molto incalzante. Il lavoro è intessuto di una grande ironia, gusto dell’assurdo e attenzione per la ritmica. In molti di questi spettacoli si tenta di dare voce a un disagio, di puntare il dito contro le discriminazioni e le ingiustizie di un sistema che fa rimanere ossessivamente chiusi in casa, come in 11/10 in apnea, o che si vorrebbe cambiare».
Giorgia Sinicorni, Il Giornale del festival di Sant’Arcangelo, 2005
«La Compagnia Teatro Sotterraneo (Firenze) con 11/10 in apnea distrugge l’unità dello spazio scenico tradizionale strutturando nuovi percorsi, altri ritmi all’azione scenica accostando visioni di un immaginario privato a materiali d’uso riciclati e assemblati un po’ alla maniera di Kantor, in una oggettualità che richiama Beuys».
Giuseppe Liotta, www.associazionescenario.it
«11/10 in apnea, curioso bonsai firmato Teatro Sotterraeno che richiama la poetica di Paravidino. In una sala sgangherata una manciata di giovani aspettano Godot parlando della vita attraverso una lingua contemporanea e tratti farcita di volgarità. Poi l’epilogo, un tentativo di suicidio di massa (davvero ben calibrati i quadri, sorretti da una dinamismo raffinato) per sconfiggere la routine».
Andrea Carli, La voce di Romagna
«Tre ragazzi in una specie di stanza-scantinato. Non vi sono rinchiusi e non ci vivono. Questa casa, come la loro esistenza, è precaria. Non va meglio nel mondo ‘fuori’. 11/10 in apnea è un congegno perfettamente fissato, fatto da una compagnia giovane che si forma, si auto-produce, si auto-organizza e riesce, nel pur desolante panorama, a girare con i suoi progetti».
Antonella Lamparelli, www.flashteatro.it

 English
English